1. Dimenticanza di nomi propri |
|
Nel 1898 ho pubblicato, sulla «Monatsschrift für Phsychiatrie und Neurologie», un breve articolo intitolato «Il meccanismo psichico della dimenticanza» il cui contenuto, che ora riassumerò, mi servirà come punto di partenza per le mie considerazioni ulteriori. In questo articolo sottomettevo all'analisi psicologica, prendendo lo spunto da un caso sorprendente osservato su me stesso, il fenomeno tanto frequente della dimenticanza passeggera di nomi propri; sono arrivato alla conclusione che il fenomeno - tanto comune e abbastanza irrilevante nella pratica - consistente nel momentaneo blocco di una facoltà psichica (la memoria), può ricevere una spiegazione la cui portata va molto al di là dell'importanza generalmente accordata a tale fenomeno. Se si chiedesse ad uno psicologo come mai ci si trova tanto spesso nell'impossibilità di ricordarsi un nome proprio, che pur si è certi di conoscere, probabilmente questi si limiterebbe a rispondere che la memoria è più labile per questo genere di nomi che per gli altri suoi contenuti; addurrebbe ragioni, più o meno plausibili, che, secondo lui, sarebbero in grado di giustificare questa caratteristica dei nomi propri, senza supporre che questo processo possa essere sottomesso ad altre condizioni, di ordine più generale. Sono stato spinto ad occuparmi a fondo del fenomeno della momentanea dimenticanza di nomi propri dall'osservazione di. certi particolari, assenti in alcuni casi, ma molto precisi in altri: non si tratta, allora, di semplice dimenticanza, ma anche di falso ricordo. Chi cerca di richiamare alla mente un nome che gli sfugge ritrova nella propria coscienza altri nomi, sostitutivi, la cui falsità egli riconosce immediatamente, ma che tuttavia continuano ostinatamente ad imporglisi. E' come se il processo che dovrebbe portare alla riproduzione del nome abbia subito uno spostamento, abbia imboccato una strada sbagliata, alla fine della quale si ritrova il nome sostitutivo, scorretto. Ed io ritengo che tale spostamento non derivi da un'azione psichica arbitraria, ma si effettui secondo determinati modi prestabiliti e pertanto prevedibili. In altre parole, io ritengo che tra il nome sostitutivo e quello ricercato ci sia un nesso ben determinato, che spero di riuscire ad identificare, in modo da chiarire il processo della dimenticanza dei nomi propri. Nel caso che ho analizzato nel 1898, il nome che io mi sforzavo invano di ricordare era quello dell'artista cui si devono i magnifici affreschi rappresentanti il «Giudizio Universale» che si trovano nel Duomo di Orvieto. Invece del nome esatto, Signorelli, mi erano venuti in mente i nomi di altri due pittori, Botticelli e Boltraffio, rendendomi immediatamente conto, con assoluta certezza, che non erano quelli esatti. Ma non appena il nome corretto mi fu comunicato da un'altra persona, lo riconobbi senza un attimo di esitazione. L'analisi degli influssi e delle associazioni che mi avevano portato alla riproduzione dei nomi Botticelli e Boltraffio, anziché Signorelli, portò ai seguenti risultati: a. Il motivo della dimenticanza del nome Signorelli non va ricercato né in una qualche sua particolarità, né in un carattere psicologico del contesto in cui era inserito. Il nome dimenticato mi era altrettanto familiare di uno di quelli sostitutivi, Botticelli, e di gran lunga più di quello di Boltraffio, di cui sapevo solo che fa parte della scuola milanese. Le circostanze nelle quali si era verificata la dimenticanza, poi, mi sembravano innocue e non tali, certo, da fornirmi alcun chiarimento: stavo facendo, in compagnia di un estraneo, un viaggio in carrozza da Ragusa, in Dalmazia, ad una località dell'Herzegovina [Erzegovina]; durante il tragitto, la conversazione cadde sull'Italia ed io chiesi al mio compagno di viaggio se era stato in Italia e se aveva visto i celebri affreschi di... b. La dimenticanza dei nomi si spiega se io considero l'argomento immediatamente precedente di quella conversazione; allora la dimenticanza si presenta come perturbazione del nuovo argomento ad opera del precedente. Poco prima che io chiedessi al mio compagno di viaggio se era stato ad Orvieto, avevamo parlato delle usanze dei Turchi che abitano la Bosnia e l’Herzegovina. Avevo riferito al mio interlocutore quanto mi aveva raccontato un collega che esercita la sua professione tra quella gente, cioè che sono persone ricolme di fiducia nei confronti del loro medico e pieni di rassegnazione di fronte alla sorte. Quando è costretto ad annunciare che la malattia di un loro parente è molto grave, essi rispondono: «Herr [Signore], non ne parliamo. Io sono certo che, se sarà possibile salvare il malato, tu lo salverai». A questo punto abbiamo i due nomi Bosnia e Herzegovina e la parola Herr, che è possibile inserire in una serie di associazioni tra Signorelli, Botticelli e Boltraffio. c. Ritengo che l'associazione di idee riguardanti le usanze dei Turchi della Bosnia, ecc., sia stata tanto potente da disturbare un pensiero successivo in quanto io ne avevo distolto l'attenzione prima di averla portata a termine. Ricordo chiaramente che avevo pensato di raccontare un altro aneddoto, molto vicino, nella mia memoria, al primo. Questi Turchi attribuiscono uno straordinario valore ai piaceri erotici e quando accusano disturbi della funzione sessuale sono presi da una disperazione che contrasta singolarmente con la loro rassegnazione di fronte alla morte. Un giorno, un paziente del mio collega gli disse: «Tu capisci bene, Herr, che quando non si può più fare quella cosa, la vita non ha più valore». Poi, però, avevo preferito astenermi dal comunicare questo aspetto caratteristico, dato che non mi pareva il caso di affrontare questo scabroso argomento nella conversazione con un estraneo. Ma feci di più: distolsi la mia attenzione dall'associazione di idee che avrebbero potuto trovarsi in un qualche nesso, nella mia mente, con l'argomento «Morte e Sessualità». Risentivo ancora, in quei giorni, dell'impressione provocata in me da un avvenimento di cui avevo avuto notizia, qualche settimana prima, durante un breve soggiorno a Trafoi: un malato, per cui mi ero dato molto da fare, si era suicidato perché soffriva di un incurabile disturbo sessuale. So perfettamente che questo triste avvenimento e tutti i particolari connessi non erano affatto presenti in me, durante il mio viaggio in Herzegovina, allo stato di ricordo cosciente. Tuttavia, l'affinità tra Trafoi e Boltraffio mi costringe a pensare che, nonostante la distrazione intenzionale, io subivo l'influsso di questa reminiscenza. d. A questo punto non posso più considerare la dimenticanza del nome Signorelli come un fatto incidentale. Sono costretto ad ammettere l'influenza di un motivo in questo fenomeno. Per ragioni di ordine psichico mi sono interrotto nei miei racconti (sulle usanze dei Turchi, ecc.), e per ragioni di ordine psichico ho evitato che nella mia coscienza penetrassero le idee che vi si associano e che mi avrebbero infine portato a parlare della notizia che avevo ricevuto a Trafoi. Dunque, io volevo dimenticare qualcosa; ho rimosso qualcosa. Naturalmente ciò che volevo dimenticare non era il nome dell'artista di Orvieto; ma tra questa «altra cosa» ed il nome si era stabilito un nesso associativo, dimodoché il mio atto di volontà ha fallito il suo scopo ed io ho, involontariamente, dimenticato il nome, mentre volevo intenzionalmente dimenticare l'«altra cosa». Il desiderio di non ricordare riguardava un certo contenuto; l'impossibilità di ricordare si è manifestata nei confronti di un altro. Questo caso sarebbe evidentemente molto più semplice se il desiderio di non ricordare e l'impossibilità della memoria si fossero collegati allo stesso contenuto. D'altra parte, i nomi sostitutivi non mi sembrano più così ingiustificati come prima della spiegazione; essi mi richiamano alla mente (per una specie di compromesso) sia ciò che ho dimenticato sia ciò che avrei voluto dimenticare, e rendono evidente come la mia intenzione di dimenticare qualcosa non sia né totalmente riuscita, né totalmente fallita. e. Il genere di associazione che si è stabilito tra il nome ricercato e l'argomento rimosso (relativo alla morte ed alla sessualità e nel quale figurano i nomi Bosnia, Herzegovina, Trafoi) è veramente singolare. 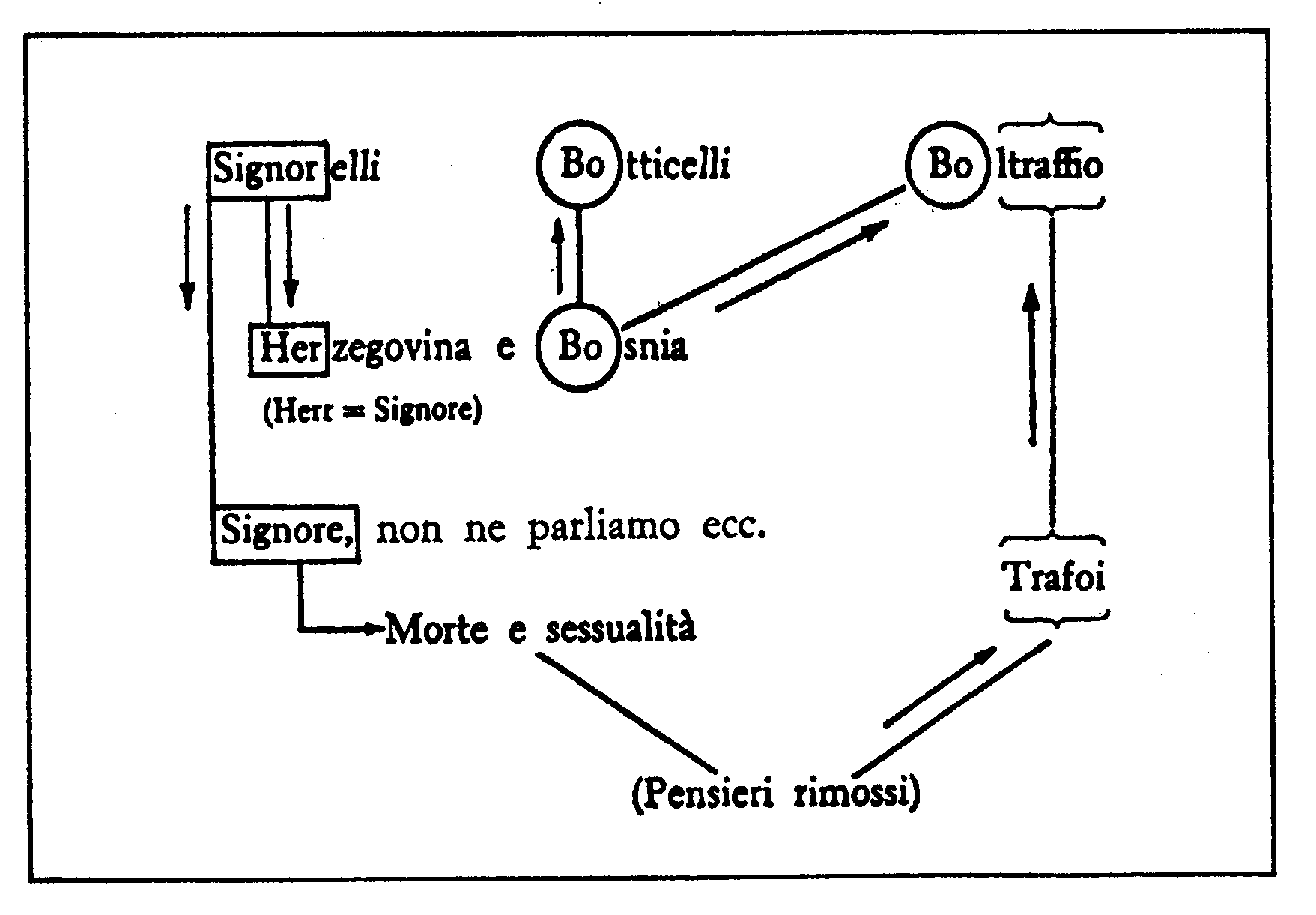 Lo schema, ripreso dal mio articolo del 1898, cerca di dare una rappresentazione concreta di questa associazione. Il nome Signorelli è stato scomposto in due parti [Signorelli]; le due ultime sillabe [elli] si ritrovano tali e quali in uno dei due nomi sostitutivi, le prime due hanno contratto, mediante la traduzione di Signor in Herr, numerosi e svariati rapporti con i nomi contenuti nell'argomento rimosso, il che ha reso impossibile riprodurli. La sostituzione di Signor è avvenuta come per uno spostamento tra i nomi connessi «Herzegovina - Bosnia», senza riguardo per il significato né per la delimitazione acustica delle sillabe. Si ha l'impressione che in questo processo i nomi siano stati trattati in maniera analoga agli ideogrammi di una frase da trasformare in rebus. La coscienza non si è affatto resa conto di questo processo in seguito al quale il nome Signorelli è stato sostituito da altri. E, a prima vista, il solo rapporto che si scopre tra l'argomento di conversazione in cui appariva il nome Signorelli e l'argomento che lo precedeva è costituito dalla somiglianza delle sillabe (o piuttosto delle successioni di lettere) in entrambi i casi. Non credo sia superfluo fare osservare che la mia spiegazione non contraddice le condizioni necessarie, secondo gli psicologi, per la riproduzione e la dimenticanza, e quali essi ricercano in certe relazioni e nostre disposizioni, lo mi limito ad aggiungere, per certi casi, un motivo a quei fattori, da tempo ammessi, che possono determinare la dimenticanza di un nome; inoltre, ho illustrato il meccanismo del falso ricordo. Nel nostro caso quei fattori hanno senz'altro avuto una parte nel permettere all'elemento rimosso di impadronirsi, attraverso 1 associazione, del nome ricercato e di portarlo con sé nella rimozione. Forse, a proposito di un altro nome, che presentasse condizioni di riproduzione più favorevoli, questo fenomeno non si sarebbe verificato. E' comunque verosimile che un elemento rimosso cerchi sempre ed in tutti i casi di manifestarsi all'esterno: tuttavia riesce a farlo solo in presenza di condizioni particolari e appropriate. In alcuni casi, la rimozione si verifica senza disturbi funzionali, o, possiamo dire, senza sintomi. In conclusione, le condizioni necessarie perché si verifichi la dimenticanza di un nome con falsa reminiscenza sono le seguenti: 1. una certa disposizione a dimenticare questo nome; 2. un processo di repressione verificatosi poco prima; 3. la possibilità di stabilire un'associazione esteriore tra questo nome e l'elemento represso prima. Penso che non si debba esagerare l'importanza di questa ultima condizione, perché, data la facilità con cui si formano le associazioni, sarà piuttosto agevole adempiervi. Un altro problema, più importante, è quello di sapere se una associazione esteriore di questo tipo costituisce realmente una condizione sufficiente perché l'elemento rimosso disturbi la riproduzione del nome ricercato e se non sia invece necessario, a questo scopo, un più intimo legame tra i due argomenti. In un primo momento si sarebbe tentati di negare quest'ultima necessità e di ritenere sufficiente la passeggera contiguità temporale di due elementi senza relazione tra loro. Ma ad un esame più approfondito si osserva, con sempre maggior frequenza, che i due elementi (quello rimosso ed il nuovo) collegati da un'associazione esteriore, hanno inoltre un nesso nel contenuto, il che avveniva anche, in effetti, nell'esempio Signorelli. La conclusione che deriva dall'analisi dell'esempio Signorelli ha un diverso valore, a seconda che si consideri questo caso come tipico o, invece, come un fenomeno isolato. E io ritengo di poter affermare che la dimenticanza di nomi con falsa reminiscenza si verifichi, per lo più, nello stesso modo che nel caso descritto. Quasi sempre, osservando questo fenomeno su me stesso, sono stato in grado di spiegarlo come nel caso Signorelli, cioè come motivato da rimozione. D'altra parte, c'è anche un altro argomento che posso addurre come riprova della natura tipica della nostra analisi. Io non credo che si possa tracciare una netta linea di demarcazione tra i casi di dimenticanza di nomi propri con falsa reminiscenza e quelli in cui non appaiono nomi sostitutivi scorretti. In alcuni casi questi si presentano spontaneamente; in altri, è possibile provocarli con uno sforzo dell'attenzione, ed allora essi presentano gli stessi rapporti con l'elemento rimosso ed il nome ricercato che se fossero sorti spontaneamente. Perché il nome sostitutivo divenga cosciente è anzitutto necessario uno sforzo dell'attenzione, ed inoltre la presenza di una condizione interiore connessa col materiale psichico. Secondo me, quest'ultima condizione consiste nella maggiore o minore facilità con cui si stabilisce la necessaria relazione interiore tra i due elementi. Così, una buona parte dei casi di dimenticanza di nomi senza falsa reminiscenza, viene ad aggiungersi ai casi con formazione di nomi sostitutivi, e vale allora il meccanismo dell'esempio Signorelli. Non voglio dire, naturalmente, che tutti i casi di dimenticanza di nomi debbano rientrare in una di queste categorie. Indubbiamente, altri casi presentano un meccanismo molto più semplice. E insomma, non usciamo dai limiti della prudenza se riassumiamo la situazione in questo modo: accanto alla semplice dimenticanza di un nome proprio, vi sono casi in cui questa è determinata da rimozione. |