Minute teoriche per Wilhelm Fliess1891-1897 |
Minuta A1892Problemi 1. L'angoscia, nelle nevrosi d'angoscia,2 nasce dall'inibizione della funzione sessuale 0 dall'angoscia collegata con la loro etiologia? 2. In che misura reagisce in modo diverso, agli ulteriori traumi sessuali, una persona sana da una persona avente una predisposizione dovuta alla masturbazione? Solo quantitativamente? 0 qualitativamente? 3. Il semplice coitus reservatus (condom) costituisce in genere una pratica nociva?3 4. Esiste una nevrastenia congenita con congenita debolezza sessuale, oppure essa è sempre acquisita durante la giovinezza? (bambinaie, masturbazione da parte di altra persona). 5. È l'eredità qualcosa di diverso da un moltiplicatore?4 6. Quali sono le componenti dell'etiologia della depressione periodica? 7. La frigidità sessuale della donna è qualcos'altro che una conseguenza dell'impotenza? Può causare per sé stessa una nevrosi?
Tesi 1. Non esiste nevrastenia o nevrosi analoga senza un disturbo nella funzione sessuale. 2 Tale disturbo ha un immediato effetto causale o agisce come predisposizione per altri fattori, ma sempre in modo che, senza di esso, gli altri fattori non provocano la nevrastenia. 3. A causa della sua etiologia, la nevrastenia, negli uomini, è accompagnata da una relativa impotenza. 4. La nevrastenia nelle donne è conseguenza diretta della nevrastenia negli uomini, tramite questa riduzione della loro potenza. 5. La depressione periodica è una forma di nevrosi d'angoscia che, altrimenti, si manifesta sotto forma di fobie o di attacchi d'angoscia. 6. La nevrosi d'angoscia è, in parte, una conseguenza dell'inibizione della funzione sessuale. 7. Semplici eccessi e sovraffaticamento non sono fattori etiologici.1 8. L'isteria, nelle nevrosi nevrasteniche, indica una repressione degli affetti concomitanti.
Serie 1. Di uomini e donne che sono rimasti sani. 2. Di donne sterili nelle quali mancano fatti traumatici preventivi nel matrimonio. 3. Di donne affette da gonorrea. 4. Di uomini di mondo affetti da gonorrea che, per tale ragione, hanno evitato i contatti e hanno coscienza della loro ipospermia. 5. Di individui, membri di famiglie gravemente affette, che sono rimasti sani. 6. Osservazioni provenienti da luoghi in cui certe anormalità sessuali sono endemiche.
Fattori etnologici 1. Esaurimento dovuto ad anormale soddisfacimento. 2. Inibizione della funzione sessuale. 3. Affetti che accompagnano tali pratiche. 4. Traumi sessuali prima dell'età della ragione. Minuta BL'etiologia delle nevrosi1893Trascrivo tutto quanto, caro amico, per te e per il nostro comune lavoro per la seconda volta. Naturalmente terrai il manoscritto lontano dalla tua giovane moglie. Che la nevrastenia sia una conseguenza frequente di un'anormale vita sessuale, si può considerare cosa nota a tutti. Vorrei però sostenere e provare sperimentalmente la tesi che la nevrastenia è sempre soltanto una nevrosi sessuale. Insieme con Breuer, ho adottato un punto di vista simile relativamente all'isteria. L'isteria traumatica era nota. Dicemmo, allora: ogni isteria che non è ereditaria, è traumatica. Allo stesso modo ora io affermo della nevrastenia: ogni nevrastenia è sessuale. Per il momento lasciamo da parte la questione se la disposizione ereditaria e, secondariamente, certe influenze tossiche possano generare una vera nevrastenia, 0 se ciò che sembra essere nevrastenia ereditaria si richiami in realtà a un precedente esaurimento sessuale. Se esistono nevrastenie ereditarie, sorge il problema se lo status nervosus nei casi ereditari non debba distinguersi dalla nevrastenia, e quale relazione mai esso abbia con i corrispondenti sintomi dell'infanzia eccetera. Quindi, per cominciare, limitiamoci a discutere la nevrastenia acquisita. Ciò che io asserisco può essere formulato come" segue: nell'etiologia di una malattia nervosa noi possiamo distinguere 1) il necessario elemento condizionante, senza cui lo stato morboso non si verificherebbe affatto, e 2) i fattori occasionali. La relazione tra i due punti può essere intesa in questi termini: se il necessario elemento condizionante ha operato a sufficienza, l'affezione ne è una necessaria conseguenza; se invece non ha agito abbastanza, ne risulterà, in primo luogo, una predisposizione alla malattia, che cesserà di essere latente appena sarà presente una sufficiente quantità di uno dei fattori secondari. Cosicché tutto ciò che manca nell'etiologia primaria a produrre l'effetto completo, può venir sostituito dall'etiologia secondaria. Si può però fare a meno dell'etiologia secondaria, mentre la primaria è indispensabile. Se si applica questa formula etiologica al nostro caso attuale, arriviamo a quanto segue: l'esaurimento sessuale può di per sé stesso provocare la nevrastenia; se, tuttavia, non fosse abbastanza forte per realizzarla da solo, esso ha un effetto predisponente talmente grande sul sistema nervoso che la malattia fisica, affetti deprimenti e sovraffaticamento (influenze tossiche) non possono essere tollerati senza [incorrere nella] nevrastenia. Se non vi è esaurimento sessuale, tutti questi fattori sono invece incapaci di generare la nevrastenia; essi rendono il paziente normalmente stanco, normalmente triste, normalmente debole di corpo, ma testimoniano soltanto quanto "di queste dannose influenze un uomo sano può sopportare".2 Occupiamoci ora separatamente della nevrastenia degli uomini e delle donne. La nevrastenia degli uomini si acquisisce nell'età pubere e diviene manifesta attorno ai vent'anni. Trae origine dalla masturbazione, la frequenza della quale è perfettamente parallela alla frequenza della nevrastenia negli uomini.3 Si può costatare, nel circolo delle proprie conoscenze, che, almeno nella popolazione urbana, coloro i quali furono in giovane età sedotti dalle donne sfuggono alla nevrastenia. Quando la pratica nociva si protrae a lungo ed è intensa, essa trasforma il soggetto in un nevrastenico sessuale che ha subito danni anche nella sua potenza, mentre all'intensità della causa corrisponde la persistenza di tale condizione per tutta la vita. Un'ulteriore prova della connessione causale è costituita dal fatto che un nevrastenico sessuale è sempre nello stesso tempo un nevrastenico generale. Se l'azione nociva non è stata sufficientemente intensa, essa ha avuto, in accordo con la formula etiologica di cui sopra, un effetto predisponente a produrre, in seguito, la nevrastenia con il concorso di fattori provocanti, che da soli non avrebbero ottenuto quell'effetto. Lavoro intellettuale-cerebroastenia; normale attività sessuale-nevrastenia spinale, e via dicendo. Nei casi medi si riscontra la nevrastenia degli anni giovanili che, tipicamente, inizia e segue il suo corso accompagnata da dispepsia ecc., e che poi termina con il matrimonio. La seconda pratica nociva, che riguarda gli uomini a un'età più avanzata, colpisce o un sistema nervoso intatto oppure un sistema nervoso predisposto alla nevrastenia dalla masturbazione. Ci chiediamo se anche nel primo caso possano esservi delle conseguenze dannose; probabilmente si. Il suo effetto è evidente nel secondo caso, nel quale fa rivivere la nevrastenia della giovinezza e crea nuovi sintomi. Questa seconda pratica nociva è l'onanismus coniugalis, la copulazione incompleta per prevenire il concepimento. I diversi metodi impiegati a tale scopo sembrano tutti di uguale effetto sugli uomini; operano con diversa intensità a seconda della predisposizione del soggetto, ma qualitativamente non differiscono. Quando il soggetto ha una forte predisposizione o soffre di nevrastenia cronica, anche il coito normale non viene tollerato, e allora l'intolleranza reagisce contro il condom, il coito extra vaginale e il coitus interruptus. Un uomo sano tollera tutto ciò abbastanza a lungo, ma anch'egli non indefinitamente: dopo un certo tempo egli pure si comporta nello stesso modo del soggetto predisposto; il suo solo vantaggio sull'onanista è costituito da un periodo di latenza più lungo o dal fatto che ogni volta è necessario l'intervento di una causa determinante. Il coitus interruptus si dimostra qui la principale pratica nociva, che anche in soggetti non predisposti sortisce il suo effetto caratteristico. Nevrastenia delle donne. Di norma, le ragazze sono sane, non nevrasteniche. Lo stesso vale per le giovani spose, nonostante i traumi sessuali di questo periodo. La nevrastenia è rara, nelle sue forme pure, nelle donne sposate e nelle zitelle anziane, e quando esiste deve considerarsi come sorta spontaneamente e nella stessa maniera [che negli uomini]. Molto più spesso, la nevrastenia in una donna sposata deriva dalla nevrastenia dell'uomo, o si produce simultaneamente a essa. È allora quasi sempre mescolata all'isteria, e costituisce allora la comune nevrosi mista delle donne. La nevrosi mista delle donne deriva dalla nevrastenia degli uomini in tutti quei casi, non infrequenti, in cui l'uomo, essendo un nevrastenico sessuale, ha sofferto una perdita della sua potenza. La mescolanza di isteria è una conseguenza diretta dell'eccitamento trattenuto dell'atto. Minore è la potenza dell'uomo, maggiore è la preminenza dell'isteria della donna; cosi che un uomo sessualmente nevrastenico rende la propria moglie non tanto nevrastenica quanto isterici. Questa nevrosi insorge con la nevrastenia maschile quando si verifica la seconda pratica sessuale nociva, che per la donna, supponendola sana, ha di gran lunga il maggior peso. Cosi accade di incontrare molti più uomini nevrotici nel primo decennio dopo la pubertà e molte più donne nevrotiche nel secondo decennio. Questa è una conseguenza della pratica nociva di misure anticoncezionali. Non è facile disporre queste ultime in una successione, e in generale nessuna può essere considerata del tutto innocua alle donne, cosi che anche nel più favorevole dei casi (condom) le donne, che sono più sensibili degli uomini, raramente sfuggiranno a una leggera nevrastenia. Naturalmente molto dipenderà dalle due predisposizioni: 1) se la donna era nevrastenica prima del matrimonio, 2) se è stata resa isterico-nevrastenica nel periodo dei suoi liberi rapporti [senza misure anticoncezionali]. 2. Nevrosi d'angoscia Ogni caso di nevrastenia comporta, senza dubbio, un certo abbassamento della coscienza di sé, un'attesa pessimistica e un'inclinazione a penose rappresentazioni di contrasto. Ma vi è il problema se la preminenza di questo fattore [l'angoscia], senza che altri sintomi appaiano particolarmente sviluppati, debba separarsi come una specifica "nevrosi d'angoscia", soprattutto perché esso si riscontra con uguale frequenza sia nell'isteria che nella nevrastenia. La nevrosi d'angoscia si può manifestare sotto due forme: come stato cronico e come attacco d'angoscia. Le due forme possono facilmente combinarsi; l'attacco d'angoscia non appare mai senza i sintomi cronici. L'attacco d'angoscia si trova maggiormente in quelle forme di nevrosi d'angoscia che sono collegate con l'isteria, e quindi con maggior frequenza nelle donne. I sintomi cronici sono più frequenti nei maschi nevrastenici. I sintomi cronici sono: 1) angoscia relativa al corpo: ipocondria; 2) angoscia relativa alle prestazioni del corpo: agorafobia, claustrofobia, vertigine delle altezze; 3) angoscia relativa alle decisioni e alla memoria (cioè rappresentazioni bizzarre delle proprie capacità psichiche): folie du doute, rimuginare ossessivo ecc. Non ho mai trovato fondate ragioni per non considerare questi sintomi come equivalenti. Dobbiamo inoltre vedere 1) se questo stato si manifesta per ereditarietà, senza pratica sessuale nociva; 2) se, nei casi ereditari, esso viene scatenato da qualche pratica sessuale nociva; 3) se sopravviene quale intensificazione in una comune nevrastenia. Non c'è dubbio che esso viene acquisito, e precisamente, sia nei maschi che nelle femmine, nel matrimonio, durante il secondo periodo delle pratiche sessuali nocive, col coitus interruptus. Io penso che non sia necessaria una predisposizione dovuta a nevrastenia precedente; tuttavia, dove manca la predisposizione, vi è un più lungo periodo di latenza. Lo schema causale è quello della nevrastenia. I casi, relativamente più rari, di nevrosi d'angoscia fuori del matrimonio si riscontrano specialmente fra gli uomini. Essi hanno origine dal congressus interruptus, nei casi ove l'uomo è legato sentimentalmente ed è fortemente preoccupato per il benessere della donna, e questa pratica, in tali circostanze, è per l'uomo maggiormente nociva di quanto non sia il coitus interruptus nel matrimonio, che è spesso compensato da un coito normale extraconiugale. Devo considerare come una terza forma di nevrosi d'angoscia la depressione periodica, un attacco d'angoscia che può durare settimane e mesi, e che si distingue dalla melanconia vera e propria per avere un legame apparentemente razionale con un trauma psichico. Quest'ultimo è, a ogni modo, solo la causa provocante. Inoltre tale depressione periodica è senza l'anestesia [sessuale] psichica, caratteristica della melanconia. Tutta una serie di casi del genere ho potuto farli risalire al coitus interruptus: la loro comparsa era tardiva e sopravveniva durante il matrimonio, dopo la nascita dell'ultimo figlio. In un caso molto tormentoso di ipocondria, che iniziò durante la pubertà, riuscii a mettere in luce un'aggressione avvenuta quando il paziente aveva otto anni. Un altro caso, che cominciò nell'infanzia, risultò essere una reazione isterica a un'aggressione masturbativa. Non posso pertanto dire se, a questo proposito, esistano vere forme ereditarie senza causa sessuale; e neppure se il coitus interruptus sia il solo responsabile, se tutto possa avvenire anche senza disposizione ereditaria. Ometterò le nevrosi professionali poiché, come ti dissi, si può dimostrare in tali casi l'esistenza di alterazioni nel sistema muscolare. Conclusioni Da quanto precede si ricava la completa prevenibilità delle nevrosi, ma anche la loro completa incurabilità. Il compito del medico riguarda cosi unicamente la profilassi. La prima parte di questo compito, cioè il prevenire la pratica sessuale nociva del primo periodo, coincide con la profilassi contro la sifilide e la gonorrea, poiché questi sono i pericoli che minacciano chi rinuncia alla masturbazione. L'unico sistema sarebbe autorizzare il libero rapporto sessuale fra la gioventù maschile e le ragazze in stato libero: ma a ciò si potrebbe ricorrere solo se vi fossero metodi anticoncezionali innocui. Altrimenti le alternative sono: onanismo, nevrastenia nel maschio, isteronevrastenia nella femmina; o sifilide nel maschio, sifilide nella prossima generazione, gonorrea nel maschio, gonorrea e sterilità nella femmina. Il trauma sessuale del secondo periodo ci pone lo stesso problema: come trovare un metodo innocuo per prevenire il concepimento, poiché il condom non procura una soluzione sicura, né costituisce una soluzione accettabile per chi è già nevrastenico. Per mancanza di tale soluzione, la società sembra condannata a essere vittima di nevrosi incurabili che riducono al minimo le gioie della vita, distruggono le relazioni coniugali e portano una rovinosa eredità alla generazione futura. I più bassi ceti sociali, che non conoscono nulla di malthusianismo, tendono a giungere allo stesso punto e cadranno, secondo natura, vittime della stessa fatalità. Si pone cosi per il medico un problema la cui soluzione merita tutti i suoi sforzi. Per preparare del materiale, ho cominciato a collezionare cento casi di nevrosi d'angoscia; vorrei fare un'analoga raccolta di nevrastenici di entrambi i sessi, e anche di casi, più rari, di depressione periodica. Una seconda serie di un centinaio di casi nervosi ne sarebbe un complemento necessario. Se si stabilisse che i medesimi disturbi funzionali nervosi derivanti dall'abuso della sessualità possono anche essere causati dalla sola ereditarietà, allora ne verrebbero fuori speculazioni la cui importanza noi oggi possiamo appena presentire. [La Minuta C è qui omessa in quanto si tratta di una lettera.] Minuta DSulla etiologia e teoria delle principali nevrosi18941. CLASSIFICAZIONE Introduzione Elementi storici. Graduale differenziazione delle nevrosi. Evoluzione dei miei punti di vista. A. Morfologia delle nevrosi 1) Nevrastenia e pseudonevrastenie. 2) Nevrosi d'angoscia. 3) Nevrosi ossessiva. 4) Isteria. 5) Melanconia, mania. 6) Nevrosi miste. 7) Diramazioni delle nevrosi e trapassi nella normalità.
B. Etiologia delle nevrosi (provvisoriamente limitata alle nevrosi acquisite) 1) Etiologia della nevrastenia. - Tipo di nevrastenia costituzionale. 2) Etiologia della nevrosi d'angoscia, 3) della nevrosi ossessiva e dell'isteria, 4) della melanconia, 5) delle nevrosi miste. 6) La formula etiologica fondamentale - Tesi della specificità [della etiologia]; analisi della miscela di nevrosi. 7) I fattori sessuali nel loro significato etiologico. 8) L'esame dei pazienti. 9) Obiezioni e prove. 10) Comportamento degli asessuali.
C. Etiologia ed eredità I tipi ereditari. - Relazione dell'etiologia con la degenerazione, con le psicosi e con la predisposizione.
2. TEORIA D. Agganci con la teoria della costanza1 Incremento di stimolo interno ed esterno, eccitamento costante e transitorio. - Carattere sommatorio dell'eccitamento interno.2 - Reazione specifica.3 - Formulazione ed esposizione della teoria della costanza. - Intervento dell'Io, con accumulazione dell'eccitamento.4 E. Il processo sessuale alla luce della teoria della costanza Via presa dall'eccitamento nel processo sessuale del maschio e della femmina. - Via presa dall'eccitamento in presenza di pratiche sessuali nocive etiologicamente operanti. - Teoria di una sostanza sessuale.5 - Lo schema della sessualità [vedi oltre p. 31]. F. Meccanismo delle nevrosi Le nevrosi come disturbi dell'equilibrio per aumentata difficoltà di scarico. - Tentativi di compensazione, di limitata efficienza. - Meccanismo delle diverse nevrosi in relazione alla loro etiologia sessuale. -Affetti e nevrosi. G. Parallelismo tra le nevrosi sessuali e quelle da fame H. Compendio della teoria della costanza, e teoria della sessualità e delle nevrosi Posto delle nevrosi in patologia; fattori che le determinano; leggi che governano la loro combinazione. - Inefficienza psichica, sviluppo, degenerazione e simili. Minuta ECome si origina l'angoscia1894Con mano sicura hai posto il problema là dove anche per me è il punto debole. Ciò che io ne so è solo quanto segue: Che l'angoscia dei miei pazienti nevrotici abbia molto a che fare con la sessualità, mi è apparso subito chiaro, e in particolare mi ha colpito con quale certezza il coitus interruptus praticato su una donna portasse a una nevrosi d'angoscia. Cominciai allora dapprima per vie sbagliate. Pensavo che l'angoscia di cui soffrono i pazienti fosse un prolungamento di quella che provano durante l'atto sessuale, che fosse cioè in realtà un sintomo isterico. E, in realtà, le relazioni fra la nevrosi d'angoscia e l'isteria sono abbastanza chiare. Due potrebbero essere le ragioni del senso d'angoscia nel coitus interruptus: nella donna, la paura di rimanere gravida, nell'uomo la preoccupazione che l'artificio possa fallire. Ma l'esperienza mi ha mostrato poi, in molti casi, che le nevrosi d'angoscia apparivano anche dove questi due momenti non si davano per nulla e dove, in realtà, non rivestiva alcuna importanza per i protagonisti l'avere un figlio o no. Perciò l'angoscia della nevrosi d'angoscia non era un'angoscia continuata, ricordata, isterica. Un secondo importantissimo punto mi si è chiarito con la seguente osservazione: è possibile riscontrare una nevrosi d'angoscia sia nelle donne anestetiche sia in quelle sensibili durante il coito. È un fatto particolarmente notevole e può soltanto significare che la fonte dell'angoscia non è da ricercarsi nell'ambito psichico. Essa deve quindi trovarsi in quello fisico; ciò che genera angoscia è un fattore fisico nella vita sessuale. Ma quale? Mi sono messo a questo fine a raccogliere tutti i casi nei quali trovavo che l'angoscia aveva origini sessuali. Sembravano a prima vista molto disparati. 1. Angoscia in soggetti vergini (osservazioni e informazioni sessuali, presentimenti della vita sessuale); confermata da numerosi esempi in ambedue i sessi, predominante nelle donne. Non rara un'allusione a un elemento intermedio, una sensazione come di erezione insorgente nei genitali. 2. Angoscia in soggetti deliberatamente astinenti, pudichi (un tipo di nevropatici). Uomini e donne caratterizzati dalla pedanteria e dall'amore della pulizia, che hanno orrore di tutto ciò che è sessuale. Questi soggetti sono portati a elaborare la loro angoscia in fobie, azioni ossessive, folie du doute. 3. Angoscia in soggetti astinenti per necessità, donne che sono trascurate dal marito o non sono soddisfatte per mancanza di potenza del marito. Questa forma di nevrosi d'angoscia può certo essere acquisita e, per circostanze concomitanti, si combina spesso con la nevrastenia. 4. Angoscia in donne soggette al coitus interruptus o, ciò che è simile, in donne i cui mariti soffrono di eiaculazione precoce, persone, quindi, in cui lo stimolo fisico non è soddisfatto. 5. Angoscia in uomini che praticano il coitus interruptus e, ancora più, in uomini che si eccitano in vari modi ma non impiegano la loro erezione per il coito. 6. Angoscia in uomini che vanno al di là del loro piacete e delle loro forze, gente piuttosto anziana, la cui potenza è in declino ma che, tuttavia, forzano il coito. 7. Angoscia in uomini astinenti per circostanze casuali: uomini giovani, sposati a donne più vecchie che fanno loro ribrezzo, oppure nevrastenici distolti dalla masturbazione da occupazioni intellettuali senza per questo praticare il coito, o in uomini la cui potenza comincia a diminuire e che si astengono dal rapporto nel matrimonio a motivo di [sgradevoli] sensazioni post coitum. Nei restanti casi la connessione fra l'angoscia e la vita sessuale non era evidente (si poteva però dimostrare teoricamente). Come combinare tutti questi casi diversi? L'astinenza è il fattore che ricorre più frequentemente. Istruiti dal dato di fatto che dopo il coitus interruptus si ha angoscia persino nelle donne anestetiche, si potrebbe dire che si tratta di un accumulo fisico di eccitamento, cioè un accumulo di tensione fìsica sessuale. L'accumulo è dovuto all'impedimento della scarica. La nevrosi d'angoscia è quindi, come l'isteria, una nevrosi da ingorgo: di qui, la loro somiglianza. E poiché l'angoscia non è certamente contenuta in ciò che è accumulato, si può esprimere questo stato di cose dicendo che l'angoscia sorge da una trasformazione della tensione sessuale accumulata. A questo punto s'inserisce una nozione, da me acquisita contemporaneamente, intorno al meccanismo della melanconia. Accade, particolarmente spesso, che i sofferenti di melanconia siano divenuti anestetici. Essi non hanno bisogno del coito (né delle sue sensazioni), ma hanno un grande desiderio di amore nella sua forma psichica o, si potrebbe dire, della tensione psichica amorosa: laddove si accumula e resta insoddisfatta, insorge la melanconia. Ed ecco allora il contrapposto delle nevrosi d'angoscia. Dove v'è accumulo di tensione sessuale fisica,... nevrosi d'angoscia. Dove v'è accumulo di tensione sessuale psichica,... melanconia. Ma perché questa trasformazione in angoscia per accumulo? A questo punto dovremmo addentrarci nel normale meccanismo dell'eliminazione della tensione accumulata. Si tratta qui del secondo caso, cioè del caso di eccitamento endogeno. Quello dell'eccitamento esogeno è più semplice, poiché la fonte dell'eccitamento è esterna e invia nella psiche un incremento di eccitamento che si elimina a seconda della sua quantità; a tale scopo è sufficiente qualsiasi reazione che riduca dello stesso quantitativo l'eccitamento psichico. Ma succede altrimenti con la tensione endogena, la cui fonte giace nell'interno del corpo del soggetto (fame, sete, pulsione sessuale). In questo caso giovano soltanto le reazioni specifiche,1 quelle cioè che prevengono l'ulteriore prodursi di eccitamento nei relativi organi terminali, sia grande o piccolo il dispendio necessario per realizzarle. Possiamo immaginarci che la tensione endogena aumenti in modo continuo o discontinuo, ma in un caso come nell'altro essa viene notata solo quando ha raggiunto una certa soglia. Solo al di sopra di questa soglia essa acquista un valore psichico ed entra in relazione con certi gruppi di rappresentazioni,2 che poi producono il rimedio specifico. Cosi la tensione sessuale fisica, quando supera un certo grado, risveglia la libido psichica,3 che porta poi al coito ecc. Se non segue la reazione specifica, la tensione fisico-psichica (l'emozione sessuale) aumenta a dismisura, diventa disturbo, ma non vi è ancora motivo perché si trasformi. Nelle nevrosi d'angoscia, invece, avviene sicuramente una simile trasformazione, e questo porta a credere che si abbia la seguente deviazione: la tensione fisica aumenta, raggiunge il livello di soglia al quale può risvegliare un affetto psichico, ma per una ragione qualsiasi il nesso psichico offerto è insufficiente, non giunge a formare un'emozione sessuale, perché manca qualcosa nelle condizioni psichiche per questo. Cosi avviene che la tensione fisica, non essendo psichicamente legata, si trasforma in... angoscia. Se si segue la teoria fino a questo punto, si deve sostenere che nelle nevrosi d'angoscia si deve costatare una deficienza di emozione sessuale, di libido psichica. E questo è confermato dall'osservazione. Le pazienti s'indignano tutte se portiamo la loro attenzione su questa connessione; al contrario, dicono di non avere alcun desiderio, e cosi via. I maschi spesso convengono di non aver avuto più desideri sessuali da che hanno cominciato a essere angosciati. Vedremo ora quanto questo meccanismo si accordi con i diversi casi sopra elencati. 1. Angoscia verginale. Qui il genere di rappresentazioni che dovrebbe assorbire la tensione fisica non è ancora presente, o solo in modo insufficiente; v'è inoltre, come risultato secondario dell'educazione, un rifiuto psichico. Tutto torna perfettamente. 2. Angoscia delle pudiche. È il caso della difesa, della ripulsa psichica diretta, che rende impossibile ogni rielaborazione della tensione sessuale. Anche qui, il caso delle numerose rappresentazioni ossessive. Tutto torna perfettamente. 3. Angoscia da astinenza forzata. In sostanza la stessa cosa, poiché tali donne abitualmente, per non cadere in tentazione, creano una ripulsa psichica. Qui, contingente, nel caso precedente, di principio. 4. Angoscia da coitus interruptus nelle donne. Qui il meccanismo è più semplice. Si tratta di un eccitamento endogeno che non è d'origine spontanea, ma viene prodotto, non tuttavia in misura sufficiente da risvegliare l'affetto psichico. Si determina artificialmente un'alienazione fra l'atto fisico-sessuale e la sua rielaborazione psichica.1 Se la tensione endogena aumenta ancora per motivi propri, non può venir rielaborata e genera angoscia. Qui può essere presente libido, ma non contemporaneamente all'angoscia. Dunque qui la ripulsa psichica è seguita dalla alienazione psichica; alla tensione di origine endogena segue la tensione indotta. 5. Angoscia da coitus interruptus o reservatus negli uomini. Il caso del coitus reservatus è il più evidente. Il coitus interruptus si può parzialmente considerare come un suo equivalente. Anche qui si tratta di una diversione psichica, perché l'attenzione è rivolta a un altro scopo ed è sottratta alla rielaborazione della tensione fisica. La spiegazione del coitus interruptus ha tuttavia probabilmente bisogno di essere migliorata. 6. Angoscia da diminuzione di potenza o da insufficienza della libido. Quando non si tratta di una trasformazione della tensione fisica in angoscia come risultato della senilità, si spiega col difetto di desiderio fisico per l'atto particolare. 7. Angoscia da disgusto negli uomini, o angoscia in nevrastenici astinenti. Il primo caso non richiede ulteriori spiegazioni. Nel secondo si tratta probabilmente di una forma attenuata di nevrosi d'angoscia, poiché questa normalmente si sviluppa appieno solo in soggetti potenti. Forse in connessione al fatto che il sistema nervoso dei nevrastenici non può tollerare un accumulo di tensione fisica, poiché la masturbazione comporta l'abitudine a una frequente, completa mancanza di tensione. In complesso dunque la mia teoria si regge abbastanza bene. Dove la tensione sessuale fisica è abbondante, si trasforma in angoscia nei casi nei quali essa non subisce la rielaborazione psichica che la trasformerebbe in affetto: ciò non avviene o per insufficiente sviluppo della sessualità psichica, o per un tentativo di repressione di questa (cioè per difesa), o ancora per decadenza di questa o per abituale alienazione tra sessualità fisica e psichica. Giocano perciò qui l'accumulo di tensione fisica e l'impedimento di scarica dal lato psichico. Ma perché si trasforma proprio in angoscia? L'angoscia è sensazione di accumulo nel caso di un altro stimolo endogeno, lo stimolo a respirare, che conosce solo questa possibile rielaborazione psichica; perciò l'angoscia potrebbe corrispondere all'accumulo di tensione fisica in genere. Inoltre, se noi esaminiamo i sintomi della nevrosi d'angoscia più da vicino, scopriamo anche in essa i frammenti sparsi del grande attacco d'angoscia: semplici dispnea, palpitazione, sensazione d'angoscia, e loro combinazioni. Se si guardano le cose più da vicino, si vedrà che queste sono le vie d'innervazione lungo le quali passa normalmente la tensione fisico-sessuale, anche quando viene rielaborata psichicamente. La dispnea e la palpitazione accompagnano il coito; nel nostro caso, per cosi dire, sono gli unici sbocchi dell'eccitamento, là invece sono solo scarichi complementari. Quindi vi è una specie di conversione in atto nella nevrosi d'angoscia proprio come nell'isteria (un altro esempio della somiglianza tra le due; solo che nell'isteria si tratta di eccitamento psichico che segue una via sbagliata la quale conduce al campo somatico, mentre nella nevrosi d'angoscia si tratta di tensione fisica che è incapace di trovare uno sfogo psichico, e conseguentemente si mantiene nel canale fisico. I due processi si combinano con enorme frequenza. Questo è il punto a cui sono arrivato. Vi sono certamente lacune da colmare; il quadro è, secondo me, incompleto, qualcosa mi manca, ma credo che le basi siano giuste. Naturalmente è ancora immaturo per essere reso pubblico. Suggerimenti, amplificazioni e inoltre confutazioni e spiegazioni saranno estremamente bene accetti. MinutaRaccolta III189418 agosto 1894 N. 1 Nevrosi d'angoscia: disposizione ereditaria. Signor K., età 27 anni. Il padre fu curato per melanconia senile, la sorella O. caso interessante di complicata nevrosi d'angoscia, ben analizzato. Tutti i K. nervosi e ricchi di temperamento. Cugino del dottor K. di Bordeaux. — In buona salute fino a poco tempo fa. Da nove mesi soffre d'insonnia; in febbraio e in marzo risvegli frequenti con terrori notturni e palpitazioni; graduale aumento dell'eccitabilità generale; in seguito, interruzione per vita militare, da cui trasse molto giovamento. Tre settimane fa, di sera, attacco improvviso, non motivato, d'angoscia, accompagnato da un senso di congestione dal torace alla testa; interpretato da lui stesso come presentimento di qualcosa di orribile che doveva accadere; non accompagnato da alcun senso di oppressione ma solo da una leggera palpitazione. Attacchi simili anche durante il giorno e durante il pranzo. Due settimane fa consultato un medico; miglioramento con bromuri, ancora malato, ma dorme bene. Oltre a ciò, nelle scorse due settimane, brevi accessi di profonda depressione, rassomiglianti all'apatia completa, solo per pochi minuti. Miglioramento qui a R[eichenau]. Altrimenti, ancora accessi di senso di pressione alla cervice. Comincia lui stesso col darmi informazioni sessuali. Un anno fa s'innamorò di una ragazza leggera; duro colpo alla notizia che essa era fidanzata con un altro. Ora non è più innamorato di lei. — Dà poca importanza a questa storia. — Continua: Fra i 13e i 16 o 17 anni usava masturbarsi, sull'esempio dei compagni di scuola, con pretesa moderazione. Moderazione nei rapporti sessuali; uso del condom negli ultimi due anni e mezzo per paura di contrarre infezioni; spesso si sente fiacco dopo l'uso. Definisce forzato questo tipo di coito; nota che la libido sta diminuendo molto da un anno a questa parte. Era stato sessualmente molto eccitato dalla relazione con quella ragazza (senza contatto intimo ecc.). Il suo primo attacco notturno (in febbraio) due giorni dopo un coito; il suo primo attacco d'angoscia si verificò la stessa sera, dopo il coito; da allora (tre settimane) astinente: un uomo tranquillo, affettuoso e in generale sano. Epicrisi del N. 1 Se tentiamo di interpretare il caso di K., una cosa ci colpisce soprattutto. L'uomo ha una predisposizione ereditaria: suo padre soffre di melanconia, probabilmente una melanconia angosciosa; sua sorella soffre di una tipica nevrosi d'angoscia, che conosco molto bene ma che altrimenti avrei descritto come acquisita. Ciò fa pensare a ereditarietà. Nella famiglia K. vi è probabilmente una semplice "disposizione", una tendenza ad ammalarsi di volta in volta sempre più seriamente, ma non "degenerazione". Si può supporre che nel caso di K. la leggera nevrosi d'angoscia si sia sviluppata su una leggera etiologia. Dove ricercarla senza preconcetti? Mi sembra che, in primo luogo, ci si trovi di fronte a una sessualità indebolita. La libido di quest'uomo è da qualche tempo diminuita; la manovra per l'uso del condom è sufficiente a fargli apparire l'atto sessuale come qualcosa di forzato e il piacere come artificiale. Questo è, senza dubbio, il nocciolo di tutta la faccenda. Dopo il coito si sente talora fiacco; egli se ne accorge, cosi dice, e poi due giorni dopo un coito, oppure la sera stessa, si verificano i primi attacchi d'angoscia. Il concorso della diminuzione della libido con la nevrosi d'angoscia rientra senza sforzo nella mia teoria. Si tratta di una debolezza nel controllo psichico dell'eccitamento sessuale somatico, esistente da un certo tempo, che permette l'insorgere dell'angoscia quando si verifica un incidentale aumento dell'eccitamento somatico. Da dove proviene questo indebolimento psichico? Dall'attività masturbatoria dell'adolescenza c'è poco da ricavare: certamente non è in grado di produrre tali risultati; inoltre pare che il soggetto non abbia ecceduto. La sua relazione con la ragazza, che lo eccitava molto sessualmente, sembra assai più adatta a causare un disturbo di questo genere; in realtà, nevrosi simili le troviamo di solito in persone fidanzate da lungo tempo. Ma soprattutto non si può dubitare che la paura di infezione e la decisione di usare il condom abbiano fornito la base di ciò che io chiamo fattore di alienazione fra il somatico e lo psichico. Sembra che l'effetto sia lo stesso prodotto dal coitus interruptus negli uomini. In breve, K. si è procurato un indebolimento sessuale psichico in seguito ad avversione per il coito e, mantenendosi inalterata la salute fisica e la produzione di stimoli sessuali, si è avuta formazione di angoscia. Possiamo aggiungere che la sua tendenza a prendere precauzioni, invece di cercare soddisfacimento adeguato in una sicura relazione, indica una sessualità non molto potente sin dall'inizio. Egli ha, in realtà, una disposizione ereditaria; ciò che si ritrova nella etiologia del suo caso è qualitativamente importante, ma verrebbe sopportato senza danno da un uomo sano, cioè vigoroso. Un'interessante caratteristica di questo caso è la comparsa di stati d'animo tipicamente melanconici in accessi di breve durata. Ciò dev'essere teoricamente importante in connessione con le nevrosi d'angoscia da alienazione, ma per il momento posso solo segnalarlo. 20 agosto 1894 N. 2 Signor von F., Budapest, 44 anni. Fisicamente sano, si lamenta di "aver perso vivacità e interesse in modo non naturale per la sua età". Questo stato, in cui tutto gli sembra indifferente, in cui gli riesce noioso il lavoro e si sente irritabile e fiacco, è accompagnato da un forte senso di pressione al vertice del capo e anche alla cervice; inoltre è regolarmente accompagnato da cattiva digestione, cioè da disgusto per il cibo, da flatulenza e stipsi. Sembra anche che dorma male. Ma lo stato evidentemente si ripete a intervalli; ogni volta dura 4 o5 giorni, poi gradualmente scompare. Egli si accorge dalla flatulenza che sta per entrare in un periodo di debolezza nervosa. Gli intervalli durano da 12 a 14 giorni, qualche volta sta bene per più settimane. Talora i periodi buoni sono durati anche dei mesi. Sostiene di essere in queste condizioni da 25 anni. Come spesso accade, è necessario prima ricostruire il quadro della malattia, perché altrimenti egli non fa che ripetere in modo monotono le sue lamentele e dice di non aver prestato attenzione ad altro. Il modo poco chiaro con il quale egli definisce i suoi accessi fa parte del quadro, come pure la loro completa irregolarità cronologica. Naturalmente sostiene che il suo male dipende dalla cattiva digestione... Organicamente sano, senza serie preoccupazioni o disturbi emotivi; quanto alla sessualità, onanismo dai 12 ai 16 anni; poi rapporti sessuali molto regolari con donne, senza stimoli troppo forti. Sposato da 14 anni, ha solo due figli; il più giovane ha 10 anni. Nell'intervallo tra la nascita dei due figli e dopo, uso del condom, e nessun'altra tecnica. La sua potenza è decisamente diminuita negli ultimi anni, con coito ogni 12-14 giorni, spesso anche più lunghi intervalli. Ammette che dopo il coito con condom si sente fiacco e afflitto, ma non subito, solo il secondo giorno; vale a dire che due giorni dopo, cosi dice, nota di aver difficoltà digestive. Perché usa un condom? È chiaro: per non aver troppi figli ( due.) Epicrisi Un leggero, ma molto caratteristico, caso di depressione periodica, melanconia. Sintomi: apatia, inibizione, senso di pressione alla testa, dispepsia, disturbo del sonno; il quadro è completo. Vi è una indubbia somiglianza con la nevrastenia, e l'etiologia è la stessa. Attualmente ho altri casi analoghi; onanisti (come il signor A.) e gente con tara ereditaria; i von F. sono notoriamente degli psicopatici. Questa è dunque la melanconia nevrastenica; dev'esserci qui un aggancio con la teoria della nevrastenia. È affatto possibile che il punto di partenza costante di una piccola melanconia di tal genere sia sempre un coito. Una esagerazione del detto fisiologico: omne animai post coitum triste. Gli intervalli concorderebbero: l'uomo è migliorato durante ogni periodo di cura e a ogni assenza da casa, cioè in ogni periodo in cui si astiene dal coito. Naturalmente, come egli dice, è fedele a sua moglie. L'uso del condom è prova di limitata potenza; essendo qualcosa di analogo all'onanismo, è causa continua di questa melanconia. Minuta GMelanconia18951. I fatti sono all'incirca questi: A. Vi sono relazioni evidenti fra melanconia e anestesia [sessuale]. Questo è provato: 1) dall'accertamento di un lungo periodo precedente di anestesia, nel caso di molti melanconici; 2) dall'osservazione che tutto ciò che provoca l'anestesia incoraggia anche il formarsi della melanconia; 3) dall'esistenza di un tipo di donne psichicamente molto esigenti, in cui il desiderio si tramuta facilmente in melanconia e che sono anestetiche. B. La melanconia si forma come un'intensificazione della nevrastenia tramite la masturbazione. C. La melanconia compare tipicamente combinata con grave angoscia. D. Il tipo e caso estremo2 della melanconia sembra la forma periodica 0 ciclica ereditaria. 2. Per poter utilizzare questo materiale occorrono alcuni solidi punti di partenza. Questi sembrano offerti dalle seguenti considerazioni: a. L'affetto corrispondente alla melanconia è quello del lutto, cioè il rimpianto di qualcosa di perduto. Cosi nella melanconia dovrebbe trattarsi di una perdita, e precisamente una perdita nella vita pul-sionale.3 b. La nevrosi alimentare parallela alla melanconia è l'anoressia. La ben nota anorexia nervosa delle ragazze mi sembra essere (da osservazioni accurate) una melanconia che si verifica ove la sessualità non è sviluppata. La paziente asseriva che non mangiava semplicemente perché non aveva appetito, e per nessun'altra ragione. Perdita di appetito: in termini sessuali, perdita della libido. Cosi non sarebbe inopportuno partire dall'idea che la melanconia consiste nel lutto per la perdita della libido. Ora rimane da vedere se questa formula spiega la comparsa e le caratteristiche dei melanconici. Sarà da discuterne sulla base dello schema della sessualità. 3. Sulla base dello schema della sessualità [fig. 1], che spesso ho usato, discuteremo ora le condizioni nelle quali il gruppo sessuale psichico (G. ps.) subisce una diminuzione della sua quantità di eccitamento. Vi sono due casi possibili: 1) se la produzione di E. som. (eccitamento sessuale somatico) si abbassa o cessa, 2) se la tensione sessuale è deviata da G. ps. [dal gruppo sessuale psichico].  Il primo caso, nel quale la produzione di E. som. [eccitamento sessuale somatico] cessa, probabilmente caratterizza la comune grave melanconia vera e propria, che ricorre periodicamente, 0 la melanconia ciclica, nella quale i periodi di aumento e di cessazione della produzione si alternano. Inoltre, si può ritenere che la masturbazione eccessiva che, secondo la nostra teoria, porta a un discarico troppo grande di O. (l'organo terminale) e quindi a un basso livello di stimolo in O., perviene a influenzare la produzione E. som. [eccitamento sessuale somatico] e a causarne un duraturo impoverimento, con la conseguenza di un indebolimento di G. ps. [del gruppo sessuale psichico]. Questa è la melanconia nevrastenica. Nel [secondo] caso, poiché la tensione sessuale è deviata da G. ps. [dal gruppo sessuale psichico] mentre la produzione di E. som. [eccitamento sessuale somatico] non diminuisce, bisogna supporre che E. som. sia impiegato altrove al confine [tra il somatico e lo psichico]. Questa è tuttavia la condizione dell'angoscia e, di conseguenza, corrisponde al caso della melanconia angosciosa, una forma mista di nevrosi d'angoscia e di melanconia. In questa discussione dunque vengono chiarite le tre forme di melanconia, che di fatto conviene mantenere distinte. 4. Come spiegare il fatto che l'anestesia abbia una tale parte nella melanconia? Secondo lo schema abbiamo le seguenti specie di anestesia. L'anestesia consiste sempre nell'assenza di S.v. (la sensazione voluttuosa) che, in seguito all'azione riflessa che scarica l'organo terminale, dovrebbe essere indirizzata in G. ps. [nel gruppo sessuale psichico]. L'ammontare della voluttà corrisponde all'intensità del discarico. a) L'organo terminale è caricato in modo insufficiente e di conseguenza la scarica, quando avviene il coito, è debole e S. v. [la sensazione voluttuosa] molto piccola. Caso della frigidità. b) La via che conduce dalla sensazione all'atto riflesso è danneggiata in modo tale che l'azione non è sufficientemente forte. Se cosi, anche il discarico e S.v. sono deboli. Caso dell'anestesia da masturbazione, dell'anestesia da coitus interruptus ecc. e) Tutto funziona bene in basso; ma S.v. non è accettata in G. ps. [nel gruppo sessuale psichico] perché collegata in altra direzione (con disgusto-difesa). Questa è l'anestesia isterica, del tutto analoga all'anoressia isterica (disgusto). Ora, in che misura l'anestesia agisce sulla formazione della melanconia? Nel caso a) (frigidità) l'anestesia non è la causa della melanconia ma un segno di predisposizione a essa. Questo concorda con il fatto Ai) menzionato all'inizio di questo saggio. In altri casi l'anestesia è la causa della melanconia, perché G. ps. [il gruppo sessuale psichico] è rafforzato dal sopravvenire di S.v. e indebolito dalla sua assenza. (Riferimento alle teorie generali sul fermare l'eccitamento nel ricordo.) Con ciò è dato conto del fatto A2). Di conseguenza, è possibile essere anestetici senza essere melanconici, poiché la melanconia è in relazione con l'assenza di E. som. [dell'eccitamento sessuale somatico], mentre l'anestesia è in relazione con l'assenza di S. v. Ma l'anestesia è un indice di melanconia o una preparazione alla melanconia, perché G. ps. [il gruppo sessuale psichico] è tanto indebolito dall'assenza di S.v. quanto dall'assenza di E. som. 5. Sarebbe anche da considerare perché l'anestesia sia una caratteristica cosi prevalentemente femminile. Questo deriva dalla parte passiva sostenuta dalla donna. Un uomo anestetico rinuncerà presto a qualsiasi coito, ma per la donna è diverso. Essa diventerà più facilmente anestetica per due ragioni: 1) Perché tutta la sua educazione tende a impedire che sorga E. som. [l'eccitamento sessuale somatico] e a trasformare tutti gli eccitamenti che potrebbero avere questo effetto in stimoli psichici, tende cioè a far deviare la linea tratteggiata [nella fig. 1] dall'oggetto sessuale, interamente verso G. ps. [il gruppo sessuale psichico]. Questo è necessario perché, se vi fosse un vivace E. som., presto G. ps. acquisterebbe in modo intermittente una forza tale da portare l'oggetto sessuale, come nell'uomo, in una posizione favorevole mediante la reazione specifica. Ma alla donna si richiede che non abbia luogo l'intero arco della reazione specifica, bensì si richiedono azioni specifiche permanenti che inducano il maschio all'azione specifica. La tensione sessuale è di conseguenza tenuta bassa nella donna, l'accesso a G. ps. è per quanto possibile tagliato fuori, e l'indispensabile forza di G.ps. è ottenuta in altro modo. Se, dunque, G.ps. raggiunge una condizione di desiderio, questa si trasforma facilmente in melanconia, quando O. [l'organo terminale] è a un basso livello [di tensione]. G.ps. è, per sé stesso, capace di scarsa resistenza. Qui noi abbiamo il tipo di libido giovanile, immatura, e le donne esigenti e anestetiche summenzionate si limitano a continuare questo tipo. 2) Perché molto frequentemente le donne si accingono all'atto sessuale, o si sposano, senza amore, cioè solo con un debole E. som. [eccitamento sessuale somatico] e con poca tensione in O. In tal caso esse sono frigide e tali rimangono. Un basso livello di tensione in O. sembra costituire la principale disposizione alla melanconia. In queste persone qualsiasi tipo di nevrosi prende facilmente un'impronta melanconica. Cosi, mentre i soggetti potenti soffrono facilmente di nevrosi d'angoscia, quelli impotenti sono inclini alla melanconia. Come si possono spiegare gli effetti della melanconia? La migliore descrizione di essi: inibizione psichica con impoverimento pulsionale e dolore al riguardo. È facile prevedere che se G. ps. [il gruppo sessuale psichico] subisce una forte diminuzione nell'eccitamento, si può avere come conseguenza una specie di contrazione nello psichico, la quale ha come effetto di risucchiare i quantitativi di eccitamento contigui. [fig. 2].  I neuroni associati sono obbligati a rinunciare al loro eccitamento, ciò che produce dolore. Il sciogliere un'associazione è sempre doloroso. Per una sorta di emorragia interna si ha un impoverimento dell'eccitamento, nella sua libera riserva, che si ripercuote su altre pulsioni e prestazioni. Tale contrazione ha un effetto inibitorio, come una ferita (vedi la teoria del dolore fisico) e analogamente al dolore. (Il caso opposto [fig. 3] sarebbe invece quello della mania, in cui il sovrabbondante eccitamento è comunicato a tutti i neuroni associati.) 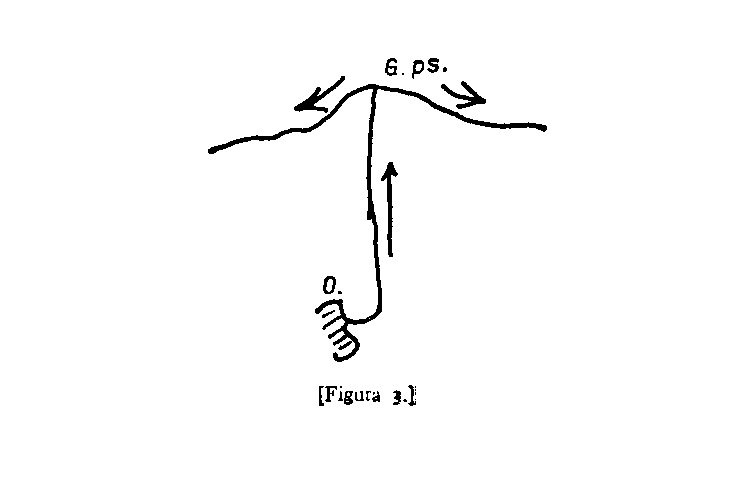 Qui si può trovare una somiglianza con la nevrastenia. Nella nevrastenia si verifica ugualmente un impoverimento dovuto al fatto che l'eccitamento sfugge come traverso una falla, ma in quel caso ciò che viene pompato via è E. som. [l'eccitamento sessuale somatico]; nella melanconia la falla è nello psichico. L'impoverimento nevrastenico, tuttavia, può estendersi allo psichico. In verità le manifestazioni sono tanto simili che alcuni casi possono distinguersi solo con molta difficoltà. Minuta HParanoia1895In psichiatria i deliri sono avvicinati alle ossessioni, come disturbi puramente intellettuali; la paranoia alla follia ossessiva, come psicosi intellettuale. Una volta ricondotte le ossessioni a un disturbo affettivo, e se si è provato che la loro forza deriva da un conflitto, allora si deve applicare la stessa concezione ai deliri, allora anche questi devono essere la conseguenza di disturbi affettivi e devono trarre la loro forza da un processo psicologico. Gli psichiatri sostengono un'opinione contraria, mentre i profani tendono ad attribuire la pazzia a esperienze psichiche sconvolgenti: "l'uomo che non perde la ragione davanti a certi avvenimenti, non ha una ragione da perdere". La verità è che la paranoia cronica, nella sua forma classica, costituisce un modo patologico di difesa come l'isteria, la nevrosi ossessiva e gli stati di confusione allucinatoria. Si diventa paranoici in conseguenza di avvenimenti che non si possono tollerare, sempre che si abbia la particolare disposizione psichica. In che cosa consiste tale disposizione? In una tendenza verso qualcosa che possiede le caratteristiche psichiche della paranoia; e ciò vogliamo considerare sulla base di un esempio. Una donna nubile, non più molto giovane, circa trent'anni, vive con un fratello e una sorella [più anziana]. Essi appartengono al ceto operaio più elevato; il fratello sta gradualmente facendosi strada come piccolo fabbricante. Frattanto essi affittano una stanza a un conoscente, un uomo che ha viaggiato molto, piuttosto misterioso, astuto e intelligente, il quale resta un anno con loro mantenendosi sempre molto socievole e di buona compagnia; poi parte di nuovo, ritorna sei mesi più tardi, questa volta si ferma soltanto per un tempo più breve e poi riscompare per sempre. Le sorelle spesso lamentano la sua assenza e non fanno che dirne bene. Nondimeno, la sorella più giovane racconta alla più anziana di una volta che egli tentò di metterla nei guai. Gli stava rifacendo la stanza mentre egli era ancora a letto; lui l'aveva chiamata presso il letto e quando essa, senza sospettare, aveva obbedito, le aveva messo il pene in mano. La scena non aveva avuto un seguito e presto lo straniero se ne era andato. Qualche anno dopo la sorella che aveva avuto questa esperienza si ammalava. Cominciò dapprima a lamentarsi; infine le si svilupparono inconfondibili deliri di attenzione e di persecuzione, la cui sostanza era che le donne del vicinato la compiangevano perché era stata abbandonata e perché continuava a sperare nel ritorno dell'uomo, facendo continuamente delle insinuazioni e dicendo le cose più varie dì lei a proposito di lui, e cosi via. Tutto era naturalmente falso. La paziente resta in questo stato solo per alcune settimane, poi ridiventa normale e spiega che tutto ciò era dovuto al fatto che si sentiva eccitata; tuttavia anche negli intervalli essa soffre di una nevrosi che può facilmente essere interpretata come nevrosi sessuale. Ben presto però sopravviene di nuovo la paranoia. La sorella più anziana ha notato con sorpresa che, ogni volta che la conversazione ritorna alla scena della seduzione, la paziente la nega. Breuer ha avuto notizia del caso, la paziente mi è stata inviata, e io ho tentato di correggere la tendenza alla paranoia, cercando di portarla a ricordare la scena. Non ho avuto successo, allora le ho parlato due volte cercando di indurla, in stato di concentrazione ipnotica, a dirmi tutto ciò che si riferiva al suo inquilino; alle mie domande incalzanti, tendenti ad approfondire se nulla di "imbarazzante" fosse accaduto, ho sempre ottenuto risposta nettamente negativa e... non l'ho più vista. Essa mi ha fatto sapere che ciò la sconvolgeva troppo. Difesa! È chiaro. Essa desiderava non ricordare il fatto e, di conseguenza, lo aveva intenzionalmente rimosso. Nessun dubbio circa la difesa, ma si sarebbe potuto produrre parimenti un sintomo isterico o un'ossessione. Qual è la natura peculiare della difesa paranoica? Essa voleva risparmiarsi qualcosa; qualcosa era stato rimosso. Possiamo indovinare che cosa. Probabilmente essa era stata veramente eccitata da quella vista e dal suo ricordo. Essa cercava di risparmiare a sé stessa l'autoaccusa di essere una "donna cattiva". Senonché lo stesso rimprovero le pervenne anche da altri. La sostanza restava la medesima, ma mutava qualcosa nella prospettiva delle cose: prima era un rimprovero interno, ora veniva dal di fuori. Il giudizio su di lei si era trasposto all'esterno: la gente diceva ciò che altrimenti essa si sarebbe detta da sé. Con ciò aveva ottenuto un vantaggio. Essa non avrebbe potuto non accettare il giudizio che fosse venuto dal suo interno, ma poteva rifiutarne uno che veniva dal di fuori. In tal modo il giudizio, il rimprovero, era tenuto lontano dal suo Io. Lo scopo della paranoia è quindi di respingere una rappresentazione incompatibile con l'Io mediante una proiezione1 del suo contenuto all'esterno. Due domande: [1] Come si verifica una trasposizione di tal genere? [2] Questo vale anche per altri casi di paranoia? [1] La trasposizione si verifica molto semplicemente. Si tratta del cattivo uso di un meccanismo psichico molto comunemente impiegato nella vita normale: il meccanismo della trasposizione o della proiezione.1 Ogni volta che si verifica un cambiamento interno, ci è data la scelta di attribuirlo o a una causa interna o a una esterna. Se qualcosa ci trattiene dall'accettare l'origine interna, noi naturalmente ci aggrappiamo a una esterna. In secondo luogo, siamo abituati a vedere che i nostri stati interni vengono rilevati dagli altri (dall'espressione mimica dei sentimenti). Ciò dà origine al normale delirio di attenzione e alla normale proiezione. Tutte cose normali finché conserviamo coscienza del nostro mutamento interno. Se però lo dimentichiamo e ci rimane solo la parte del sillogismo che porta all'esterno, allora abbiamo la paranoia, con la sua sopravvalutazione di ciò che la gente sa di noi e di ciò che la gente ci ha fatto. Che cosa sa la gente di noi, che noi stessi ignoriamo e non possiamo ammettere? Ecco il cattivo uso del meccanismo della proiezione a scopo di difesa. Qualcosa del tutto analogo avviene con le ossessioni. Anche il meccanismo della sostituzione è un meccanismo normale. Se un'anziana zitella tiene un cane o un vecchio scapolo raccoglie tabacchiere, la prima compensa il suo bisogno di compagnia coniugale, il secondo il suo desiderio di... numerose conquiste. Ogni collezionista è una controfigura di Don Giovanni Tenorio, cosi come lo scalatore di montagne, lo sportivo ecc. Sono equivalenti erotici. Li conoscono anche le donne. La cura ginecologica rientra in questa categoria. Vi sono due tipi di malate: le prime fedeli al medico come al proprio marito, le seconde che cambiano medici come i propri amanti. Tale meccanismo sostitutivo normale viene male impiegato nelle rappresentazioni ossessive: parimenti a scopo di difesa. [2] Tale interpretazione può dunque applicarsi ad altri casi di paranoia? A tutti, penserei. Prendiamo degli esempi. Il paranoico litigioso non può sopportare l'idea di avere commesso un'ingiustizia e di doversi privare della sua proprietà. Di conseguenza, la sentenza non è legalmente valida, lui non ha affatto torto ecc. Il caso è troppo chiaro, forse non del tutto univoco, forse da spiegare in modo più semplice. La grande nation non può concepire l'idea di poter essere sconfitta in guerra. Ergo non è stata sconfitta; la vittoria non conta. Essa dà un esempio di paranoia collettiva e inventa il delirio di tradimento. L'alcolizzato non vorrà mai ammettere di essere divenuto impotente a causa del bere. Per quanto alcool possa tollerare, non può tollerare questa idea. Cosi la colpevole è sua moglie: delirio di gelosia ecc. L'ipocondriaco lotterà a lungo prima di scoprire la chiave del suo sentirsi gravemente ammalato. Egli non può dire a sé stesso che gli deriva dalla sua vita sessuale; ma troverà la più grande soddisfazione nel ritenere che le sue sofferenze non sono endogene, come dice Moebius, ma esogene. Perciò è stato avvelenato. Il funzionario che non è stato avanzato di grado ha bisogno di persecutori che cospirano contro di lui e lo spiano fino nella sua camera; altrimenti dovrebbe ammettere la sua inettitudine. Non sempre si sviluppa un delirio di persecuzione. Il delirio di grandezza può essere per esempio ancora più efficace per eliminare dall'Io l'idea penosa. Per una cuoca sfiorita, costretta ad abituarsi all'idea di rimanere esclusa dalle gioie dell'amore, ecco, per esempio, il momento adatto per scoprire che il signore di faccia è evidentemente desideroso di sposarla e glielo fa capire in modo cosi stranamente timido e tuttavia significativo. In tutti i casi l'idea delirante è mantenuta con la stessa energia con la quale un'altra idea, penosa in modo insopportabile, viene respinta dall'Io. Cosi, essi amano il loro delirio come sé stessi. Questo è il segreto. Ora, in quale rapporto sta questa forma di difesa con quelle che già conosciamo: 1) isteria; 2) rappresentazione ossessiva; 3) confusione allucinatoria; 4) paranoia? Dobbiamo tener conto di: affetto, contenuto rappresentativo e allucinazioni [vedi prospetto a pagina seguente]. 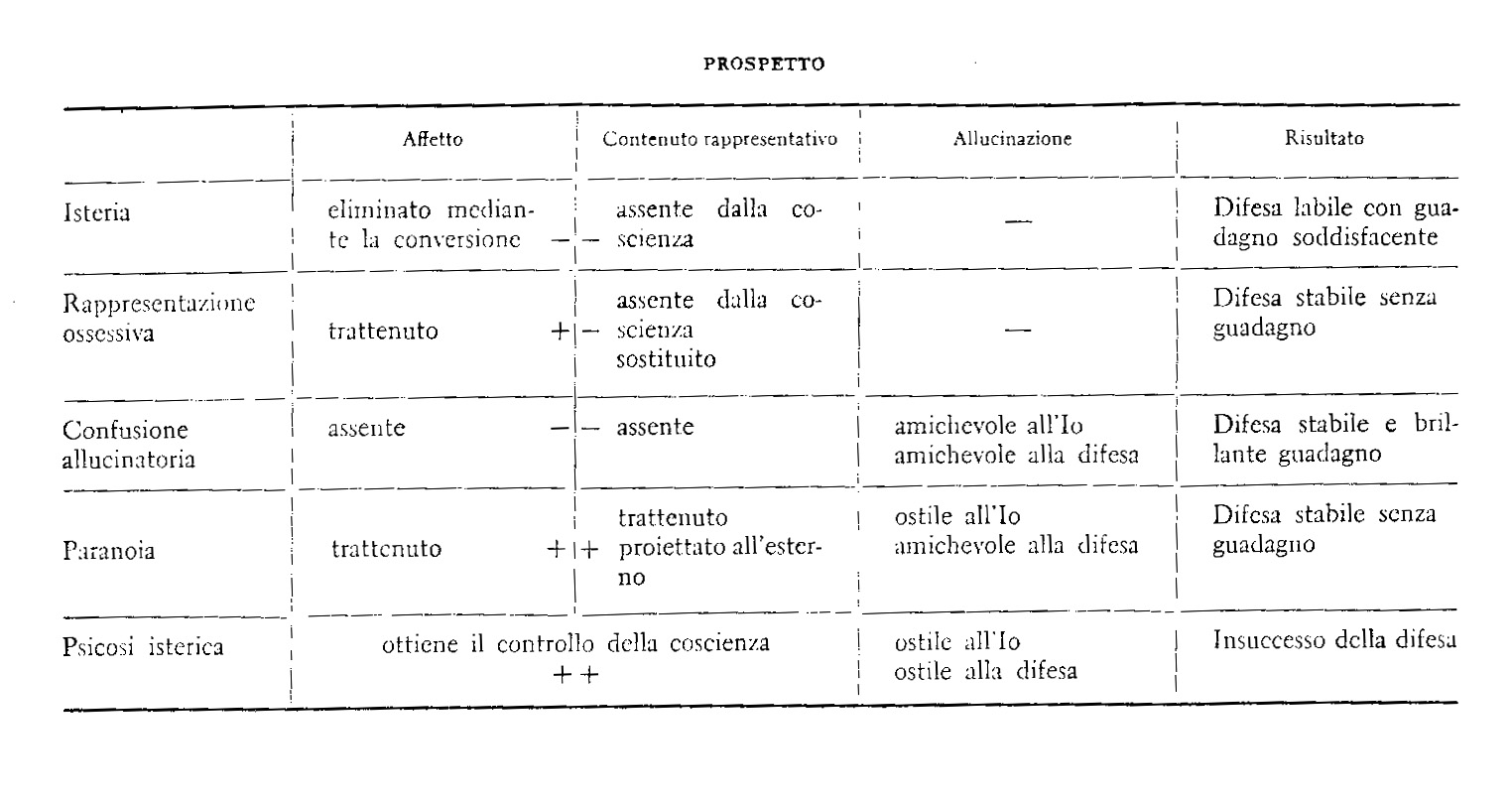 1) Isteria. La rappresentazione incompatibile non è ammessa ad associarsi con l'Io. Il contenuto viene mantenuto escluso, assente dalla coscienza; l'affetto [è eliminato] mediante conversione nel corporeo. Psiconevrosi il solo [risultato]. 2) Rappresentazione ossessiva. Anche qui la rappresentazione incompatibile non è ammessa ad associarsi. L'affetto viene trattenuto: il contenuto viene sostituito. 3) Confusione allucinatoria. L'intera rappresentazione incompatibile — sia l'affetto che il contenuto — è tenuta lontana dall'Io; ciò è possibile solo a prezzo di un distacco parziale dal mondo esterno. Si ricorre ad allucinazioni amichevoli all'Io e che favoriscono la difesa. 4) Paranoia. Il contenuto e l'affetto della rappresentazione incompatibile vengono trattenuti, all'opposto che nel caso 3); ma proiettati all'esterno. Le allucinazioni, che si verificano in alcune forme, sono ostili all'Io, ma favoriscono la difesa. Nelle psicosi isteriche, al contrario, sono precisamente le rappresentazioni respinte che acquistano il predominio. Il tipo è costituito dall'attacco e dall'état secondaire. Le allucinazioni sono ostili all'Io. L'idea delirante è o una copia o l'opposto dell'immagine respinta (delirio di grandezza). [In questo senso] paranoia e confusione allucinatoria sono le due psicosi di "per l'appunto" oppure di "a dispetto di". L'"autoriferimento" della paranoia è analogo alle allucinazioni degli stati confusionali, le quali cercano di affermare l'opposto del fatto respinto ["a dispetto del" dato di fatto]. Allo stesso modo l'autoriferimento tenta continuamente di provare ["per l'appunto"] la veridicità della proiezione. Minuta IEmicrania: punti associati18951. Una questione di sommazione. Intervallo di ore o giorni tra la provocazione e la comparsa dei sintomi. Si ha come la sensazione che un ostacolo venga scavalcato e poi continui un processo. 2. Una questione di sommazione. Anche senza provocazione si ha l'impressione come dell'accumularsi di uno stimolo, presente in piccola quantità all'inizio dell'intervallo e in maggior quantità verso la fine. 3. Una questione di sommazione, nella quale la sensibilità ai fattori etiologici si mantiene all'altezza del livello dello stimolo già presente. 4. Una questione dalla etiologia complessa, che segue forse lo schema della catena etiologica, dove una causa prossima può sorgere direttamente o indirettamente per molti fattori, o lo schema della sommazione etiologica, dove accanto a una causa specifica possono intervenirne altre banali quantitativamente sostitutive. 5. Una questione sul modello dell'emicrania mestruale e appartenente al gruppo sessuale. Prove di ciò: a) molto rara nei maschi sani; b) ristretta al periodo di attività sessuale della vita: quasi escluse l'infanzia e la vecchiaia; e) se si produce per sommazione, anche lo stimolo sessuale è qualcosa che si produce per sommazione; d) l'analogia della periodicità; f) frequenza in persone con scarica sessuale disturbata (nevrastenia, coitus interruptus). 6. È certo che l'emicrania è prodotta da stimoli chimici: tossine del corpo umano, scirocco, stanchezza, odori. Ora, anche lo stimolo sessuale è uno stimolo chimico. 7. Scomparsa dell'emicrania durante la gravidanza, in cui la produzione è probabilmente orientata altrove. Si sarebbe quindi tentati di dire che l'emicrania è una reazione tossica prodotta dalla sostanza sessuale stimolante1 quando questa non trova una scarica sufficiente, e forse si dovrebbe aggiungere che vi è un certo canale, ancora da determinare topicamente, che si trova in condizioni di speciale recettività. Il problema di questo canale è il problema della localizzazione dell'emicrania. 8. Esiste qualche indicazione relativa a tale canale nel fatto che le malattie organiche del cranio, tumori e infiammazioni (senza anelli di congiunzione tossici?) producono emicrania o qualcosa di simile; e anche che l'emicrania è unilaterale, connessa col naso e collegata con localizzati fenomeni di paresi. Il primo di questi segni non è senza ambiguità. L'unilateralità dell'emicrania, la sua localizzazione sopra l'occhio, e il fatto che si complica con focolai di paresi, sono più importanti. 9. Il fatto che l'emicrania sia dolorosa può solo far pensare alle meningi cerebrali, poiché le affezioni della sostanza cerebrale sono certamente indolori. 10. Quando in tal modo l'emicrania tende a diventare nevralgia, tale fatto va d'accordo con la sommazione, con la sensibilità e le sue oscillazioni, col prodursi di nevralgie per stimoli tossici. La nevralgia tossica sarebbe quindi il prototipo fisiologico dell'emicrania. Il pericranio è la sede del suo dolore e il trigemino il suo canale. Poiché tuttavia la modificazione nevralgica può però essere solo centrale, dobbiamo supporre che il centro logico per l'emicrania sia un nucleo trigeminale le cui fibre innervano la dura madre. Poiché il dolore dell'emicrania ha la stessa localizzazione di quelle della nevralgia sopraorbitale, questo nucleo durale deve essere in prossimità del nucleo del primo ramo. Poiché tuttavia i differenti rami e nuclei del trigemino si influenzano, anche tutte le altre affezioni del trigemino possono contribuire all'etiologia [dell'emicrania] come fattori (non banali) concorrenti. La sintomatologia e la posizione biologica dell'emicrania Il dolore di una nevralgia abitualmente defluisce in tensione tonica (persino in spasmo clonico). Non è, quindi, impossibile che l'emicrania possa coinvolgere un'innervazione spastica dei muscoli vascolari nell'area riflessa della regione durale. Possiamo ascrivere a questa innervazione i disturbi funzionali generali, oltre a quelli locali, che non differiscono sintomatologicamente dai disturbi simili che derivano dalla costrizione vascolare (vedi la somiglianza dell'emicrania con gli attacchi di trombosi). Parte dell'inibizione è dovuta al dolore in sé stesso. Si tratta presumibilmente dell'area vascolare del plesso coroideo, che è per primo colpito dallo spasmo di scarica. La relazione con l'occhio e il naso si spiega per il loro comune allacciamento al primo ramo [del trigemino]. Minuta JSignora P. J. Età: 27 anni1895Era sposata da tre mesi. Suo marito, un viaggiatore di commercio, aveva dovuto lasciarla poche settimane dopo il matrimonio ed era assente già da alcune settimane. Essa senti assai la sua mancanza ed ebbe molto desiderio di lui. Era stata cantante 0, per lo meno, aveva ricevuto lezioni di canto. Sedeva un giorno al pianoforte cantando per passare il tempo quando improvvisamente si senti male: disturbi all'addome e allo stomaco, giramenti di testa, sensazioni di oppressione, angoscia e parestesia cardiaca; pensò d'impazzire. Un attimo più tardi le venne in mente che quella mattina aveva mangiato uova e funghi; si ritenne pertanto avvelenata. Il malessere tuttavia scomparve rapidamente. Il giorno seguente la ragazza di servizio le disse che una donna, la quale abitava nella stessa casa, era diventata pazza. Da allora essa non si liberò più dall'ossessione, accompagnata da angoscia, che anche lei sarebbe impazzita. Questo è il caso. Suppongo, dapprima, che si sia trattato di un attacco d'angoscia, una scarica sessuale trasformatasi in angoscia. Un attacco del genere, temevo, può aver luogo senza che vi si congiunga alcun processo psichico. Non voglio, tuttavia, escludere la possibilità più favorevole che si possa andare alla ricerca di questo processo, e anzi ho fissato di farne il punto di partenza del mio lavoro. Mi attendevo di trovare quanto segue. Essa aveva avuto desiderio di suo marito, cioè di relazioni sessuali con lui, imbattendosi cosi in un'idea che aveva eccitato l'emozione sessuale e, in un secondo tempo, una difesa contro di essa; allora si era spaventata e aveva fatto un falso nesso o sostituzione. Dapprima le chiedo le circostanze di contorno dell'avvenimento: qualcosa doveva averle ricordato suo marito. — Cantava l'aria della Carmen: "Sugli spalti di Siviglia..." Gliela faccio ripetere ma essa non ricorda esattamente le parole. "A qual punto le sembra di aver avuto l'attacco?" Non lo sa. — In seguito a mia pressione [sulla sua fronte], dice che era accaduto dopo che aveva finito di cantare l'aria. È possibile: può essersi trattato di una sequenza di pensieri suscitata dalle parole del canto. Asserisco che prima dell'attacco doveva aver avuto dei pensieri che forse non ricorda. Infatti non ricorda nulla, ma la pressione [sulla fronte] produce "marito" e "desiderio". Continuando a insistere, quest'ultimo si precisa come un desiderio di tenerezze sessuali. "Ne sono convinto: il suo attacco non era altro che uno stato di effusione amorosa. Conosce la canzonetta del paggio? Voi che sapete che cosa è amor, Donne, vedete s'io l'ho nel cor... Ma doveva esserci stato qualcosa d'altro, una sensazione nella parte bassa del corpo, un bisogno convulso di urinare." Essa conferma, ora; l'insincerità delle donne inizia con l'omissione dei caratteristici sintomi sessuali quando descrivono i loro stati. In realtà, dunque, era stata una polluzione. "Vede, allora, che un tale stato di desiderio in una giovane donna abbandonata dal marito non può essere nulla di cui vergognarsi? " Al contrario, lei pensa, proprio cosi ha da essere. "Molto bene, ma allora mi manca il motivo dello spavento. 'Marito' e 'desiderio' non possono certo spaventarla, devono perciò mancare, qui, anche altri pensieri più appropriati allo spavento." Ma essa aggiunge soltanto di aver sempre avuto paura del dolore fisico causato dal rapporto sessuale, ma che il suo desiderio era stato molto più forte del timore di quel dolore. A questo punto interrompiamo. 2. È davvero da sospettare che nella prima scena (al pianoforte), oltre ai pensieri nostalgici relativi al marito (da lei ricordati), sia penetrata più addentro una sequenza di pensieri non ricordata, che conduce a una seconda scena. Ma io non so ancora dove trovare un aggancio. Oggi arriva in pianto e disperata, evidentemente senza alcuna fiducia nel successo di questo tipo di terapia. La resistenza è perciò già all'erta e tutto riesce molto più difficile. Voglio sapere quali pensieri fossero ancora capaci di spaventarla. Essa enumera ogni genere di cose, ma senza importanza a questo riguardo. Che per lungo tempo non era stata deflorata (cosa che il professor Chrobak le aveva confermato); che a ciò attribuiva il suo nervosismo, e aveva quindi desiderato che la deflorazione si compisse. — Si trattava naturalmente di un'idea posteriore. Fino all'epoca della prima scena era stata in buona salute. Finalmente ottengo l'informazione che essa ha già avuto un simile attacco con le stesse sensazioni, ma molto più debole e transitorio. (Da ciò io scorgo che il cammino che conduce nel profondo parte proprio dall'immagine mnestica della polluzione.) Poi passiamo a quella scena. A quel tempo — quattro anni addietro — era stata scritturata a Ratisbona; aveva cantato in una prova, la mattina, ed era piaciuta. Nel pomeriggio, in casa, aveva avuto una "visione", come se "vi fosse stato qualcosa" (una lite) tra lei, il tenore della compagnia e un altro uomo, e in seguito aveva avuto l'attacco con la paura d'impazzire. Qui, dunque, si ha una seconda scena, che era stata sfiorata per associazione nella prima. Dobbiamo riconoscere che anche qui vi sono delle lacune nella memoria. Altre rappresentazioni dovevano figurarvi, concorrendo a giustificare in essa la scarica sessuale e lo spavento. Domando di questi anelli intermedi, ma invece ricevo motivazioni da parte sua. La vita di teatro, nel suo insieme, non le era piaciuta. "Perché?" Per la rudezza del direttore e i rapporti reciproci fra gli attori. Chiedo particolari su quest'ultimo punto. C'era una vecchia attrice comica che i giovani si divertivano a canzonare chiedendole se potevano passare la notte con lei. "Avanti, qualcosa a proposito del tenore." Egli aveva infastidito anche lei; alla prova le aveva messo una mano sul petto. "Attraverso i vestiti o sulla nuda pelle?" Essa conferma dapprima la seconda versione, poi si ricrede; era vestita da passeggio. "Bene, che c'è d'altro?" Tutto quel tipo di rapporto, quell'abbracciarsi e baciarsi fra colleghi era per lei spaventoso. "E poi?" Di nuovo la rudezza del direttore; del resto c'era rimasta soltanto pochi giorni. "L'assalto del tenore era avvenuto nello stesso giorno del suo attacco?" No; non sa se sia accaduto prima o dopo. Le indagini col mezzo della pressione rivelano che l'assalto era accaduto nel quarto giorno della sua permanenza e l'attacco nel sesto. Interrotto per fuga della paziente. Minuta KLe nevrosi da difesa (Favola di Natale)1895Ne esistono quattro tipi e molte forme. Io posso solo mettere a confronto l'isteria, la nevrosi ossessiva e una forma di paranoia. Esse hanno varie cose in comune. Sono aberrazioni patologiche di normali stati affettivi psichici: di conflitto (isteria), di autoaccusa (nevrosi ossessiva), di mortificazione (paranoia) e di lutto (amenza allucinatoria acuta). Esse differiscono da questi affetti perché non conducono ad alcuna eliminazione ma a un'offesa permanente dell'Io. Sono causate dagli stessi motivi dei loro prototipi affettivi, quando per il motivo si adempiano due altre condizioni, che esso sia di natura sessuale e che si verifichi in un periodo anteriore alla maturità sessuale (condizioni della sessualità e dell'infantilismo). Sulle condizioni della persona non mi è noto nulla di nuovo; direi in generale che l'ereditarietà è un'ulteriore condizione, in quanto facilita e aumenta l'affetto patologico; è cioè quella condizione che soprattutto rende possibili le gradazioni tra la normalità e gli estremi. Non credo che l'ereditarietà determini la scelta della nevrosi da difesa. Vi è una normale tendenza alla difesa, cioè un'avversione a dirigere l'energia psichica in modo da produrre dispiacere. Questa tendenza, connessa coi più fondamentali attributi del meccanismo psichico (la legge della costanza), non può essere diretta contro le percezioni, poiché queste sono capaci di svegliare l'attenzione (come è dimostrato dal fatto che sono consce); essa agisce solamente nei riguardi dei ricordi e delle rappresentazioni mentali. È innocua ove si tratti di rappresentazioni alle quali un tempo era legato dispiacere, ma incapaci di suscitare dispiacere attuale (altro dal dispiacere ricordato); anche in tali casi, essa può essere sopraffatta dall'interesse psichico. La tendenza alla difesa è però dannosa se è diretta verso rappresentazioni capaci, come ricordi, di liberare nuovo dispiacere, com'è il caso delle rappresentazioni sessuali. Qui, in realtà, si realizza l'unica possibilità di un ricordo che abbia successivamente una capacità liberante maggiore di quella prodotta dall'esperienza a esso corrispondente. È solo necessario, per questo, che tra l'esperienza e la sua ripetizione nella memoria si inserisca la pubertà, la quale intensifica di molto l'effetto del risvegliarsi mnemonico. Il meccanismo psichico sembra impreparato a questa eccezione, ed è di conseguenza condizione indispensabile, per non incorrere nelle nevrosi da difesa, che non si sia verificata prima della pubertà una considerevole irritazione sessuale, l'effetto della quale tuttavia, per giungere a livello patologico, deve essere accresciuto da una predisposizione ereditaria. (A questo punto si apre un problema collaterale: come accade che in condizioni analoghe insorgano, invece della nevrosi, perversione o semplice immoralità?) Ben addentro agli enigmi psicologici conduce l'indagine sull'origine del dispiacere, che sembra venir liberato dalla stimolazione sessuale precoce e senza il quale, d'altronde, non si può spiegare una rimozione. La risposta più plausibile si rifa alla costatazione che la vergogna e la moralità sono le forze rimoventi, e che la prossimità in cui si trovano per natura gli organi sessuali non può non destare, al momento delle esperienze sessuali, anche il disgusto. Dove non esiste vergogna (come nelle persone di sesso maschile) o non c'è moralità (come nelle classi popolari più basse), dove il disgusto è smussato dalle condizioni dell'esistenza (come in campagna), non ci sarà alcuna rimozione, e quindi nessuna nevrosi risulterà dalla stimolazione sessuale infantile. Nondimeno io temo che questa spiegazione non regga a un esame più profondo. Non credo che la liberazione di dispiacere durante le esperienze sessuali sia il risultato di una fortuita mescolanza di certi fattori spiacevoli. L'esperienza di ogni giorno ci insegna che se la libido è sufficientemente grande non si prova disgusto e la morale viene superata, e ritengo che l'insorgere della vergogna sia connesso con l'esperienza sessuale mediante legami più profondi. La mia opinione è che vi debba essere una fonte indipendente che libera dispiacere nella vita sessuale: se questa fonte è presente, essa può attivare sensazioni di disgusto, rafforzare la moralità e cosi via. Mi riferisco al modello della nevrosi d'angoscia negli adulti, dove parimenti una quantità proveniente dalla vita sessuale che, altrimenti, avrebbe trovato altra utilizzazione nel processo sessuale provoca un disturbo nella sfera psichica. Fintantoché non possederemo una teoria esatta del processo sessuale, la questione dell'origine del dispiacere, attivo nella rimozione, rimarrà irrisolta. Il corso della malattia nelle nevrosi da difesa è in generale sempre lo stesso: 1) l'esperienza sessuale (oppure la serie di esperienze) traumatica, prematura, che è da rimuovere; 2) la rimozione di questa esperienza in un'occasione posteriore che ne ridesta il ricordo, e nello stesso tempo la formazione di un sintomo primario; 3) una fase di difesa riuscita, che assomiglia alla salute, eccetto per l'esistenza del sintomo primario; 4) la fase in cui le rappresentazioni rimosse ritornano, ove durante la lotta tra queste e l'Io si formano nuovi sintomi, quelli della vera malattia, cioè una fase di adeguamento, di sopraffazione o di guarigione che reca in sé un difetto.2 Le principali differenze tra le singole nevrosi si rivelano nel modo in cui ritornano le rappresentazioni rimosse, altre si mostrano nella formazione dei sintomi e nel decorso della malattia. Ma il carattere specifico delle diverse nevrosi risiede nelle modalità di esecuzione della rimozione. Il procedimento più chiaro per me è quello della nevrosi ossessiva, poiché è la nevrosi che ho imparato a conoscere meglio. La nevrosi ossessiva In questo caso l'esperienza primaria si è accompagnata al piacere. Essa può essere stata attiva (nei bambini) 0 passiva (nelle bambine) senza perciò mescolarsi a dolore o a disgusto, il che nelle bambine implica in generale già una certa età (circa 8 anni). Questa esperienza, quando viene più tardi richiamata alla memoria, dà luogo a una liberazione di dispiacere, e precisamente sorge per prima un'autoaccusa, che è conscia. In realtà sembra che tutto il complesso psichico, ricordo e autoaccusa, sia dapprima cosciente. Più tardi, senza alcun nuovo avvenimento, vengono entrambi rimossi e in loro vece si forma nella coscienza un sintomo di contrasto: una certa sfumata scrupolosità. La rimozione può verificarsi perché il ricordo del piacere, quando viene riprodotto in età più avanzata, libera di per sé dispiacere, cosa che sarebbe da spiegare con una teoria della sessualità. Ma le cose possono avvenire anche in altro modo. In tutti i miei casi di nevrosi ossessiva vi è stata a un'età molto precoce, anni prima dell'esperienza di piacere, un'esperienza puramente passiva, e questo non può essere un fatto accidentale. Se è cosi, possiamo ritenere che sia il successivo scontrarsi di questa esperienza passiva con quella di piacere, a sovrapporre il dispiacere al ricordo del piacere e a rendere possibile la rimozione. In tal caso sarebbe una condizione clinica necessaria della nevrosi ossessiva che l'esperienza passiva si verifichi cosi presto da non poter impedire la formazione spontanea dell'esperienza di piacere. La formula sarebbe dunque: Dispiacere-piacere-rimozione. Il fattore determinante sarebbe la relazione cronologica delle due esperienze tra di loro e con la data della maturità sessuale. Nella fase del ritorno del rimosso, risulta che l'autoaccusa torna inalterata, ma raramente in modo da attrarre l'attenzione su di sé, restando perciò, per un certo tempo, come un puro senso di colpa senza contenuto. Essa di solito procede a collegarsi con un contenuto che è doppiamente distorto: quanto al tempo e all'oggetto; quanto al primo, perché viene riferito a un'azione contemporanea o futura, e quanto al secondo perché non significa l'evento reale, bensì un surrogato secondo la categoria dell'analogo, una sostituzione. Cosi la rappresentazione ossessiva è un prodotto di compromesso, esatto per quanto riguarda l'affetto e la categoria, ma falso per spostamento cronologico e sostituzione analogica. L'affetto d'autoaccusa si può trasformare, attraverso vari stati psichici, in altri affetti che, poi, penetrano nella coscienza più distintamente: per esempio in angoscia (relativa alle conseguenze dell'azione alla quale si applica l'autoaccusa), in ipocondria (paura dei suoi effetti somatici), in deliri di persecuzione (paura delle sue conseguenze sociali), in vergogna (paura che la gente sappia), e cosi via. L'Io cosciente sta di fronte alla rappresentazione ossessiva come a qualcosa di estraneo e non le presta fede, aiutato, sembra, dalla rappresentazione contrastante di scrupolosità formatasi molto tempo prima. In questo stadio l'Io può, di tanto in tanto, essere sopraffatto dall'ossessione, come, per esempio, quando è colpito da una forma di melanconia episodica. A parte questo, tutto lo stadio della malattia è occupato dalla lotta difensiva dell'Io contro l'ossessione; e ciò può produrre di per sé stesso nuovi sintomi, i sintomi della difesa secondaria. La rappresentazione ossessiva viene attaccata, come qualsiasi altra, dalla logica, quantunque la sua forza coattiva non possa essere vinta; i sintomi secondari sono un'intensificazione della scrupolosità, una coazione all'esame e alla conservazione. Altri sintomi secondari insorgono quando la coazione è trasferita agli impulsi motori diretti contro l'ossessione; come per esempio al rimuginare, al bere (dipsomania), al cerimoniale protettivo, alla folie du doute. Qui si giunge, quindi, alla formazione di tre specie di sintomi: a) il sintomo primario di difesa: scrupolosità; b) i sintomi di compromesso della malattia: ossessioni o affetti ossessivi; c) i sintomi secondari di difesa: rimuginare ossessivo, conservare ossessivo, dipsomania, cerimoniale ossessivo. Quei casi, nei quali il contenuto del ricordo non è diventato ammissibile alla coscienza per mezzo di una sostituzione, ma è diventato ammissibile l'affetto d'autoaccusa in seguito a trasformazione, danno l'impressione di uno spostamento avvenuto lungo una catena di deduzioni. Io mi rimprovero di qualche cosa — ho paura che altre persone sappiano — mi vergogno quindi di fronte agli altri. Una volta rimosso il primo anello di questa catena, l'ossessione salta al secondo o terzo anello e ne risultano due forme di delirio di attenzione, le quali però, di fatto, appartengono alla nevrosi ossessiva. La lotta difensiva sbocca in una generalizzata mania del dubbio o nello sviluppo di una vita eccentrica con un numero indefinito di sintomi di difesa secondaria, se un tale sbocco ha successo. Rimane aperto il problema se le rappresentazioni rimosse ritornino da sole, senza l'aiuto di nessuna forza psichica attuale, oppure se ne abbiano bisogno come spinta per ritornare. Le mie esperienze indicano la seconda alternativa. Sembra che gli stati di libido attuale insoddisfatta usino la forza del loro dispiacere per risvegliare l'autoaccusa rimossa. Una volta che tale risveglio abbia avuto luogo e in conseguenza dell'influsso del rimosso sull'Io si sia formato un sintomo, il materiale rappresentativo rimosso naturalmente continua a operare per proprio conto, ma non cessa di dipendere, nelle oscillazioni della sua potenza quantitativa, dall'importo di tensione libidica presente in ogni momento. La tensione sessuale che, venendo soddisfatta, non ha tempo di convertirsi in dispiacere, non produce danno. I nevrotici ossessivi sono individui soggetti al pericolo che tutta la tensione sessuale che si genera in loro ogni giorno alla fine si converta in autoaccusa, o piuttosto in sintomi che da questa derivano, anche se al presente non riconoscerebbero l'autoaccusa primaria. La cura delle nevrosi ossessive può avere successo se noi annulliamo tutte le sostituzioni e le trasformazioni di affetto che hanno avuto luogo, finché l'autoaccusa primaria e l'esperienza alla quale essa appartiene possano essere liberate e collocate di fronte all'Io cosciente per un nuovo giudizio. Nel fare questo è necessario destreggiarsi attraverso un incredibile numero di rappresentazioni intermedie o di compromesso, le quali diventano ossessioni temporanee. Da ciò traiamo la più viva convinzione che è impossibile per l'Io dirigere sul rimosso quella parte di energia psichica cui è legato il pensiero cosciente. Le rappresentazioni rimosse, cosi è da credere, sono presenti e s'inseriscono senza inibizioni nell'esatto collegamento d'idee; la più semplice allusione è sufficiente, però, per risvegliarne il ricordo. Il sospetto che la "moralità" quale potenza rimovente sia solo un pretesto, è confermato dall'esperienza poiché, durante il lavoro terapeutico, la resistenza fa uso di ogni possibile motivo di difesa. Paranoia Mi sono ancora sconosciuti le condizioni cliniche e i rapporti di tempo di piacere e dispiacere nell'esperienza primaria. Ciò che io ho riconosciuto è il fatto della rimozione, il sintomo primario, lo stadio della malattia in quanto determinato dal ritorno delle rappresentazioni rimosse. L'esperienza primaria sembra essere dì natura simile a quella delle nevrosi ossessive; la rimozione si verifica dopo che il ricordo, non si sa come, ha liberato dispiacere. Non si forma, tuttavia, alcuna autoaccusa poi rimossa, ma il dispiacere che insorge viene rivolto sul prossimo in accordo allo schema psichico della proiezione. Il sintomo primario che si forma è la diffidenza (ipersensitività verso gli altri). Con ciò è tolta fede all'autoaccusa. Si suppone l'esistenza di forme diverse, a seconda che solo l'affetto sia stato rimosso mediante la proiezione 0 anche il contenuto dell'esperienza, insieme con esso. Pertanto ciò che ritorna può essere l'affetto penoso da solo, o accompagnato dal ricordo. Nel secondo caso, che è l'unico che conosco abbastanza bene, il contenuto dell'esperienza ritorna come un pensiero improvviso 0 come allucinazione visiva 0 sensoria. L'affetto rimosso sembra invariabilmente tornare sotto la forma di allucinazioni di voci. I pezzi di memoria che ritornano sono distorti in quanto sostituiti con immagini analoghe del presente; cioè distorti solo mediante una sostituzione nel tempo e non mediante la formazione di un surrogato. Le voci, similmente, richiamano l'autoaccusa sotto forma di un sintomo di compromesso; cioè, in primo luogo, distorte nell'espressione verbale al punto di divenire indecifrabili e trasformate in minacce, in secondo luogo riferite, invece che all'esperienza primaria, proprio alla diffidenza, ossia al sintomo primario. Poiché è stata tolta fede all'autoaccusa primaria, essa è senza limiti alla mercé dei sintomi di compromesso. L'Io non sta di fronte a essi come a cose estranee, ma è incitato da essi a compiere tentativi di chiarificazione, che si potrebbero descrivere come delirio di assimilazione. A questo punto, con il ritorno in forma distorta del rimosso, la difesa è subito fallita, e il delirio di assimilazione non può essere considerato come un sintomo di difesa secondaria, ma come l'inizio di una alterazione dell'Io, come espressione della sua sopraffazione. Il processo raggiunge la sua conclusione sia nella melanconia (senso della piccolezza dell'Io) — nella quale la fiducia rifiutata all'autoaccusa primaria è, secondariamente, accordata alle distorsioni — sia, ciò che è più frequente e grave, nella formazione di un delirio protettivo (delirio di grandezza), finché l'Io sia rimodellato completamente. L'elemento determinante della paranoia è il meccanismo di proiezione accompagnato dal rifiuto di credere all'autoaccusa. Di qui, le caratteristiche generali della nevrosi: il significato delle voci come il mezzo con il quale gli altri ci influenzano, nonché dei gesti che ci rivelano la loro vita mentale; e l'importanza del tono del discorso e delle allusioni, dato che il diretto riferimento del contenuto dei discorsi al ricordo rimosso è inammissibile alla coscienza. Nella paranoia la rimozione ha luogo dopo che si è avuto un complicato processo cosciente di pensiero (rifiuto di credere). Questo fatto può forse indicare che si è verificata in un'età più avanzata di quanto avvenga nella nevrosi ossessiva e nell'isteria. Le premesse della rimozione sono senza dubbio le stesse. Rimane del tutto da determinare se il meccanismo della proiezione risieda interamente nella disposizione individuale, o se venga scelto secondo particolari fattori temporali e occasionali. Quattro specie di sintomi: a) sintomi primari di difesa, b) sintomi di compromesso del ritorno, e) sintomi secondari di difesa, d) sintomi della sopraffazione dell'Io. Isteria L'isteria necessariamente presuppone un'esperienza primaria di dispiacere, cioè di natura passiva. La naturale passività sessuale delle donne spiega perché esse siano più inclini all'isteria. Ogni volta che ho riscontrato l'isteria negli uomini ho potuto notare una notevole passività sessuale nella loro anamnesi. Un'ulteriore condizione dell'isteria è che l'esperienza primaria di dispiacere non si verifichi prematuramente, allorché la liberazione di dispiacere è ancora troppo scarsa e quando, com'è ovvio, possono ancora succedere eventi piacevoli; si addiviene allora solo alla formazione di ossessioni. Per questo motivo, negli uomini, spesso troviamo la combinazione di entrambe le nevrosi, o la sostituzione di un'isteria iniziale con una successiva nevrosi ossessiva. L'isteria comincia con la sopraffazione dell'Io, la paranoia vi conduce alla fine. La tensione è tanto elevata durante l'esperienza primaria di dispiacere, che l'Io non le resiste e non costruisce alcun sintomo psichico, ma è costretto a permettere una manifestazione di scarica: di solito un'eccessiva espressione dell'eccitamento. Questo primo stadio dell'isteria può essere definito come isteria da spavento; il suo sintomo primario è la manifestazione di spavento accompagnata da una lacuna psichica. Non si sa ancora fino a quale età possa aver luogo questa prima sopraffazione isterica dell'Io. Solo più tardi, in relazione con il ricordo, si verificano la rimozione e la formazione dei sintomi di difesa, e da allora in poi nell'isteria la difesa e la sopraffazione, cioè la formazione di sintomi e lo scatenarsi di attacchi, possono combinarsi liberamente tra essi. La rimozione non ha luogo mediante la formazione di una rappresentazione sovraintensa di contrasto,1 ma mediante l'intensificazione di una rappresentazione di frontiera, la quale d'ora in poi sostituisce nel decorso del pensiero il ricordo rimosso. Può dirsi una rappresentazione di frontiera perché da un lato appartiene all'Io cosciente e dall'altro forma un pezzo non distorto del ricordo traumatico. Quindi, ancora una volta, è il risultato di un compromesso, il quale, tuttavia, non si manifesta in una sostituzione secondo qualche categoria topica, ma in uno spostamento dell'attenzione su di una serie di rappresentazioni collegate [al ricordo] per ragioni di contemporaneità. Se l'evento traumatico ha trovato uno sfogo per sé in una manifestazione motoria, sarà questa a diventare la rappresentazione di frontiera e il primo simbolo del rimosso. Non vi è quindi bisogno di ammettere che una rappresentazione venga repressa ogni volta che l'attacco primario si ripete; si tratta in primo luogo di una lacuna nello psichico. Minuta L1897Architettura dell'isteriaLo scopo sembra sia quello di arrivare alle scene primarie.2 In alcuni casi vi si perviene direttamente, in altri solo per via indiretta attraverso le fantasie. Le fantasie infatti sono facciate psichiche costruite per sbarrare l'ingresso a questi ricordi.3 Nello stesso tempo, le fantasie sono al servizio della tendenza ad affinare i ricordi, a sublimarli. Esse sono costruite sulla base di cose udite e, successivamente, utilizzate; e quindi combinano esperienze vissute e cose udite, fatti passati (dalle vicende dei genitori e degli antenati) e cose viste coi propri occhi. Si comportano con le cose udite come i sogni con le cose viste. Infatti, nei sogni non sentiamo nulla, ma vediamo. Ruolo delle ragazze di servizio Dalla identificazione [da parte della donna] con queste persone di bassa morale, ricordate come materiale femminile di nessun valore tanto spesso in relazione sessuale col padre e col fratello, scaturisce un enorme peso sulla coscienza, con autoaccuse (furti, aborti); e in seguito alla sublimazione di queste ragazze nelle fantasie, figurano in queste stesse fantasie accuse assai inverosimili contro altre persone. Hanno come riferimento le ragazze di servizio anche la paura di divenir prostitute (paura di camminare sole per la strada), la paura che un uomo sia nascosto sotto il letto, e cosi via. Vi è una tragica giustizia nel fatto che la condiscendenza del capofamiglia per la domestica venga espiata dall'autoumiliazione della figlia. Funghi Una ragazza, l'estate scorsa, aveva paura di cogliere un fiore o persino un fungo, perché ciò andava contro il comandamento di Dio che non vuole che i germi di vita siano distrutti. All'origine di questo sta il ricordo di massime religiose della madre contro le precauzioni durante il coito, poiché esse portano alla distruzione di germi vitali. Le "spugne" (spugnette di Parigi) erano esplicitamente menzionate a questo riguardo. L'identificazione con la madre era il contenuto principale della nevrosi. Dolori Non sono direttamente la sensazione di fissazione, ma la deliberata ripetizione di essa. Il bambino urta contro uno spigolo, un mobile ecc., e cosi mette i suoi genitali a contatto con esso, per ripetere una scena nella quale la parte che è ora dolorante, ed era stata allora premuta contro lo spigolo, ha servito alla fissazione. Molteplicità delle personalità psichiche Il fatto dell'identificazione permette forse di prendere questa frase alla lettera. Avvolgere Continuazione della storia del fungo. La ragazza esigeva che ogni oggetto che le veniva porto fosse avvolto. (Condom.) Differenti redazioni di fantasie. C'è anche ricollegamento [all'esperienza originale]? Quando un paziente desidera essere ammalato e si aggrappa ai suoi dolori, ciò avviene regolarmente perché la sofferenza viene considerata come arma protettiva contro la propria libido, e cioè perché non ha fiducia in sé stesso. In questa fase il sintomo mnestico diventa sintomo difensivo: le due correnti attive si uniscono. In precedenti stadi il sintomo era una conseguenza della libido, un sintomo provocatorio; può darsi che, fra di essi, le fantasie servano alla difesa. È possibile seguire via, tempo e materiale di formazione delle fantasie, formazione che è poi del tutto simile a quella dei sogni, solo che non vi è alcuna regressione1 ma soltanto una progressione nella raffigurazione. [Rapporto] tra sogni, fantasie e riproduzione. Ancora un sogno di desiderio "Questo dev'essere un sogno di desiderio", dice E. "Sognai che, proprio mentre arrivavo a casa con una signora, venivo arrestato da un poliziotto che m'intimava di salire su una carrozza. Gli ho chiesto di darmi il tempo di sistemare i miei affari eccetera." — "Altri dettagli?" — "Ho fatto il sogno al mattino, dopo che avevo trascorso la notte con questa signora." — "Era molto spaventato?" — "No." — "Sa di che cosa lo si accusasse?" — "Si, di aver ucciso un bambino." — "C'è un rapporto con qualcosa di reale?" — "Ho avuto una volta la responsabilità di un aborto in seguito a una relazione, e non ci torno volentieri col pensiero." — "Bene, non era accaduto nulla durante la mattina, prima che facesse il sogno?" — "Si, mi ero svegliato e avevo avuto un coito." — "Con precauzioni?" — "Si, ritirandomi." — "Dunque aveva paura di aver fatto un bambino e il sogno mostra il compimento del suo desiderio che nulla fosse accaduto, di aver cioè soffocato il bambino in germe. Lei ha impiegato l'eccitamento angoscioso che deriva da questo genere di coito come materiale onirico." Minuta M1897Architettura dell'isteria Probabilmente è cosi: alcune scene sono accessibili direttamente, altre solo attraverso le fantasie sovrapposte.2 Le scene sono ordinate secondo l'aumento della resistenza: quelle più leggermente rimosse vengono alla luce prima, ma solo in modo incompleto a causa della loro associazione con quelle severamente rimosse. Il cammino seguito dal lavoro [di analisi] scende a spirale dapprima alle scene 0 alle loro immediate vicinanze; poi, da un sintomo, più sotto; quindi di nuovo da un sintomo, ancora più in basso. Poiché la maggioranza delle scene converge solamente su pochi sintomi, il nostro cammino segue ripetute spirali attraverso i pensieri di fondo dei medesimi sintomi [fig. 4].  Rimozione È da sospettare che l'elemento propriamente rimosso sia sempre il femminile; ed è confermato dal fatto che le donne, non meno degli uomini, ammettono più facilmente esperienze con donne piuttosto che con uomini. Ciò che gli uomini propriamente rimuovono è l'elemento pederastico. Fantasie Le fantasie insorgono dall'intreccio inconscio di cose sperimentate e udite, secondo certe inclinazioni. Queste inclinazioni mirano a rendere inaccessibile il ricordo dal quale i sintomi si sono generati o possono generarsi. La formazione di fantasie avviene per fusione e distorsione, in modo analogo alla decomposizione di un corpo chimico che deve combinarsi con un altro. Il primo tipo di distorsione consiste in una falsificazione del ricordo mediante frammentazione, ove sono trascurati soprattutto i rapporti cronologici (le correzioni cronologiche sembrano propriamente dipendere dall'attività del sistema della coscienza '). Un frammento di cosa vista è poi congiunto con un frammento di cosa udita, a formare una fantasia, mentre il frammento lasciato libero va incontro a un altro legame. In questo modo una loro connessione originaria non può più essere rintracciata. Attraverso la costruzione di fantasie di questo genere (in periodi di eccitamento) i sintomi mnestici cessano. Al loro posto si presentano drammatizzazioni inconsce che non sono soggette alla difesa. Se l'intensità di tale fantasia aumenta al punto da minacciare di forzare l'ingresso nella coscienza, la fantasia soggiace alla rimozione e si genera un sintomo per riflusso impetuoso dalla fantasia sui ricordi che la costituiscono. Tutti i sintomi di angoscia (fobie) derivano in questo modo dalle fantasie. Cosi, tuttavia, semplifichiamo i sintomi. Un terzo movimento in avanti e un terzo modo di formare i sintomi, proviene forse dalla formazione di impulsi. Tipi di spostamenti di compromesso Spostamento per associazione: isteria. Spostamento per somiglianza (concettuale): nevrosi ossessiva, caratteristica per il luogo della difesa (forse anche per il tempo). Spostamento causale: paranoia. Decorso tipico Vi sono buone ragioni per sospettare che il risveglio del rimosso non sia lasciato al caso ma segua le leggi dello sviluppo. Inoltre, che la rimozione proceda all'indietro partendo dal materiale recente e colpisca prima gli ultimi eventi. Differenza tra le fantasie nell'isteria e nella paranoia Queste ultime sistematiche, tutte in armonia; le prime, indipendenti le une dalle altre, anche contraddittorie, dunque isolate, sorte come automaticamente (per via chimica). Questo, e l'indifferenza per le caratteristiche cronologiche, sono senza dubbio essenziali per distinguere tra l'attività nel preconscio e nell'inconscio. Rimozione nell'inconscio Non è sufficiente prendere in considerazione la rimozione tra il preconscio e l'inconscio, bensì anche la normale rimozione all'interno del sistema inconscio stesso. Molto importante, ma ancora assai oscuro. È la più bella delle speranze, quella di poter determinare il numero e la specie delle fantasie cosi come possiamo fare con le "scene". Un romanzo di estraniamento (vedi la paranoia1), quale si trova abitualmente, serve a illegittimare i parenti ai quali ci si riferisce. L'agorafobia sembra dipendere da un romanzo di prostituzione, che anch'esso di nuovo riconduce a questo romanzo familiare. Una donna che non vuole uscire da sola afferma, quindi, l'infedeltà della madre. Minuta1897Impulsi Gli impulsi ostili verso i genitori (desiderio della loro morte) sono anch'essi parte integrante delle nevrosi. Essi si rivelano alla coscienza sotto forma di rappresentazioni ossessive. Nella paranoia, ciò che vi è di più malvagio nel delirio di persecuzione (diffidenza patologica verso governanti e monarchi) corrisponde a questi impulsi. Essi vengono rimossi in periodi nei quali è viva la compassione per i genitori, al momento di una loro malattia o della loro morte. Allora, è una manifestazione del lutto farsi rimproveri per la loro morte (la cosiddetta "melanconia") 0 punirsi in modo isterico, tramite l'idea della retribuzione, ammalandosi della loro stessa malattia. L'identificazione che ha cosi luogo non è altro, come possiamo vedere, che un modo di pensare e non rende superfluo indagarne il motivo. Sembra che nei figli questo desiderio di morte sia diretto verso il padre e nelle figlie verso la madre. La giovane domestica ne opera la traslazione augurando la morte alla sua padrona in modo che il padrone la possa sposare (vedi il sogno di Lisi su Martha e me). Rapporto tra impulsi e fantasie I ricordi sembrano biforcarsi: una parte viene scartata e sostituita da fantasie, un'altra parte, più accessibile, sembra condurre direttamente a impulsi. È forse possibile che, in seguito, scaturiscano impulsi anche dalle fantasie? Analogamente, la nevrosi ossessiva e la paranoia potrebbero derivare ex aequo dall'isteria, ciò che spiegherebbe l'incompatibilità di queste due affezioni. Trasferimento della certezza Credere (o dubitare) è un fenomeno che appartiene interamente al sistema dell'Io (C) e non riguarda minimamente l'Inc. Nelle nevrosi la certezza è spostata, rifiutata al rimosso che cerchi di riprodursi, e come per punizione trasferita al materiale difensivo. Titania, che non vuole amare Oberon, suo marito legittimo, deve per questo riversare il suo amore su un asino, oggetto della sua fantasia. Poesia e "fine frenzy" Il meccanismo della creazione poetica è lo stesso delle fantasie isteriche. Goethe uni in Werther qualcosa di vissuto, il suo amore per Lotte Kastner, e qualcosa di cui aveva sentito parlare, il destino del giovane Jerusalem, morto suicida. Probabilmente accarezzò l'idea di suicidarsi e in questo trovò un punto di contatto e s'identificò con Jerusalem, a cui prestò i suoi motivi, derivati dalla sua storia d'amore. Per mezzo di questa fantasia egli si protesse contro le conseguenze della sua esperienza. Cosi Shakespeare aveva ragione di accostare poesia e delirio (fine frenzy). Motivi della formazione dei sintomi Ricordare non è mai un motivo, ma solo una via, un metodo. Cronologicamente, il primo motivo per la formazione dei sintomi è la libido. Quindi il sintomo, come il sogno, è un appagamento di desiderio. In stadi più tardivi la difesa contro la libido ha occupato un posto anche nell'Inc. L'appagamento di desiderio deve accontentare questa difesa inconscia. Ciò si verifica quando un sintomo, sotto forma di punizione (per un maligno impulso) o di sfiducia, può agire come autoimpedimento. I motivi della libido e dell'appagamento di desiderio sotto forma di punizione si sommano. Alla tendenza generale verso l'abreazione e l'irruzione del rimosso, qui evidente, si uniscono gli altri due motivi. Parrebbe che, negli stadi più tardivi, da una parte si spostino complicate strutture psichiche (impulsi, fantasie, motivi) dai ricordi, dall'altra parte la difesa, proveniente dal Prec (l'Io), si insinui nell'inconscio, rendendo anche la difesa multiloculare. La formazione dei sintomi per mezzo dell'identificazione è legata alle fantasie, cioè alla loro rimozione nell'Inc, analogamente all'alterazione dell'Io nella paranoia. Poiché lo scoppio dell'angoscia è legato a queste fantasie rimosse, dobbiamo concludere che la trasformazione della libido in angoscia non si verifica per la difesa tra Io e Inc, ma nell'Inc stesso. Esiste perciò anche una libido di Inc. La rimozione degli impulsi non sembra generare angoscia, bensì depressione: melanconia. Quindi le melanconie si ricollegano alle nevrosi ossessive. Definizione del "sacro" Il "sacro" si basa sul fatto che gli uomini hanno sacrificato, per il vantaggio di una più vasta comunità, una parte della loro libertà sessuale e di perversione L'orrore dell'incesto (qualcosa di empio) è basato sul fatto che, formando una comunità sessuale (anche in epoca infantile), i membri di una famiglia rimarrebbero permanentemente uniti e incapaci di legarsi a estranei. Quindi l'incesto è antisociale, e la civilizzazione consiste in questa progressiva rinuncia. Al contrario: il "superuomo".
|