7. La psicologia dei processi onirici |
|
Tra i sogni che mi sono stati raccontati da altre persone, ce n'è uno che merita particolarmente di richiamare a questo punto la nostra attenzione. Mi fu raccontato da una paziente che lo aveva sentito durante una conferenza sui sogni: la sua fonte effettiva mi è ancora sconosciuta. Tuttavia il suo contenuto fece impressione sulla signora, che lo sognò a sua volta, cioè ripetè alcuni dei suoi elementi in un sogno proprio, in modo da poter esprimere, appropriandosene, il suo accordo con esso su un punto particolare. Le premesse di questo sogno esemplare sono le seguenti. Un padre aveva vegliato per giorni e notti accanto al letto del figlio ammalato. Quando il bambino morì, egli andò nella stanza accanto per riposarsi, ma lasciò la porta aperta in modo da poter vedere dalla sua stanza da letto la stanza in cui era composto il corpo del bambino, circondato da alte candele. Era stato preso un vecchio che continuasse la veglia e che sedeva vicino al corpo mormorando preghiere. Dopo poche ore di sonno il padre sognò che suo figlio era accanto al suo letto, lo afferrava per un braccio e gli sussurrava in tono di rimprovero: «Papà, non vedi che brucio?». Si svegliò, notò un lampo di luce viva proveniente dalla stanza attigua, vi accorse e scoprì che il vecchio si era addormentato e che i drappi e un braccio del cadavere del figlio amato erano stati bruciati da una candela accesa che vi era caduta sopra. La spiegazione di questo sogno commovente è abbastanza semplice e, secondo quanto mi ha raccontato la paziente, è stata data correttamente dal conferenziere. Il bagliore di luce arrivava attraverso la porta aperta fino agli occhi dell'uomo addormentato e lo condusse alla conclusione che avrebbe raggiunto se fosse stato sveglio, che cioè una candela era caduta e aveva bruciato qualcosa nelle vicinanze del corpo. E anche possibile che egli si sia preoccupato, prima di andare a dormire, delle capacità del vecchio ad adempiere il suo compito. Né ho altre modifiche da suggerire a questa interpretazione, tranne che il contenuto del sogno deve essere stato sovradeterminato e che le parole dette dal bambino devono essere state formate da parole che egli aveva effettivamente detto durante la sua vita e che erano collegate ad eventi importanti nella mente del padre. Per esempio, «brucio» riporta allo stato febbrile in cui è morto il bambino e «papà, non vedi?» potrebbe derivare da qualche altra situazione altamente emotiva, che noi ignoriamo. Ma, avendo riconosciuto che il sogno è un processo pieno di significato e che può essere inserito nella catena delle esperienze psichiche del sognatore, possiamo ancora chiederci perché mai si sia verificato un sogno in tali circostanze, quando si richiedeva un risveglio il più rapido possibile. E qui osserveremo che anche questo sogno conteneva la realizzazione di un desiderio. Il bimbo morto si comportava nel sogno come uno vivo: egli stesso avvertiva il padre, si avvicinava al suo letto e lo afferrava per il braccio, proprio come aveva probabilmente fatto in quella circostanza dal ricordo della quale derivava la prima parte delle parole del bambino nel sogno. Per la realizzazione di questo desiderio, il padre prolungò il suo sonno ancora un momento. Il sogno veniva preferito alle riflessioni della veglia, perché riusciva a mostrare ancora una volta il bambino vivo. Se il padre si fosse prima svegliato e poi avesse fatto la deduzione che lo spingeva ad andare nell'altra stanza, avrebbe in un certo qual modo abbreviato la vita del figlio di quel momento. Non c'è dubbio sulla particolare caratteristica che attira la nostra attenzione su questo breve sogno. Finora ci siamo occupati principalmente del significato segreto dei sogni e del metodo di scoprirlo e dei mezzi impiegati dal lavoro onirico per nasconderlo. I problemi dell'interpretazione dei sogni hanno finora occupato il centro del quadro. Ed ora incontriamo un sogno che non solleva problemi di interpretazione e il cui significato è ovvio, ma che, come vediamo, trattiene nonostante tutto le caratteristiche essenziali che differenziano in modo sorprendente i sogni dalla veglia e di conseguenza richiede una spiegazione. Solo dopo che abbiamo sistemato tutto ciò che ha a che fare con il lavoro di interpretazione, cominciamo a renderci conto dell'incompletezza della nostra psicologia dei sogni. Ma prima di addentrarci lungo questo nuovo sentiero, sarà bene che ci fermiamo e ci guardiamo intorno, per vedere se nel corso del nostro viaggio fino a questo punto abbiamo trascurato qualcosa di importante. Poiché bisogna chiaramente comprendere che la parte facile e gradevole del nostro viaggio è dietro di noi. Finora, se non mi sbaglio del tutto, tutti i sentieri che abbiamo percorso ci hanno portato verso la luce, verso la spiegazione e la comprensione più piena. Ma appena cerchiamo di penetrare più profondamente nel processo mentale che il sognare implica, tutti i sentieri si perdono nell'oscurità. Non c'è possibilità di spiegare i sogni come processi psichici, poiché spiegare una cosa significa riportarla a qualcosa di già noto e non ci sono attualmente nozioni psicologiche definite alle quali potremmo sottoporre ciò che l'esame psicologico dei sogni ci permette di dedurre come base per la loro spiegazione. Al contrario, saremo costretti a fare nuove ipotesi che tastino la struttura dell'apparato psichico e il gioco delle forze che in esso agiscono. Dobbiamo però stare attenti a non seguire queste ipotesi troppo al di là dei loro primi legami logici, altrimenti il loro valore si perderà nell'incertezza. Anche se non facciamo false deduzioni e prendiamo in considerazione tutte le possibilità logiche, la probabile incompletezza delle nostre premesse minaccia il nostro calcolo di fallimento completo. Non si raggiungeranno mai delle conclusioni, o almeno delle conclusioni pienamente dimostrate, sulla formazione e sui metodi di attività dello strumento psichico dall'indagine anche la più accurata sui sogni e su qualsiasi altra funzione psichica presa isolatamente. Per ottenere questo risultato, sarà necessario collegare tutte le deduzioni tratte da uno studio comparativo di tutta la serie di tali funzioni. Quindi le ipotesi psicologiche cui arriviamo mediante l'analisi dei processi del sognare devono in un certo senso essere lasciate in sospeso, finché non si potrà metterle in relazione con i risultati di altre indagini che cercano di avvicinarsi al nocciolo dello stesso problema da un altro angolo. (A) L'oblio dei sogniPropongo, quindi, che ci rivolgiamo in primo luogo ad un tema che solleva un'obiezione che non abbiamo ancora preso in considerazione, e che tuttavia può togliere fondamento a tutti i nostri sforzi di interpretazione dei sogni. E stato obiettato più di una volta che non abbiamo in realtà nessuna conoscenza dei sogni che ci accingiamo ad interpretare, o, parlando più correttamente, non abbiamo nessuna garanzia di conoscerli come si sono effettivamente verificati. In primo luogo, ciò che noi ricordiamo di un sogno e ciò su cui noi esercitiamo le nostre arti interpretative è stato mutilato dall'infedeltà della nostra memoria, che sembra particolarmente incapace di conservare il sogno e può aver perso proprio le parti più importanti del suo contenuto. Succede piuttosto spesso che quando cerchiamo di rivolgere la nostra attenzione ad uno dei nostri sogni, ci troviamo a rimpiangere il fatto che, anche se abbiamo sognato molto di più, non possiamo ricordare altro che un unico frammento, ricordato esso stesso con particolare incertezza. In secondo luogo, ci sono tutte le migliori ragioni per sospettare che il nostro ricordo dei sogni non è solo frammentario, ma decisamente disattento e falsificato. Da un lato si può dubitare che il sogno sia stato così incoerente e nebuloso, come lo ricordiamo; e dall'altro lato si può anche dubitare se il sogno sia stato davvero così coerente come il racconto che ne facciamo, se nel tentare di raccontarlo non riempiamo le lacune di parti inesistenti o forse dimenticate con nuovo materiale scelto arbitrariamente, se non aggiungiamo abbellimenti e ornamenti e lo aggiustiamo in modo che sia impossibile decidere quale possa essere il suo contenuto originario. Anzi un autore, Spitta, arriva al punto di suggerire che nella misura in cui un sogno mostra un qualsiasi genere di ordine o di coerenza, queste qualità vengono introdotte in esso solo quando cerchiamo di ricordarlo. Quindi sembra che ci sia il pericolo che proprio quella cosa il cui valore ci accingiamo ad asserire, ci scivoli dalle mani. Finora nell'interpretare i sogni abbiamo trascurato tali avvertimenti. Al contrario, abbiamo valutato di pari importanza sia l'interpretazione degli elementi più piccoli, meno chiari e più incerti del contenuto dei sogni, che l'interpretazione di quelli conservati con maggiore chiarezza e sicurezza. Il sogno dell'iniezione a Irma conteneva la frase «chiamai immediatamente il dr. M.»; e noi pensammo che perfino questo dettaglio non sarebbe penetrato nel sogno, se non avesse avuto un'origine particolare. In tal modo ritrovammo la storia dell'infelice paziente al cui capezzale avevo chiamato «immediatamente» il collega più anziano. Nel sogno apparentemente assurdo che considerava la differenza tra 51 e 56 trascurabile, il numero 51 era menzionato parecchie volte. Invece di considerare questo un fatto naturale o indifferente, ne deducemmo che c'era una seconda linea di pensiero nel contenuto latente del sogno che portava al numero 51 ; lungo questa traccia arrivammo alla mia paura che l'età di 51 anni fosse il limite della mia vita, in brillante contrasto con il pensiero dominante nel sogno prodigo di vanità di una lunga vita. Nel sogno del «Non vixit» c'era una interpolazione poco appariscente, che al principio avevo trascurato: «poiché P. non lo capiva, FI. mi chiese» ecc. Quando l'interpretazione si arrestò, tornai a quelle parole ed esse mi ricondussero alla fantasia infantile, che risultò essere il punto intermedio dei pensieri del sogno. Ci arrivai mediante i versi: Raramente mi avete capito, E anche io vi ho capito raramente, Solo quando ci siamo trovati entrambi nel fango Ci siamo capiti subito entrambi. Si possono trovare in tutte le analisi esempi che mostrano che proprio gli elementi più insignificanti del sogno sono indispensabili per la sua interpretazione e che il lavoro si arresta se non si presta in tempo attenzione a questi elementi. Abbiamo attribuito non meno importanza nell'interpretazione dei sogni a tutte le sfumature di forme verbali che ci si presentavano. Ed anche quando succedeva che il testo del sogno che avevamo era privo di significato o insufficiente, come se non fossimo riusciti nello sforzo di farne un'esposizione corretta, abbiamo preso in considerazione anche questo difetto. In breve, abbiamo trattato come testo sacro ciò che i precedenti scrittori hanno considerato improvvisazione arbitraria, messa affrettatamente insieme, nell'imbarazzo del momento. Questa contraddizione richiede una spiegazione. La spiegazione è a nostro favore, anche se non diamo torto agli altri autori. Alla luce della nostra nuova comprensione dell'origine dei sogni, la contraddizione scompare del tutto. È vero che deformiamo i sogni nel cercare di riprodurli; qui troviamo in opera ancora una volta il processo che abbiamo descritto come elaborazione secondaria (e spesso mal congegnata) del sogno, da parte dell'agente che produce il pensiero normale. Ma questa deformazione è essa stessa parte della revisione alla quale vengono regolarmente sottoposti i pensieri del sogno a causa della censura onirica. Gli altri autori a questo punto hanno notato o sospettato la parte della deformazione del sogno che agisce manifestamente; a noi ciò interessa meno, poiché sappiamo che un processo di deformazione molto più esteso, anche se meno evidente, ha già sviluppato il sogno dai pensieri del sogno nascosti. L'unico errore fatto dagli scrittori precedenti è stato quello di supporre che la modificazione del sogno nel corso del ricordo e del racconto fosse arbitraria e non potesse venire ulteriormente risolta, e che fosse quindi intesa a darci un'immagine sbagliata del sogno. Essi hanno sottovalutato l'entità della determinazione dei fatti psichici. In questi non c'è nulla di arbitrario. Si può generalmente dimostrare che se un elemento non viene determinato da una serie di pensieri, la sua determinazione è immediatamente effettuata da una seconda serie. Per esempio, posso cercare di pensare ad un numero arbitrariamente. Ma ciò è impossibile: il numero che mi viene in mente sarà chiaramente e necessariamente determinato dai miei pensieri, anche se possono essere remoti dalla mia intenzione immediata. Le modifiche alle quali i sogni vengono sottoposti sotto la direzione della vita da svegli sono altrettanto poco arbitrarie. Esse sono collegate mediante associazione al materiale che sostituiscono e servono a indicarci la via per altro materiale, che può a sua volta essere un sostituto per qualcos'altro. Nell'analizzare i sogni dei miei pazienti, a volte metto alla prova questa affermazione con il seguente esperimento, che mi è sempre riuscito. Se il primo racconto di un sogno fatto da un paziente è troppo difficile da seguire, gli chiedo di ripeterlo. Nel farlo, egli usa raramente le stesse parole. Ma le parti del sogno che egli descrive in termini differenti mi si rivelano come il punto debole del travestimento del sogno: servono al mio scopo come il segno ricamato sul mantello di Sigfrido servì allo scopo di Hagen. A quel punto si può cominciare l'interpretazione del sogno. La mia richiesta fatta al paziente di ripetere il racconto del sogno lo avverte che intendo sforzarmi particolarmente per risolverlo; sotto la pressione della resistenza quindi egli affrettatamente copre le parti deboli del travestimento onirico, sostituendo qualsiasi espressione che minacci di tradire il suo significato con altre espressioni rivelatrici. In questo modo egli attira la mia attenzione sull'espressione che ha lasciato cadere. La fatica fatta dal sognatore per impedire la soluzione del sogno mi offre una base per la valutazione della cura con cui il suo mantello è stato intessuto. Meno giustificati mi sembrano gli scrittori precedenti, per aver dedicato tanta attenzione al dubbio con cui il nostro giudizio riceve i racconti di sogni. Infatti questo dubbio non ha alcuna garanzia intellettuale. In genere non c'è garanzia dell'esattezza della nostra memoria; eppure cediamo all'impulso di credere ai suoi dati molto più spesso di quanto sia oggettivamente giustificato. Il dubbio se un sogno o alcuni suoi dettagli siano stati raccontati correttamente è ancora una volta un derivato della censura del sogno, della resistenza alla penetrazione dei pensieri del sogno nella coscienza. Questa resistenza non si è esaurita neanche con gli spostamenti e le sostituzioni che ha prodotto; persiste nella forma del dubbio collegato al materiale che è stato fatto passare. Noi siamo particolarmente portati a fraintendere questo dubbio, poiché esso è accurato nel non rivolgersi mai agli elementi più intensi del sogno, ma solo a quelli deboli e indistinti. Tuttavia, come già sappiamo, tra i pensieri del sogno e il sogno si verifica una completa trasmutazione di tutti i valori psichici. La deformazione si rende possibile solo mediante il ritiro del valore psichico; generalmente si esprime con quel mezzo e occasionalmente non richiede altro. Se dunque un elemento indistinto del contenuto di un sogno viene anche attaccato dal dubbio, sapremo con certezza che si tratta di un derivato relativamente diretto di uno dei pensieri proibiti del sogno. Lo stato di cose è quello che c'era dopo qualche violenta rivoluzione in una delle repubbliche dell'antichità e del Rinascimento. Le famiglie nobili e potenti, che avevano prima regnato, venivano mandate in esilio e tutti gli alti ufficiali venivano sostituiti da nuovi venuti. Solo i membri più poveri e impotenti delle famiglie vinte o i dipendenti potevano restare nelle città; e tuttavia non godevano di pieni diritti civili ed erano guardati con diffidenza. La diffidenza in questa analogia corrisponde al dubbio del nostro esempio. È questo il motivo per cui nell'analizzare un sogno io insisto che si abbandoni tutta la gamma di valutazioni di certezza e che si consideri come certezza assoluta anche la più remota possibilità che si sia verificata una qualche cosa in un sogno. Si scoprirà che se non si adotta questo atteggiamento nel risalire alle origini di qualsiasi elemento, l'analisi si arresterà. Se si lanciano dubbi, sul valore dell'elemento in questione, il risultato psichico nel paziente è che non gli verrà in mente nessuna delle idee involontarie che si celano dietro a quell'elemento. Questo risultato non è evidente di per sé. Non avrebbe senso se uno dicesse: «Non so di certo se la tale cosa era nel sogno, ma ecco che cosa mi viene in mente in proposito». Ma in realtà nessuno dice mai questo; ed è proprio il fatto che il dubbio produce questo effetto di interruzione sull'analisi che lo rileva come un derivato e uno strumento della resistenza psichica. La psicoanalisi è giustamente diffidente. Una delle sue leggi è che qualunque cosa interrompa il proseguimento del lavoro analitico è una resistenza. (L'affermazione fatta in questi termini perentori («Tutto ciò che interrompe il processo del lavoro onirico è una resistenza» è facilmente aperta ai malintesi. Naturalmente si deve prendere solo come una regola tecnica, come un avvertimento agli analisti. Non si può confutare che nel corso dell'analisi si possono verificare diversi eventi non imputabili alle intenzioni del paziente. Il padre può morire senza che egli lo abbia assassinato, o può scoppiare una guerra che interrompe l'analisi. Ma al di là dell'evidente esagerazione, l'affermazione sostiene qualcosa di nuovo e di vero. Anche se l'evento che causa l'interruzione è reale e indipendente dal paziente, dipende spesso da lui l'entità dell'interruzione che provoca; e la resistenza si rivela inequivocabilmente nella prontezza con la quale egli accetta un fatto di questo genere e nell'abuso che ne fa.) Anche l'oblio dei sogni resta inspiegabile se non si prende in considerazione la potenza della censura psichica. In numerosi casi la sensazione di aver sognato molto durante la notte e di ricordare solo una piccola parte può effettivamente avere qualche altro significato, ad esempio che il lavoro onirico abbia agito in modo percettibile durante tutta la notte, ma abbia lasciato dietro di sé solo un breve sogno. È indubbio che dimentichiamo sempre di più i sogni con il passare del tempo, dopo il risveglio; spesso li dimentichiamo nonostante i più faticosi sforzi per ricordarli. Ma sono dell'opinione che l'entità di questo oblio sia in genere sopravvalutata; e c'è anche una sopravvalutazione della limitazione della nostra conoscenza del sogno a causa delle lacune. Spesso è possibile mediante l'analisi ritrovare tutto quanto è stato perso dimenticando il contenuto del sogno; o almeno, in numerosi casi, si può ricostruire da un unico frammento non il sogno, che in ogni caso non è importante, ma l'insieme dei pensieri del sogno. Ciò richiede una certa attenzione e autodisciplina nel compiere l'analisi; questo è tutto, ma dimostra che non manca un fine ostile (di resistenza) attivo nel dimenticare i sogni. (Cito il seguente sogno dalla mia Introduzione allo studio della psicoanalisi come esempio del significato di dubbio e incertezza in un sogno e del suo contenuto ridotto ad un unico elemento; nonostante tutto questo, il sogno è stato analizzato con successo, anche se con un breve ritardo. «Una paziente scettica fece un sogno piuttosto lungo nel quale alcune persone le parlavano di un mio libro sui motti di spirito, lodandolo molto. Poi c'era qualcosa circa un «canale», forse era un altro libro che parlava di un canale, o qualche altra cosa che riguardava un canale... non sapeva... era tutto così indistinto». Senza dubbio sarete portati a credere che l'elemento «canale», dal momento che era così confuso, sia inaccessibile all'interpretazione. È giusto sospettare una difficoltà; ma la difficoltà non veniva dalla confusione; sia la difficoltà che la confusione derivavano da un'altra causa. Alla sognatrice non veniva in mente niente in relazione a «canale» ed io naturalmente non potevo dare dei chiarimenti. Poco dopo, precisamente il giorno dopo, mi disse che aveva pensato a qualcosa che poteva avere a che fare con il sogno. Si trattava di un motto di spirito che aveva sentito. Sul vapore tra Dover e Calais un noto scrittore si mise a conversare con un inglese. Quest'ultimo ebbe occasione di citare la frase: «Dal sublime al ridicolo non c'è che un passo», lo scrittore rispose: «Sì, il passo di Calais», intendendo dire che trovava la Francia sublime e l'Inghilterra ridicola. Ma il passo di Calais è un canale, il Canale della Manica. Mi si chiederà se ritengo che questo abbia qualcosa a che fare con il sogno. Certamente, inoltre fornisce la soluzione dell'elemento del sogno. Si può forse dubitare che questo motto di spirito fosse già presente prima del sogno come pensiero inconscio retrostante all'elemento «canale»? Si può credere che fosse introdotto come invenzione successiva? L'associazione tradiva lo scetticismo che si celava dietro all'ostentata ammirazione della paziente; e la sua resistenza alla rivelazione era certamente la causa comune del ritardo nel trovare l'associazione e della confusione dell'elemento onirico. Si consideri la relazione tra l'elemento onirico e il suo sfondo inconscio; era in un certo senso un frammento di quello sfondo, un'allusione, ma era reso del tutto incomprensibile mediante l'isolamento.) Si trova una prova convincente del fatto che il dimenticare i sogni sia tendenzioso e serva agli scopi della resistenza (Cfr. per gli scopi della dimenticanza in genere il mio breve scritto sul meccanismo psichico della dimenticanza, in seguito accluso come primo capitolo nella Psicopatologia della vita quotidiana.), quando è possibile osservare nell'analisi uno stadio preliminare di dimenticanza. Succede spesso che nel mezzo del lavoro di interpretazione venga alla luce una parte del sogno omessa e si dica che fino a quel momento era stata dimenticata. Ora una parte di un sogno che sia tratta dall'oblio in questa maniera è certamente la parte più importante; si trova sempre sulla via più breve verso la soluzione del sogno e per tale motivo è stata sempre esposta alla resistenza più di qualsiasi altra parte. Tra gli esempi di sogni sparsi in questo libro, ce n'è uno in cui una parte del suo contenuto è stata aggiunta in tal modo come pensiero successivo. Si tratta del sogno di viaggio in cui mi vendicai contro i due scortesi compagni di viaggio e che ho dovuto lasciare quasi senza interpretazione a causa della sua grossolana oscenità. La parte omessa diceva: Dissi riferendomi ad un lavoro di Shiller: "It is from... " ma, notando l'errore, mi corressi: "It is by... " "Sì", osservò l'uomo alla sorella, "ha detto bene"». (Queste correzioni nell'uso di lingue straniere non sono rare nei sogni, ma più spesso vengono attribuite ad altre persone. Quando imparava l'inglese, Maury sognò una volta che, nel dire ad una persona che era andato a trovarla il giorno precedente, usava l'espressione: «I called for you yesterday», mentre l'altro rispondeva: «Avresti dovuto dire: / called on you yesterday».) Le autocorrezioni nei sogni, che sembrano così sorprendenti agli altri autori, non richiedono la nostra attenzione. Indicherò invece il ricordo che servì da modello al mio errore verbale in questo sogno. Quando avevo diciannove anni andai in Inghilterra per la prima volta e passai una giornata intera sulla riva del mare irlandese. Naturalmente godevo dell'opportunità di raccogliere gli animali marini lasciati dalla marea ed ero impegnato con una stella marina (le parole «Hollthurn» e «holothurians», erano comparse al principio del sogno), quando un'affascinante ragazzina mi si avvicinò e disse: «Is it a starfish? Is it alive?» Io risposi: «Yes, he is alive», e subito, imbarazzato per il mio errore, ripetei correttamente la frase. Il sogno sostituiva l'errore che avevo fatto con un altro che un tedesco fa altrettanto facilmente. «Das Buch ist von Schiller» non si deve tradurre con un «from» ma con un «by». Dopo tutto quello che abbiamo sentito sugli scopi del lavoro onirico e sulla sua scelta avventata dei metodi usati per ottenerli, non ci sorprenderemo nell'apprendere che esso ha effettuata questa sostituzione perché rendeva possibile una magnifica condensazione mediante l'identità di suono dell'inglese «from» e dell'aggettivo tedesco «fromm» [«pio»]. Ma come poteva entrare nel sogno l'innocente ricordo della riva del mare? Serviva da esempio il più innocente possibile del mio usare al posto sbagliato una parola indicante il genere o il sesso, del mio inserire il sesso (la parola «he») dove non c'entrava. Questa era poi una delle chiavi per la soluzione del sogno. Chiunque abbia inoltre sentito dell'origine attribuita al titolo del libro di Clerk-Maxwell, «Matter and Motion» (menzionato nel sogno), non troverà difficoltà nel riempire le lacune: «Il malato immaginario» di Molière - «La matière est-elle laudable?» - A motion of the bowels. Inoltre posso dare una dimostrazione oculare del fatto che il dimenticare i sogni è in gran parte un prodotto di resistenza. Un paziente mi dice di aver fatto un sogno, ma di averlo completamente dimenticato: quindi è come se non lo avesse fatto. Procediamo nel nostro lavoro. Incontro una resistenza; quindi spiego qualcosa al paziente e lo aiuto con incoraggiamenti e insistenze ad affrontare un pensiero sgradevole. Sono appena riuscito in questo, che egli esclama: «Ora ricordo quello che ho sognato». La resistenza che ostacolava quel giorno il nostro lavoro gli aveva fatto dimenticare il sogno. Superando questa resistenza gli ho fatto tornare alla memoria il sogno. Proprio nello stesso modo, quando un paziente raggiunge uno stadio particolare dell'analisi, riesce a ricordare un sogno fatto tre o quattro anni prima o anche di più, che fino a quel momento era stato dimenticato. (Ernest Jones ha parlato di un caso analogo che succede spesso: mentre un sogno viene analizzato, il paziente può ricordarne un altro fatto la stessa notte e ignorato fino a quel momento.) L'esperienza psicoanalitica ci ha fornito un'ulteriore prova del fatto che l'oblio dei sogni dipende molto di più dalla resistenza che dalla concezione, messa in rilievo dagli altri autori, che lo stato della veglia e quello del sonno siano estranei l'uno all'altro. Mi succede di frequente, così come succede agli altri analisti e ai pazienti sotto trattamento, che, svegliato da un sogno, se così si può dire, intraprendo immediatamente e nel pieno possesso delle mie facoltà intellettuali, la sua interpretazione. In tali casi ho spesso rifiutato di riaddormentarmi prima di essere arrivato alla comprensione completa del sogno; tuttavia mi è capitato a volte di aver completamente dimenticato al risveglio al mattino sia l'attività interpretativa sia il contenuto del sogno, pur sapendo di aver fatto un sogno e di averlo interpretato. Succede molto più spesso che il sogno attiri i risultati della mia attività interpretativa nell'oblio, piuttosto che la mia attività intellettuale riesca a conservare il sogno della mia memoria. Tuttavia non esiste un tale abisso psichico tra la mia attività interpretativa e i miei pensieri da sveglio, come gli autori presumono, per poter spiegare la dimenticanza dei sogni. Morton Prince ha criticato la mia spiegazione dell'oblio dei sogni affermando che quella dimenticanza è solo un caso speciale dell'amnesia collegata agli stati mentali dissociati, che è impossibile estendere la mia spiegazione di questa amnesia speciale agli altri tipi e che la mia spiegazione di conseguenza è priva di ogni valore anche per il suo scopo immediato. Con ciò egli rammenta quindi ai suoi lettori che nel corso di tutte le descrizioni di questi stati dissociati non ha mai cercato di scoprire una spiegazione dinamica di tali fenomeni. Se lo avesse fatto, avrebbe certamente scoperto che la rimozione (o, più precisamente, la resistenza che essa crea) è la causa di entrambe le dissociazioni e dell'amnesia collegata al loro contenuto psichico. Un'osservazione che ho potuto fare nel corso della preparazione di questo manoscritto mi ha mostrato che i sogni non vengono dimenticati più degli altri atti mentali e che possono essere paragonati, senza alcuno svantaggio, alle altre funzioni psichiche per quanto riguarda la loro conservazione nella memoria. Avevo preso appunti su un gran numero di sogni che per un motivo o per un altro non ero riuscito a interpretare completamente al momento o che non avevo interpretato affatto. Ed ora, uno o due anni più tardi, ho cercato di interpretarne alcuni per ottenere più materiale che illustrasse le mie tesi. Questi tentativi mi sono riusciti in ogni caso; anzi si può dire che l'interpretazione sia avanzata più facilmente dopo questo lungo intervallo, che al momento in cui il sogno era un'esperienza recente. Una spiegazione possibile di questo è che nel frattempo io ho superato parte delle resistenze interne che prima mi ostacolavano. Nel fare queste successive interpretazioni ho paragonato i pensieri del sogno che avevo tirato fuori al momento del sogno con quelli attuali, generalmente più abbondanti, e ho sempre scoperto che i vecchi erano compresi tra i nuovi. Il mio stupore fu prontamente arrestato dalla riflessione che da molto tempo avevo l'abitudine di indurre i miei pazienti, che a volte mi raccontano sogni che risalgono ad anni precedenti, ad interpretarli mediante lo stesso procedimento e con lo stesso successo; come se avessero sognato la notte precedente. Quando arriverò alla discussione dei sogni d'angoscia, darò due esempi di tali interpretazioni postume. Fui indotto a fare il mio primo esperimento di questo tipo dalla giustificata aspettativa che sotto questo come sotto altri riguardi il sogno si sarebbe comportato come i sintomi nevrotici. Quando io curo uno psiconevrotico, diciamo un isterico, mediante la psicoanalisi, sono costretto a trovare una spiegazione per i primi sintomi attuali che l'hanno portato da me per il trattamento; ed effettivamente trovo i primi problemi più semplici da risolvere di quelli attuali. Già nel 1895, nei miei «Studi sull'isterìa», riuscii a dare la spiegazione del primo attacco isterico che una donna di più di quarant'anni aveva avuto a quindici anni. Ed ora menzionerò degli altri punti, in più libera connessione, sull'interpretazione dei sogni, che aiuteranno forse i lettori ad orientarsi nel caso volessero controllare le mie affermazioni mediante un successivo lavoro sui propri sogni. Nessuno si deve aspettare che l'interpretazione dei suoi sogni gli cada in grembo come la manna dal cielo. Ci vuole pratica perfino per percepire i fenomeni endoptici o altre sensazioni da cui in genere la nostra attenzione è distolta; e ciò accade anche se non c'è alcun motivo psichico che combatta contro tali percezioni. È decisamente più difficile afferrare le «idee involontarie». Chiunque cerchi di farlo dovrà familiarizzare con le aspettative espresse in questo libro e dovrà, secondo le regole esposte in esso, cercare, durante il lavoro, di trattenersi da qualsiasi critica, da qualsiasi preconcetto, da qualsiasi pregiudizio emotivo o intellettuale. Deve ricordarsi del consiglio di Claude Bernard ai ricercatori di un laboratorio fisiologico: «travailler comme une bête», lavorare, cioè, con l'ostinazione di una bestia e con noncuranza per il risultato. Seguendo questo consiglio, il compito non sarà più così difficile. L'interpretazione di un sogno non si può sempre conseguire con una sola seduta. Una volta seguita una catena di associazioni, spesso succede che ci si senta esauriti; nulla di più si imparerà dal sogno per quel giorno. La cosa migliore è quella di interrompere e riprendere il lavoro un altro giorno: un'altra parte del contenuto del sogno potrebbe allora attirare la nostra attenzione e aprirci l'accesso ad un altro strato di pensieri del sogno. Questo procedimento si potrebbe definire un'interpretazione dei sogni «frazionata». E' solo con grandissima difficoltà che il principiante nell'interpretazione dei sogni può venir persuaso che il suo compito non è finito quando è in possesso di una interpretazione completa, una interpretazione che abbia senso, sia coerente e illumini ogni elemento del contenuto del sogno. Infatti lo stesso sogno può avere anche un'altra interpretazione, una «sovrainterpretazione», che gli è sfuggita. Non è davvero facile formarsi un concetto dell'abbondanza delle serie di pensieri nelle nostre menti. Né è facile prestare fede all'abilità mostrata dal lavoro onirico nel centrare sempre forme di espressione che possono avere parecchi significati, come il piccolo sarto della fiaba che prese sette mosche in un colpo solo. I miei lettori tenderanno sempre ad accusarmi di introdurre un'eccessiva ingegnosità nelle mie interpretazioni; ma l'esperienza effettiva farebbe cambiare loro idea. D'altra parte, non posso confermare l'opinione, sostenuta per la prima volta da Silberer, che tutti i sogni (o molti sogni, o determinate categorie di sogni) richiedano due diverse interpretazioni, che hanno tra loro una relazione precisa. Una di queste interpretazioni, che Silberer chiama «psicoanalitica», si dice che dia al sogno un significato qualsiasi, generalmente sessuale-infantile; l'altra interpretazione, più importante, che egli chiama «anagogica», rivela i pensieri più seri, spesso più profondi, che il lavoro onirico ha impiegato come materiale. Silberer non ha dato delle prove a sostegno di questa opinione, mediante il racconto di una serie di sogni analizzati nelle due direzioni. Ed io devo obiettare che il fenomeno descritto non esiste. Nonostante le sue idee, la maggioranza dei sogni non richiede una «sovrainterpretazione» e, più particolarmente, non è suscettibile di interpretazione anagogica. Come nel caso di molte altre teorie avanzate negli ultimi anni, le opinioni di Silberer sono influenzate in una certa misura dal proposito di mascherare le circostanze fondamentali della formazione dei sogni e di distogliere l'interesse dalle radici pulsionali. Per un certo numero di casi ho potuto confermare le affermazioni di Silberer. L'analisi ha mostrato che in tali casi il lavoro onirico ha dovuto affrontare il problema di trasformare in un sogno una serie di pensieri altamente astratti della vita da svegli, che non riuscivano ad ottenere una rappresentazione diretta. Ha cercato di risolvere il problema impadronendosi di un altro gruppo di materiale ideativo, imparentato alla lontana (in un modo che si potrebbe dire «allegorico») ai pensieri astratti e nello stesso tempo suscettibile di rappresentazione con minori difficoltà. L'interpretazione astratta di un sogno sorto in questa maniera può essere fatta dal sognatore senza alcuna difficoltà; l'interpretazione corretta del materiale sostituito si deve ricercare mediante i metodi tecnici che ci sono noti. Alla domanda se tutti i sogni possano essere interpretati bisogna rispondere negativamente. Non si deve dimenticare che nell'interpretazione del sogno siamo ostacolati dalle forze psichiche responsabili della sua deformazione. È quindi questione di forza relativa se, nell'interpretazione del sogno, il nostro interesse intellettuale, la nostra capacità di autodisciplina, le nostre conoscenze psicologiche e la nostra pratica riescono a dominare le resistenze interne. E' sempre possibile arrivare fino a un certo punto: in ogni caso fino a convincerci che il sogno è una struttura con un significato, e in genere anche fino ad avere un'idea sul suo significato. Abbastanza spesso un sogno immediatamente successivo ci permette di confermare e continuare l'interpretazione tentata per il precedente. Un'intera serie di sogni, che si protrae per un periodo di settimane o mesi, spesso si basa su un fondamento comune e di conseguenza l'interpretazione deve essere collegata. Nel caso di due sogni consecutivi, si può osservare che uno di essi prende come punto centrale qualcosa che è solo nella periferia dell'altro e viceversa, cosicché anche le loro interpretazioni sono complementari. Ho già fatto degli esempi per mostrare che sogni diversi fatti la stessa notte abbastanza generalmente devono essere considerati nell'interpretazione come un unico insieme. Spesso c'è una parte anche nel sogno interpretato più a fondo che dev'essere lasciata oscura; ciò avviene perché ci rendiamo conto durante il lavoro di interpretazione che a quel punto c'è un nodo di pensieri del sogno che non può essere districato e che inoltre non aggiunge nulla alla nostra conoscenza del contenuto del sogno. Questo è l'ombelico del sogno, il punto dove si immerge nell'ignoto. I pensieri del sogno, ai quali ci conduce l'interpretazione, non possono, per la natura delle cose, avere dei punti d'arrivo determinati; sono costretti a ramificarsi in tutte le direzioni nell'intricata rete del mondo del pensiero. E il desiderio del sogno emerge in qualche punto in cui questa rete è particolarmente fitta, come un fungo dal suo micelio. Ma dobbiamo ritornare ai fenomeni riguardanti il dimenticare i sogni, poiché non abbiamo tratto una importante deduzione. Abbiamo visto che la veglia mostra l'inequivocabile tendenza a dimenticare i sogni che si sono formati durante la notte, o nel complesso subito dopo il risveglio, o a brani durante la giornata; ed abbiamo riconosciuto che l'agente principalmente responsabile di questo oblio è la resistenza mentale al sogno che ha già fatto quanto ha potuto durante la notte. Ma se questo è vero, viene da chiedersi come mai possa nascere un sogno nonostante questa resistenza. Prendiamo il caso estremo, in cui la veglia si è liberata del sogno, come se non ci fosse mai stato. Se prendiamo in considerazione il gioco delle forze psichiche in questo caso dovremo concludere che effettivamente il sogno non ci sarebbe stato affatto, se la resistenza durante la notte fosse stata altrettanto forte di quella del giorno. Quindi la resistenza durante la notte perde parte della sua forza, ma non la perde completamente, poiché sappiamo che svolge un ruolo nella formazione del sogno, deformandolo. Siamo portati a supporre che però il suo potere possa essere diminuito durante la notte e che ciò renda possibile la formazione dei sogni. Questo ci permette di comprendere facilmente che, avendo riottenuto al momento del risveglio la sua forza piena, essa cerchi immediatamente di eliminare ciò che è stata costretta a permettere mentre era debole. La psicologia descrittiva ci dice che la condizione essenziale per la formazione dei sogni è che la mente sia nello stato di sonno; e noi ora possiamo spiegare questa affermazione: lo stato di sonno rende possibile la formazione dei sogni, perché riduce la forza della censura endopsichica. E' senza dubbio una grande tentazione quella di considerare questa l'unica possibile deduzione da trarre dai fenomeni della dimenticanza dei sogni e di farne una base per ulteriori conclusioni riguardo alle condizioni di energia prevalenti durante il sonno e durante la veglia. Tuttavia per il momento ci fermeremo a questo punto. Quando saremo penetrati un po' più profondamente nella psicologia dei sogni, scopriremo che i fattori che rendono possibile la formazione dei sogni si possono considerare anche in altro modo. Può essere che la resistenza contro i pensieri del sogno che diventano coscienti si possa eludere senza che si verifichi una riduzione della sua forza. E sembra plausibile che entrambi i fattori che favoriscono la formazione dei sogni, la riduzione e l'aggiramento della resistenza, siano resi possibili contemporaneamente dallo stato di sonno. A questo punto interrompo, ma riprenderò di nuovo l'argomento tra poco. Dobbiamo ora affrontare un'altra serie di obiezioni contro il nostro metodo di interpretazione dei sogni. Il nostro procedimento consiste nell'abbandonare tutte le rappresentazioni intenzionali che generalmente regolano le nostre riflessioni, nel centrare la nostra attenzione su un singolo elemento del sogno e nel prendere nota di qualsiasi pensiero involontario che ci possa venire in mente al riguardo. Poi prendiamo la parte seguente del sogno e con essa ripetiamo il processo. Ci lasciamo condurre dai nostri pensieri incuranti della direzione in cui ci portano e procediamo in questo modo per così dire di palo in frasca. Ma siamo fiduciosi che alla fine, senza alcun intervento attivo da parte nostra, arriveremo ai pensieri onirici da cui il sogno deriva. I nostri critici sollevano le loro argomentazioni lungo questa direttiva. Non c'è niente di sorprendente nel fatto che un singolo elemento del sogno ci conduca da qualche parte; qualsiasi idea si può associare con qualcosa. Ciò che è sorprendente è che un'associazione di pensieri così priva di scopo e arbitraria debba proprio portarci ai pensieri del sogno. La probabilità è che ci stiamo ingannando. Seguiamo una catena di associazioni da un elemento, finché, per qualche ragione, sembra interrompersi. Se poi prendiamo un secondo elemento, ci si deve solo aspettare che il carattere originariamente illimitato delle nostre associazioni si sia ristretto. Infatti abbiamo ancora nella nostra memoria la precedente catena di pensieri, e per tale motivo, nell'analizzare la seconda rappresentazione onirica, è molto probabile che troviamo delle associazioni che abbiano qualcosa in comune con le associazioni della prima catena. Allora ci illudiamo, immaginando di aver scoperto un pensiero che sia un punto di connessione tra due elementi del sogno. Poiché ci concediamo completa libertà nel collegare i pensieri e poiché in realtà gli unici passaggi da un'idea all'altra che escludiamo sono quelli che operano nel pensare normale, non sarà difficile alla fine tirar fuori un numero di «pensieri intermedi», qualcosa che chiamiamo «pensieri del sogno» e che, anche senza garanzia poiché non sappiamo cosa siano i pensieri del sogno, asseriamo essere il surrogato psichico del sogno. Ma il tutto è completamente arbitrario; stiamo solo approfittando di nessi casuali in un modo che dà un effetto di ingegnosità. In questo modo chiunque voglia fare una fatica inutile può elaborare l'interpretazione che vuole da qualsiasi sogno. Se dovessimo effettivamente incontrare obiezioni simili, potremmo difenderci richiamandoci all'impressione fatta dalle nostre interpretazioni, ai sorprendenti nessi con gli altri elementi del sogno che emergono nel corso del nostro inseguimento di una sola delle rappresentazioni per volta, e all'improbabilità del fatto che si possa raggiungere qualcosa da una spiegazione così esauriente, se non seguendo dei nessi psichici che sono stati già preparati. Potremmo anche rilevare in nostra difesa che il nostro procedimento nell'interpretazione dei sogni è identico a quello mediante il quale risolviamo i sintomi isterici; e in quel campo l'esattezza del nostro metodo è garantita dal contemporaneo emergere e scomparire dei sintomi o, per fare un paragone, le affermazioni fatte nel testo sono confermate dalle illustrazioni inserite. Ma non c'è ragione per eludere il problema del come sia possibile raggiungere un fine preesistente, seguendo la corrente di una catena di pensieri arbitraria e priva di scopo; ma se anche non fossimo in grado di risolvere il problema, possiamo eliminarlo alla radice. Infatti si può dimostrare che non è vero che siamo trasportati lungo una corrente di idee senza scopo quando, nel processo dell'interpretazione di un sogno, abbandoniamo la riflessione e permettiamo che emergano i pensieri involontari. Si può mostrare che ci possiamo liberare solo delle idee intenzionali che ci sono note; appena abbiamo fatto ciò, le idee sconosciute - oppure, come diciamo impropriamente, «inconsce» - assumono l'incarico e da quel momento determinano il corso delle immagini involontarie. Nessuna influenza che riusciamo a far pesare sui processi psichici ci permetterà mai di pensare senza idee intenzionali; né conosco alcuno stato di disordine psichico che possa farlo. (Solo successivamente mi sono accorto che Eduard von Hartmann ha la stessa opinione su quest'importante argomento della psicologia: «Nel parlare del ruolo svolto dall'inconscio nella creazione artistica, Eduard von Hartmann ha dato una chiara definizione della legge secondo la quale le associazioni di idee sono regolate da rappresentazioni intenzionali inconscie, pur ignorando il fine della legge. Egli vuole dimostrare che «ogni combinazione di rappresentazioni sensibili, se non è lasciata al caso, ma diretta verso uno scopo preciso, richiede l'aiuto dell'inconscio» e che l'incosciente^stimola l'inconscio a scegliere la rappresentazione più adatta tra le infinite possibilità. E l'inconscio che fa l'adatta selezione di uno scopo per l'interesse e ciò «è valido per le associazioni di idee nel pensare astratto, così come nell'immaginazione sensibile e nella combinazione artistica e nella creazione di barzellette. Per questa ragione non si può limitare l'associazione di idee ad un'idea eccitatrice e un'idea eccitata (nel senso di una psicologia di associazione pura). Tale limitazione si potrebbe giustificare «solo se esistessero nella vita umana condizioni tali per cui l'uomo potesse essere libero non solo da qualsiasi fine cosciente ma anche dall'influenza o collaborazione di qualsiasi interesse inconscio, di qualsiasi umore passeggero. Questa condizione, tuttavia, non si raggiunge quasi mai. perché anche quando in apparenza si abbandonano completamente al caso le proprie associazioni d'idee, o ci si abbandona interamente a fantasie non intenzionali, ci sono sempre degli altri interessi dominanti, sentimenti e stati d'animo, che prevalgono prima o poi ed esercitano sempre un'influenza sulle associazioni d'idee». «Nei sogni semi-coscienti si presentano sempre solo quelle rappresentazioni che corrispondono all'interesse principale (inconscio) del momento». Dal punto di vista della psicologia di Hartmann, il sottolineare l'influenza dei sentimenti e degli stati d'animo sulla libera sequenza dei pensieri giustifica il procedimento metodologico della psicoanalisi. Riferendosi al fatto che spesso, dopo aver invano cercato di ricordare un nome, esso ci viene in mente improvvisamente e direttamente, Du Prel conclude che è subentrato il pensare inconscio ma non meno intenzionale, e il suo risultato è entrato improvvisamente nella coscienza.) Gli psichiatri sono stati fin troppo pronti, sotto questo riguardo, ad abbandonare la loro fiducia nella coerenza dei processi psichici. So per certo che le associazioni di pensiero senza rappresentazioni intenzionali non si verificano nell'isteria e nella paranoia, così come non sono nella formazione o risoluzione dei sogni. Forse non ci sono in nessuno dei disordini psichici endogeni. Anche nei deliri confusi ci può essere un significato, se vogliamo accettare il brillante suggerimento di Leuret, per cui ci sono incomprensibili solo a causa delle lacune. Io stesso mi sono formato la stessa opinione quando ho avuto l'opportunità di osservarli. I deliri sono il prodotto della censura che non si preoccupa più di celare la sua attività; invece di collaborare nel produrre una nuova versione che sia ineccepibile, distrugge apertamente ciò che disapprova, così che ciò che rimane diventa piuttosto incoerente. Questa censura agisce esattamente come la censura dei giornali alla frontiera russa, che lascia andare tra le mani dei suoi lettori, che deve proteggere, i giornali stranieri, solo dopo aver cancellato i passaggi pericolosi. Forse si può trovare il libero gioco di idee con una catena di associazioni non influenzate da rappresentazioni finalizzate, ciò che si considera tale nelle psiconevrosi si può sempre spiegare come un effetto dell'influenza della censura su un'associazione spinta in primo piano da rappresentazioni intenzionali che sono rimaste nascoste. (Questa affermazione ha trovato sorprendente conferma nelle analisi di casi di demenza precoce di C. G. Jung.) È stato considerato indizio infallibile di associazioni non influenzate da rappresentazioni intenzionali il fatto che le associazioni (o immagini) possano essere collegate in maniera «superficiale», mediante assonanza, doppio senso di una parola, coincidenza temporale, senza nesso di significato, o associazione del genere che si trova nelle barzellette e nei giochi di parole. Questa caratteristica si trova nelle associazioni d'idee che portano dagli elementi di un sogno ai pensieri intermedi e da questi ai pensieri del sogno veri e propri; abbiamo visto esempi di ciò, non senza stupore, in molte analisi di sogni. Nessun nesso era troppo debole, nessuno scherzo troppo cattivo, per poter essere un ponte tra un pensiero e l'altro. Ma è facile trovare la vera spiegazione di questo indulgente stato di cose. Ogni volta che un elemento psichico è legato ad un altro da un 'associazione contestabile e superficiale, c'è anche un legame conveniente e più profondo tra di essi, soggetto alla resistenza della censura. La vera ragione della prevalenza delle associazioni superficiali non è l'abbandono delle rappresentazioni intenzionali, ma la pressione della censura. Le associazioni superficiali sostituiscono quelle profonde, se la censura rende inaccessibili i normali passaggi di connessione. Possiamo immaginare, per analogia, una zona di montagna, dove una generale interruzione del traffico, ad esempio a causa di una inondazione, abbia bloccato le strade principali più grandi, ma dove si mantengono ancora le comunicazioni attraverso gli scomodi e ripidi sentieri generalmente percorsi solo dai cacciatori. Qui possiamo distinguere due casi, anche se essenzialmente si tratta della stessa cosa. Nel primo caso la censura è diretta solo contro la connessione tra due pensieri, che isolatamente sono ineccepibili. In tal caso, i due pensieri entreranno nella coscienza successivamente; la connessione tra di essi resterà nascosta, ma, al suo posto, un legame superficiale ci verrà in mente, al quale non avremmo altrimenti mai pensato. Questo legame è generalmente collegato a qualche punto del complesso di rappresentazioni completamente diverso da quello sul quale è basata la connessione essenziale e repressa. Nel secondo caso, i due pensieri sono essi stessi soggetti alla censura a causa del loro contenuto. In tal caso, nessuno dei due appare nella sua forma effettiva, ma in una modificata che la sostituisce; e i due pensieri che li costituiscono sono scelti in modo da avere un'associazione superficiale, che ripeta la connessione essenziale che si riferisce ai due pensieri che hanno sostituito. In entrambi i casi la pressione della censura ha prodotto uno spostamento da un 'associazione normale e seria ad una superficiale e apparentemente assurda. Poiché sappiamo che si verificano spostamenti di questo genere, non esitiamo affatto, quando interpretiamo un sogno, a contare sulle associazioni superficiali quanto sulle altre. (Naturalmente le stesse considerazioni valgono anche per i casi in cui le associazioni superficiali appaiono apertamente nel contenuto del sogno, come per esempio nei due sogni di Maury sopra citati (pélerinage - pelletier - pelle; kilomètre - kilogramme; Gilolo - Lobelia - Lopez - lotto). Dal mio lavoro con i nevrotici ho appreso la natura dei ricordi che preferiscono questo tipo di rappresentazione. Si tratta di occasioni in cui il soggetto (come la maggior parte delle persone del periodo della pubertà) ha sfogliato le pagine di enciclopedie e dizionari per trovare una risposta all'enigma del sesso.) Nella psicoanalisi delle nevrosi si fa grandissimo uso di queste due regole - che, quando le rappresentazioni finalizzate coscienti vengono abbandonate, delle rappresentazioni finalizzate nascoste prendono il controllo della corrente di idee, e che le associazioni superficiali sono solo dei sostituti mediante spostamento di altre più profonde, represse. Queste regole sono diventate davvero i pilastri della tecnica psicoanalitica. Quando io dico al paziente di abbandonare riflessioni di qualsiasi genere e di dirmi qualsiasi cosa gli venga in mente, io sto fermamente contando sulla supposizione che egli non riuscirà ad abbandonare le rappresentazioni intenzionali inerenti al trattamento e mi sento giustificato a dedurre che quelle che sembrano essere le cose più innocenti e arbitrarie che egli mi dice, sono in realtà collegate alla sua malattia. C'è un'altra rappresentazione finalizzata che il paziente non sospetta, una che si riferisce a me stesso. La piena valutazione dell'importanza di queste due regole e così anche le informazioni più dettagliate a riguardo rientrano nel campo della spiegazione della tecnica della psicoanalisi... Qui abbiamo dunque raggiunto il punto dove, secondo il nostro programma, dobbiamo lasciar cadere l'argomento dell'interpretazione dei sogni. (Questi due postulati, che sembravano incredibili quando furono esposti, sono stati poi impiegati sperimentalmente e confermati da Jung e dai suoi allievi nei loro studi sull'associazione di parole.) C'è una conclusione vera da trarre da queste obiezione, cioè che non è necessario presumere che tutte le associazioni che vengono in mente durante il lavoro di interpretazione erano presenti nel lavoro onirico durante la notte. E vero che nel compiere l'interpretazione da svegli seguiamo un percorso che riporta dagli elementi del sogno ai pensieri del sogno, e che il lavoro onirico l'ha percorso in senso inverso, ma è molto improbabile che queste vie si possano percorrere in entrambe le direzioni. Sembra piuttosto che durante il giorno percorriamo vie sotterranee lungo nuove associazioni di pensiero e che queste vie abbiano un contatto con i pensieri intermedi e con i pensieri del sogno ora in un punto ora in un altro. Possiamo ora vedere come, in questo modo, nuovo materiale del giorno si inserisca nelle catene interpretative. E' anche probabile che l'aumento di resistenza, che si è stabilito dopo la notte, renda necessari giri nuovi e più indiretti. Il numero e la natura dei pensieri collaterali che intessiamo in questo modo non ha alcuna importanza psicologica, purché ci conducano ai pensieri del sogno che stiamo cercando. (B) LA REGRESSIONEAvendo respinto le obiezioni che sono state sollevate contro di noi, o almeno indicato dove si trovano le nostre armi difensive, non dobbiamo più rimandare il compito di intraprendere le indagini psicologiche, per le quali da tanto tempo ci stiamo preparando. Riassumiamo i principali risultati della nostra indagine ottenuti finora. I sogni sono atti psichici di valore pari a qualsiasi altro atto; la loro forza motrice è in ogni caso un desiderio che cerca realizzazione; il fatto che essi non siano riconoscibili come desideri e le loro numerose particolarità e assurdità sono dovute all'influenza della censura psichica, cui sono sottoposti durante il processo di formazione; a parte la necessità di eludere la censura, altri fattori che contribuiscono alla loro formazione sono la necessità di condensazione del loro materiale psichico, il riguardo per la possibilità di essere rappresentati in immagini sensorie e, anche se non sempre, l'esigenza che la struttura del sogno abbia un'apparenza razionale e intellegibile. Ognuna di queste asserzioni apre la via a nuovi postulati psicologici e speculazioni; devono essere studiate la relazione reciproca tra il desiderio che è la forza motrice del sogno e le quattro condizioni cui è sottoposta la formazione del sogno e le relazioni che intercorrono tra queste; e si deve assegnare al sogno un posto nel complesso della vita mentale. Ho iniziato il presente capitolo con un resoconto di un sogno proprio per rammentare i problemi che devono ancora essere risolti. Non c'è stata difficoltà nell'interpretare quel sogno, il sogno del bambino che bruciava, anche se l'interpretazione non è stata completa, secondo quanto intendiamo noi. Ho sollevato il problema del perché il sognatore non si fosse svegliato invece di sognare ed ho riconosciuto che uno dei motivi era il desiderio di rappresentare il bambino ancora vivo. Le nostre prossime esposizioni mostreranno che c'era anche un altro desiderio. Quindi in primo luogo per la realizzazione del desiderio il processo di pensiero durante il sonno è stato trasformato in un sogno. Se eliminiamo la realizzazione del desiderio, vedremo che resta un solo tratto per distinguere le due forme di evento psichico. Il pensiero del sogno sarebbe stato: «Vedo un bagliore proveniente dalla stanza dove giace il corpo morto. Forse una candela è caduta e mio figlio potrebbe bruciare». Il sogno ripeteva queste riflessioni senza modifiche, ma le rappresentava in una situazione che era effettivamente attuale e che poteva essere percepita attraverso i sensi come un'esperienza della veglia. Qui abbiamo la caratteristica psicologica più generale e più sorprendente del processo del sognare; un pensiero, e in genere il pensiero di qualcosa che si desidera, è oggettivato nel sogno, è rappresentato come una scena, o, come ci sembra, è vissuto. Allora come dobbiamo spiegare questa particolarità caratteristica del lavoro onirico, o, per porre la questione in termini più modesti, come dobbiamo trovarle un posto nel complesso dei processi psichici? Se osserviamo la faccenda più da vicino, scopriremo che spiccano due elementi caratteristici, quasi indipendenti l'uno dall'altro, che influenzano la forma assunta dal sogno. L'uno è il fatto che il pensiero viene rappresentato come situazione immediata senza il «forse», e l'altro è il fatto che il pensiero viene trasformato in immagini visive e parole. In questo sogno particolare può non colpire molto la trasformazione dei pensieri mediante la conversione della speranza in essi espressa nel tempo presente. Ciò avviene solo a causa della parte insolitamente subordinata, svolta in questo sogno dalla realizzazione di desiderio. Prendiamo invece un altro caso, dove il desiderio del sogno non è separato dai pensieri della veglia che sono continuati nel sogno, per esempio il sogno dell'iniezione di Irma. Là il pensiero del sogno che veniva rappresentato era un ottativo: «Magari Otto fosse responsabile della malattia di Irma!». Il sogno eliminava l'ottativo e lo sostituiva con un deciso presente: «Sì, Otto è responsabile della malattia di Irma». Questa dunque è la prima trasformazione prodotta tra i pensieri del sogno perfino da un sogno privo di deformazioni. Non c'è bisogno di indugiare su questa prima particolarità dei sogni. Possiamo esaurirla richiamando l'attenzione sulle fantasie coscienti, sui sogni ad occhi aperti, che trattano esattamente allo stesso modo il loro contenuto rappresentativo. Mentre il Monsieur Joyuse di Daudet vaga, senza lavoro, per le strade di Parigi (mentre le figlie credono che egli abbia un posto e sieda in un ufficio), egli sogna gli effetti che potrebbe avere un aiuto influente per cui egli troverebbe un impiego, e sogna al presente. Quindi i sogni sì servono del tempo presente allo stesso modo e con lo stesso diritto dei sogni a occhi aperti. Il tempo presente è quello in cui i desideri vengono rappresentati come realizzati. Ma i sogni si differenziano dai sogni ad occhi aperti per la loro seconda caratteristica: cioè per il fatto che il loro contenuto rappresentativo viene trasformato da pensieri in immagini sensorie, cui si crede e che sembrano vissute. Devo subito aggiungere che non tutti i sogni mostrano questa trasformazione da idea a immagine sensoria. Ci sono sogni che consistono solo in pensieri ma che mantengono nonostante ciò la natura essenziale di sogni. Il mio sogno «Autodidasker» rientra in quella categoria; esso conteneva appena qualche elemento sensorio in più che se avessi pensato a quel contenuto durante il giorno. E in ogni sogno di lunghezza considerevole ci sono degli elementi che non hanno ricevuto, come tutti gli altri, una forma sensoria, ma che sono semplicemente pensati o conosciuti, nel modo in cui siamo abituati a pensare o a conoscere le cose nella vita da svegli. Bisogna anche ricordare che non solo nei sogni avvengono tali trasformazioni di idee in immagini sensorie; si trovano anche nelle allucinazioni e nelle visioni, che possono sembrare entità indipendenti nelle persone sane, o sintomi nelle psiconevrosi. In breve, la relazione che stiamo ora esaminando non è esclusiva sotto alcun aspetto. Tuttavia resta vero che questa caratteristica dei sogni, quando è presente, ci colpisce come la più notevole; al punto che sarebbe impossibile per noi immaginare il mondo dei sogni senza di essa. Ma per poter arrivare a comprenderla, dobbiamo affrontare una discussione che ci porterà lontano. Come punto di partenza per la nostra indagine, vorrei scegliere una tra le molte osservazioni fatte sulla teoria dei sogni da coloro che hanno scritto sull'argomento. Nel corso di una breve trattazione del tema dei sogni, il grande Fechner avanza l'idea che la scena di azione dei sogni è diversa da quella della vita rappresentativa della veglia. Questa è l'unica ipotesi che rende comprensibili le speciali particolarità della vita onirica. Con queste parole ci si presenta l'idea di località psichica. Trascurerò completamente il fatto che l'apparato psichico che ci riguarda ci è anche noto sotto forma di preparato anatomico, ed eviterò accuratamente la tentazione di determinare la località psichica in senso anatomico. Resterò su basi psicologiche e propongo semplicemente di seguire il suggerimento di immaginare lo strumento che esegue le nostre funzioni psichiche come un microscopio composto, o un preparato fotografico, o qualcosa del genere. Su tale base, la località psichica corrisponderà ad un punto nell'interno dell'apparecchio dove appaiono gli stadi preliminari di un'immagine. Nel microscopio e nel telescopio, come sappiamo, in parte essi si trovano in punti ideali, dove non è collocato nessun elemento tangibile dell'apparato. Non vedo alcuna necessità di scusarmi per le imperfezioni di questo o di altri paragoni. Le analogie di questo tipo servono solo ad aiutarci nel tentativo di rendere comprensibili le complicazioni del funzionamento psichico scomponendo la funzione e assegnando i diversi elementi a diverse parti costituenti l'apparato. Per quanto io ne sappia non è stato finora fatto l'esperimento di usare questo metodo di dissezione per studiare il modo in cui viene messo insieme lo strumento psichico, e non vedo in questo niente di male. Secondo me siamo giustificati nel dare libero corso alle nostre supposizioni nella misura in cui conserviamo la calma nei giudizi e non confondiamo l'impalcatura con la costruzione. E poiché al nostro primo avvicinamento a qualcosa di sconosciuto ci è necessaria l'assistenza di rappresentazioni provvisorie, darò la preferenza alle ipotesi più rozze e concrete. Immagineremo dunque l'apparato mentale come uno strumento composto, alle cui componenti daremo il nome di «istanze», o (per maggiore chiarezza) di «sistemi». Bisogna poi anticipare che questi sistemi sono forse in rapporti spaziali costanti l'uno con l'altro, nello stesso modo in cui i vari sistemi di lenti in un telescopio sono disposti uno dietro l'altro. A rigore, non c'è bisogno di fare l'ipotesi che i sistemi psichici siano effettivamente disposti in un ordine spaziale. Sarebbe sufficiente stabilire un ordine fisso in modo che in un dato processo psichico l'eccitazione passi attraverso i sistemi in una particolare successione temporale. In altri processi la successione può essere diversa; lasceremo aperta questa possibilità. Per ragioni di brevità parleremo d'ora in avanti delle componenti dell'apparato come «sistemi φ». La prima cosa che ci colpisce è che questo apparato composto di sistemi φ abbia un senso o una direzione. Tutta la nostra attività psichica ha origine dagli stimoli (sia interni che esterni) e termina in innervazioni. Quindi attribuiremo un'estremità sensoria e una estremità motoria all'apparato. All'estremità sensoria c'è un sistema che riceve le percezioni; all'estremità motoria ce n'è un altro che apre la via all'attività motoria. I processi psichici avanzano in genere dall'estremità percettiva a quella motoria. Quindi l'immagine schematica più generale dell'apparato psichico si può rappresentare così: 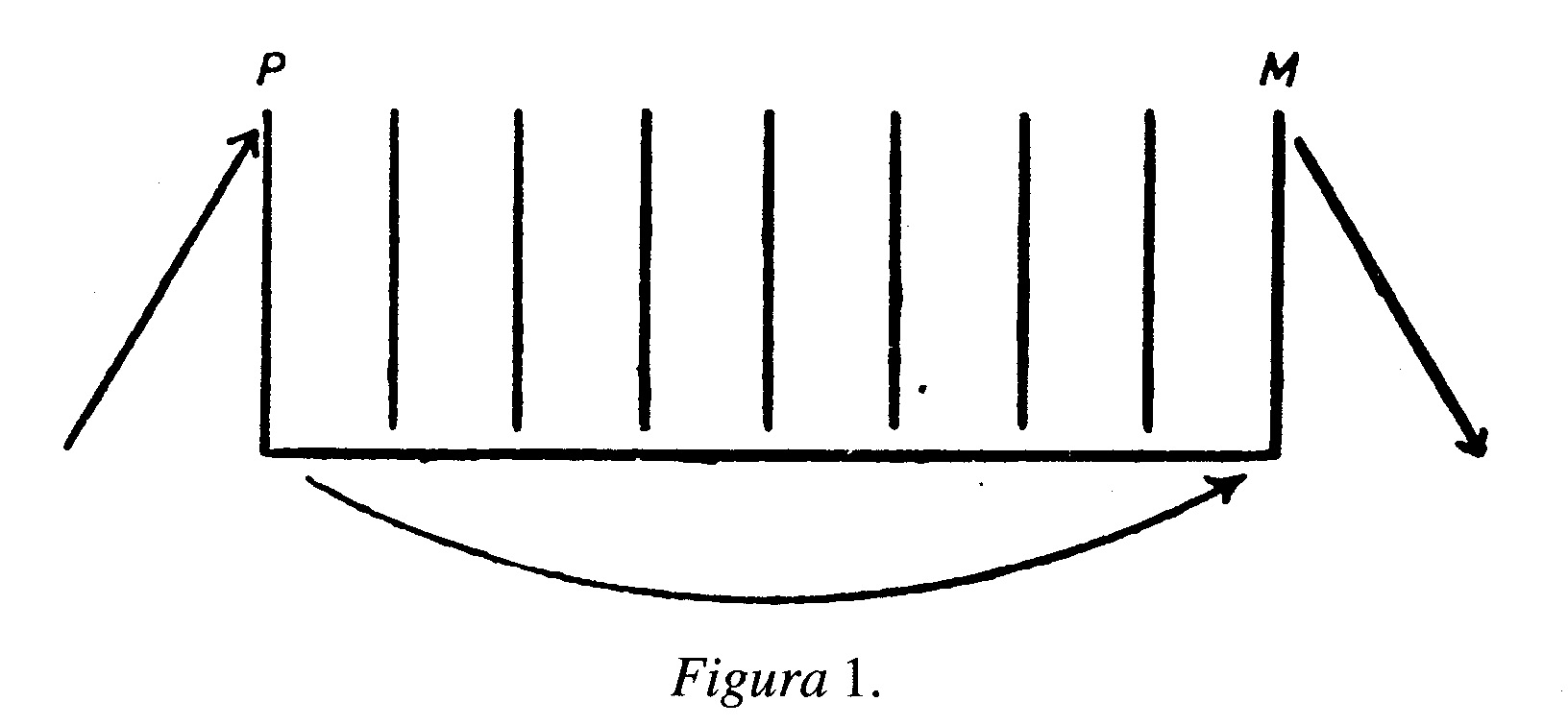 Ma questo non fa altro che soddisfare un'esigenza che ci è nota da tempo, cioè che l'apparato psichico si deve costruire come un apparato di riflesso. I processi di riflesso restano il modello di tutte le funzioni psichiche. Poi abbiamo le basi per introdurre una prima differenziazione all'estremità sensoria. Nel nostro apparato psichico resta una traccia delle percezioni che agiscono su di esso. Possiamo chiamarla «traccia mnestica»; e alla funzione che ad essa si riferisce diamo il nome di «memoria». Se siamo impazienti di attribuire processi psichici ai sistemi, le tracce mnestiche non sono altro che modificazioni permanenti degli elementi dei sistemi. Ma, come è già stato fatto rilevare altrove, ci sono ovvie difficoltà nella supposizione che lo stesso sistema possa accuratamente conservare le modificazioni dei suoi elementi e tuttavia restare perpetuamente aperto alla ricezione di nuove occasioni di modifiche. Quindi secondo il principio che regola il nostro esperimento, distribuiremo queste due funzioni a sistemi diversi. Supporremo che un sistema nella parte frontale dell'apparato riceva gli stimoli percettivi ma non trattenga tracce di essi e quindi non abbia memoria, mentre dietro di esso ci sia un secondo sistema che trasforma le eccitazioni momentanee del primo sistema in tracce permanenti. L'immagine schematica dell'apparato psichico sarebbe quindi la seguente: 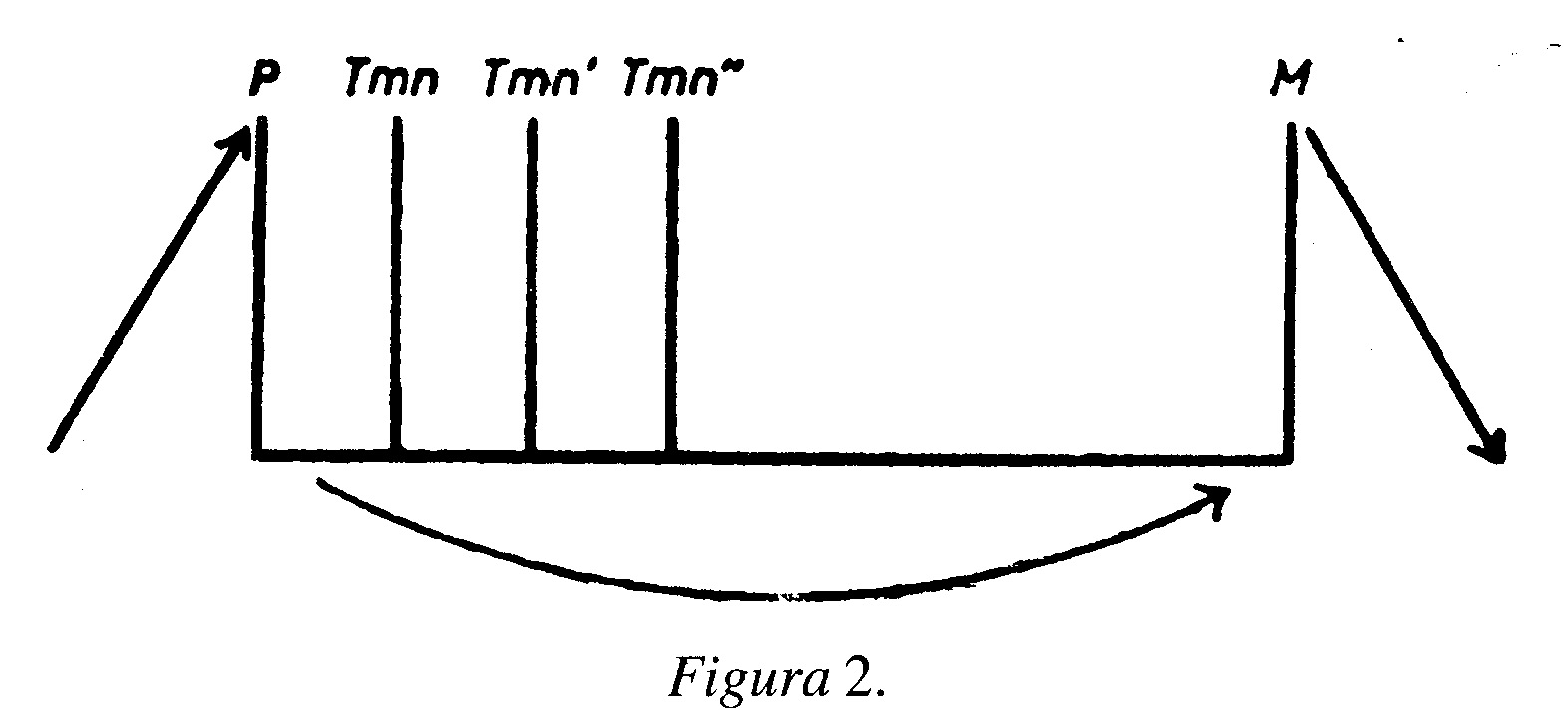 È un fatto noto che tratteniamo permanentemente qualcosa in più del mero contenuto delle percezioni che agiscono sul sistema P. Le nostre percezioni sono collegate l'una all'altra nella nostra memoria, prima di tutto per la coincidenza temporale. Questo fenomeno lo chiamiamo «associazione». È chiaro allora che, se il sistema P non ha affatto memoria, non può conservare le tracce associative; i singoli elementi P sarebbero insopportabilmente ostacolati nel compiere la loro funzione, se il residuo di una precedente associazione dovesse esercitare un'influenza su una nuova percezione. Dobbiamo quindi presumere che il fondamento dell'associazione si trovi nel fatto che, a causa della riduzione delle resistenze e della costituzione di vie d'accesso agevoli, un'eccitazione viene trasmessa da un elemento della memoria. L'esame più attento mostrerà la necessità di supporre l'esistenza non di uno ma di parecchi di questi elementi Tmn, in cui la stessa eccitazione trasmessa dagli elementi P lascia una varietà di diverse registrazioni permanenti. Il primo di questi sistemi Tmn contiene naturalmente la registrazione delle associazioni sotto l'aspetto della simultaneità; mentre lo stesso materiale percettivo sarà disposto nei sistemi seguenti secondo altri tipi di coincidenze, in modo che uno di questi ultimi sistemi, ad esempio, registrerà relazioni di somiglianza, e così via. Sarebbe naturalmente una perdita di tempo cercare di esprimere a parole il valore psichico di un sistema di questo genere. La sua caratteristica consisterebbe negli intimi particolari dei suoi rapporti con i diversi elementi del materiale grezzo della memoria, cioè, se vogliamo accennare ad una teoria più approfondita, nei vari gradi della resistenza di conduzione offerta da questi elementi al passaggio dell'eccitazione. A questo punto inserirò un'osservazione di carattere generale che potrebbe avere importanti conseguenze. Il sistema P che non è capace di mantenere le modificazioni e che quindi non ha memoria, fornisce alla nostra coscienza tutta la molteplicità delle qualità sensorie. D'altra parte, i nostri ricordi, anche quelli più profondamente impressi nella nostra mente, sono in se stessi inconsci. Possono esser resi coscienti, ma non c'è dubbio che possono produrre tutti i loro effetti in uno stato inconscio. Quello che noi chiamiamo il nostro «carattere» è basato sulle tracce di ricordi delle nostre impressioni e, inoltre, le impressioni che hanno provocato il più grande effetto su di noi, quelle della prima infanzia, sono proprio quelle che quasi mai diventano coscienti. Ma se i ricordi diventano coscienti di nuovo, non mostrano una qualità sensoria, o una molto debole in confronto alle percezioni. Se si potesse dimostrare che nei sistemi φ la memoria e la qualità che caratterizza la coscienza si escludono a vicenda, una luce molto promettente illuminerebbe le condizioni che regolano l'eccitamento neuronico. (In seguito ho suggerito che la coscienza sorge effettivamente al posto della traccia mnestica. Cfr. Notiz. iiber den Wunderblok.) Le supposizioni fatte finora riguardo alla costruzione dell'apparato psichico nella sua estremità sensoria sono state fatte senza riferimento ai sogni o alle informazioni psicologiche che da essi abbiamo dedotto. Tuttavia le prove evidenti date dai sogni ci aiuteranno a comprendere un'altra parte dell'apparato. Abbiamo visto che abbiamo potuto spiegare la formazione dei sogni solo basandoci sull'ipotesi dell'esistenza di due istanze psichiche, di cui l'una sottopone a critica l'attività dell'altra, il che implica la sua esclusione dalla coscienza. L'istanza critica, abbiamo concluso, si trova in una relazione più stretta con la coscienza che l'istanza criticata: rappresenta uno schermo tra quest'ultima e la coscienza. Inoltre abbiamo trovato dei motivi che ci hanno permesso di identificare l'istanza critica con l'istanza che dirige la nostra vita da svegli e determina le nostre azioni volontarie, coscienti. Se, secondo le nostre supposizioni, sostituiremo queste istanze con dei sistemi, allora la nostra ultima conclusione ci deve portare a collocare il sistema critico all'estremità motoria dell'apparato. Introdurremo ora i due sistemi nella nostra figura schematica e daremo loro dei nomi per esprimere la loro relazione con la coscienza: 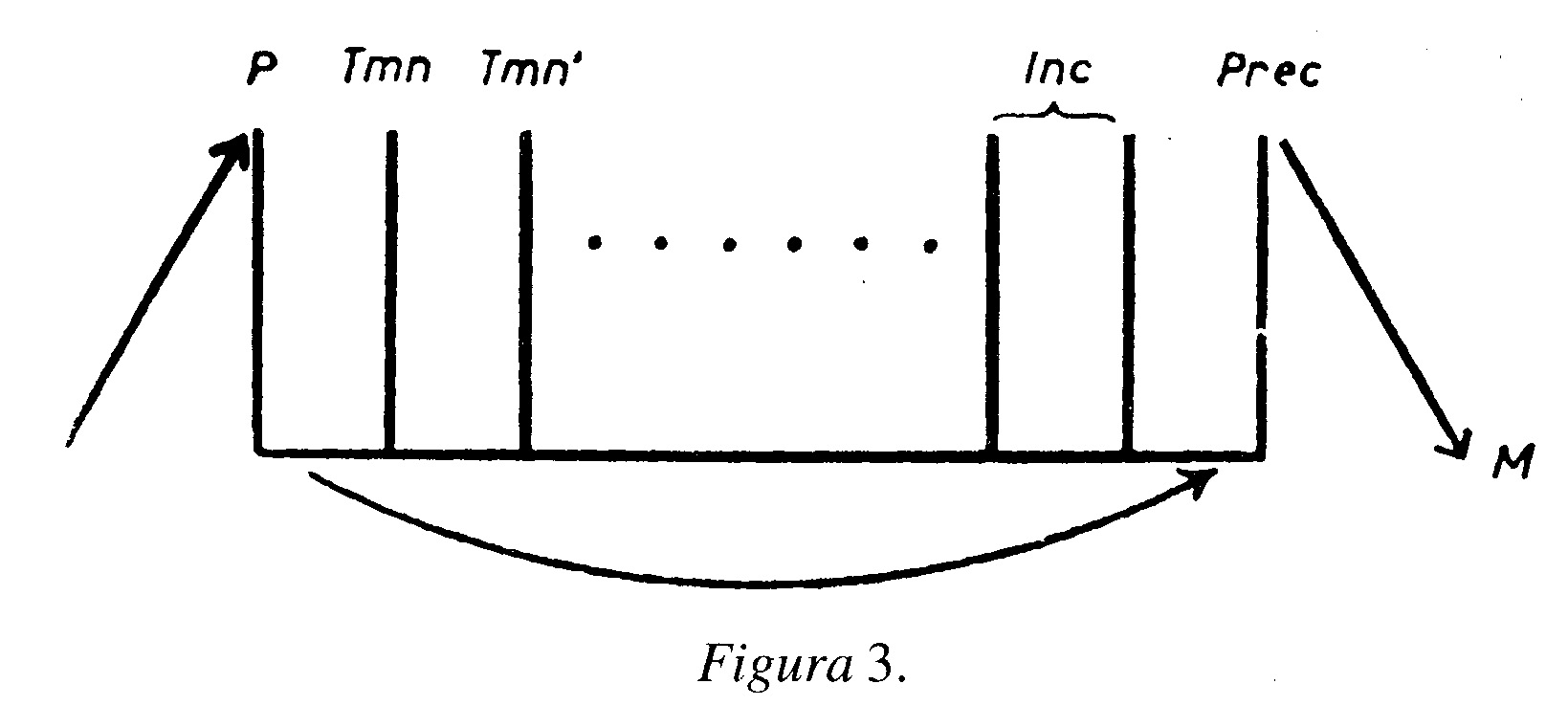 Chiameremo «preconscio» l'ultimo sistema dell'estremità motoria, per indicare che i processi di eccitazione presenti in esso possono entrare nella coscienza senza ulteriori impedimenti, purché siano soddisfatte certe condizioni: per esempio, che raggiungano un certo grado di intensità, che la funzione che chiamiamo «attenzione» sia distribuita in un modo particolare ecc. Questo è nello stesso tempo il sistema che possiede la chiave del movimento volontario. Chiameremo il sistema che giace dietro di esso «inconscio», perché non ha accesso alla coscienza se non attraverso il preconscio; e durante questo passaggio il processo di eccitamento è costretto a subire delle modifiche. (Se cercassimo di proseguire con questo schema in cui i sistemi sono posti in successione lineare, dovremmo tener conto del fatto che il sistema al di là del Prec. è quello al quale si deve attribuire la coscienza, in altre parole che P = C.) In quale di questi sistemi dobbiamo allora collocare l'impulso alla formazione dei sogni? Per semplicità, nel sistema Inc. È vero che nel corso della trattazione futura apprenderemo che ciò non è completamente esatto e che il processo di formazione dei sogni è costretto a collegarsi ai pensieri del sogno che appartengono al sistema preconscio. Ma se prendiamo in considerazione il desiderio del sogno, scopriremo che la forza motrice della produzione dei sogni è fornita dal sistema Inc.; e a causa di quest'ultimo fattore assumeremo il sistema inconscio come punto di partenza della formazione del sogno. Come tutte le altre strutture di pensiero questo istigatore del sogno farà uno sforzo per avanzare nel Prec. e quindi ottenere l'accesso alla coscienza. L'esperienza dimostra che questa via che porta attraverso il preconscio alla coscienza è sbarrata ai pensieri del sogno durante il giorno dalla censura di resistenza. Durante la notte essi sono in grado di accedere alla coscienza; ma come possano farlo e per quale cambiamento, resta un problema. Se ciò che permette ai pensieri del sogno di ottenere questo fosse il fatto che di notte c'è un abbassamento della resistenza che vigila al confine tra l'inconscio e il preconscio, allora faremmo dei sogni che avrebbero la stessa natura delle idee e che non avrebbero il carattere di allucinazione che al momento ci interessa. Quindi l'allentamento della censura tra i sistemi Inc. e Prec. può solo spiegare i sogni come il mio «Autodidasker» e non sogni come quello del bambino che brucia, che abbiamo preso come punto di partenza per la nostra indagine. Possiamo spiegare ciò che succede nei sogni allucinatolri solo affermando che l'eccitazione segue una via retrograda. Invece di essere trasmessa verso l'estremità motoria dell'apparecchio, si muove verso l'estremità sensoria e alla fine raggiunge il sistema percettivo. Se chiamiamo «progressiva» la direzione presa dai processi psichici provenienti dall'inconscio durante la veglia, allora possiamo dire dei sogni che hanno un carattere «regressivo». (II primo accenno al fattore della regressione si trova in Alberto Magno. Egli dice che l'immaginazione costruisce sogni dalle immagini di oggetti sensori che ha conservato e il processo si svolge nella direzione opposta a quella della vita da svegli. Hobbes scrive nel Leviathan: «Insomma i nostri sogni sono l'opposto dell'immaginazione sveglia: il movimento comincia da un'estremità quando siamo svegli, dall'altra quando sogniamo».) Questa regressione dunque è certamente una delle caratteristiche psicologiche del processo del sognatore; ma dobbiamo ricordare che ciò non avviene solo nei sogni. Il ricordo intenzionale e altri processi costitutivi del nostro normale pensare implicano un movimento di regressione nell'apparato psichico da un complesso atto rappresentativo al materiale grezzo delle tracce di ricordo su cui si basa. Nella veglia però questo movimento ali'indietro non si estende mai al di là delle immagini mnestiche; non riesce a far rivivere sotto forma allucinatoria le immagini percettive. Perché nel sogno le cose stanno diversamente? Nel prendere in considerazione il lavoro di condensazione dei sogni abbiamo supposto che l'intensità collegata alle rappresentazioni potesse essere trasferita dal lavoro onirico da una rappresentazione ad un'altra. Probabilmente è questa alterazione del normale procedimento psichico che rende possibile il percorso del sistema P nella direzione inversa, cominciando dai pensieri fino al culmine della piena vivacità sensoria. Non dobbiamo illuderci esagerando l'importanza di queste considerazioni. Non abbiamo fatto altro che dare un nome ad un fenomeno inspiegabile. Parliamo di «regressione» quando in un sogno la rappresentazione viene trasformata di nuovo nell'immagine sensoria da cui originariamente derivava. Ma anche questo passo richiede una giustificazione. A che serve dare dei nomi, se ciò non insegna niente di nuovo? Ritengo che il nome «regressione» ci sia di aiuto nella misura in cui collega un fatto che ci era già noto con la nostra immagine schematica, in cui l'apparato mentale ha ricevuto un senso o una direzione. Ed è a questo punto che quella figura comincia a ricompensarci per averla costruita. Infatti l'esaminarla, senza ulteriori riflessioni, rivela un'ulteriore caratteristica della formazione dei sogni. Se consideriamo il processo del sognatore come una regressione che avviene nel nostro ipotetico apparato psichico, arriviamo subito alla spiegazione del fatto empiricamente dimostrato che tutte le relazioni logiche che appartengono ai pensieri del sogno scompaiono durante l'attività onirica, o possono trovare espressione con molta difficoltà. Secondo la nostra figura schematica, queste relazioni non sono contenute nei primi sistemi Tmn ma negli ultimi; e nel caso della regressione essi dovrebbero necessariamente perdere qualsiasi mezzo di espressione tranne quello delle immagini percettive. Nella regressione la struttura dei pensieri del sogno viene disgregata nella sua materia prima. Quale cambiamento consente la regressione, e che non si può verificare durante il giorno? Dobbiamo accontentarci a questo punto solo di alcune congetture. Senza dubbio è questione di cambiamenti nella distribuzione dell'energia secondo i diversi sistemi, cambiamenti che aumentano o diminuiscono la facilità con cui tali sistemi possono essere percorsi dal processo di eccitazione. Ma in qualsiasi apparato di questo tipo gli stessi risultati sul passaggio delle eccitazioni possono essere prodotti in diversi modi. Naturalmente penseremo subito allo stato di sonno e ai cambiamenti di carica che produce all'estremità sensoria dell'apparecchio. Durante il giorno c'è una corrente continua che dal sistema P si riversa in direzione dell'attività motoria; ma questa corrente si ferma di notte e non potrebbe più essere di ostacolo alla corrente di eccitazioni che si svolge in senso opposto. Qui sembra che ci troviamo davanti al «chiudersi al mondo esterno» che alcuni autori considerano la spiegazione teorica delle caratteristiche psicologiche del sogno. Tuttavia, nello spiegare la regressione del sogno, dobbiamo tenere presenti le regressioni che si verificano anche negli stati patologici della veglia; e qui la spiegazione appena data ci abbandona. Infatti in tali casi la regressione si verifica nonostante il flusso continuo della corrente sensoria in direzione progressiva. Secondo me la spiegazione delle visioni nei soggetti psichicamente normali si trova nel fatto che esse sono effettivamente delle regressioni, cioè dei pensieri trasformati in immagini, ma che gli unici pensieri che subiscono questa trasformazione sono quelli strettamente collegati a ricordi che sono stati repressi o che sono rimasti inconsci. Per esempio, uno dei miei più giovani pazienti isterici, un ragazzo di dodici anni, non riusciva ad addormentarsi perché delle «facce verdi con gli occhi rossi» lo spaventavano. La causa di questo fenomeno era un ricordo represso, ma nello stesso tempo cosciente, di un ragazzo che aveva visto quattro anni prima. Questo ragazzo gli aveva offerto un quadro allarmante delle conseguenze delle cattive abitudini dei bambini, compresa la masturbazione, un'abitudine che ora il mio paziente si rimproverava retrospettivamente. La madre aveva rilevato a quel tempo che quel ragazzo che si comportava male aveva una faccia verdastra e occhi rossi. Ecco l'origine del suo spirito maligno, il cui unico scopo, oltre tutto, era di ricordargli un'altra delle predizioni di sua madre: che i ragazzi di quella specie diventavano idioti, non riuscivano a imparare niente a scuola e morivano giovani. Il mio piccolo paziente aveva realizzato una parte della profezia, poiché a scuola non faceva progressi e, come risultò dai suoi pensieri involontari, era terrorizzato riguardo l'altra parte. Posso aggiungere che dopo breve tempo il risultato del trattamento fu che egli riuscì ad addormentarsi, sparì la sua ansietà e ottenne un attestato di merito alla fine dell'anno scolastico. Sempre per lo stesso argomento, spiegherò una visione che mi fu descritta da una paziente isterica (una donna di quaranta anni), avuta prima che si ammalasse. Un mattino aprì gli occhi e vide suo fratello nella stanza, anche se sapeva che in realtà era in un manicomio. Il suo bambino dormiva in un letto accanto a lei. Per evitare che il bambino avesse paura e cadesse in convulsioni alla vista dello zio, gli coprì il viso con il lenzuolo, e allora l'apparizione svanì. La visione era una versione modificata di un ricordo dell'infanzia della signora; e, anche se cosciente, era strettamente collegato a tutto il materiale inconscio della sua mente. La governante le aveva detto che sua madre (che era morta molto giovane, quando la paziente aveva solo diciotto mesi) aveva sofferto di convulsioni epilettiche o isteriche, che risalivano ad uno spavento provocatole dal fratello (lo zio della paziente) che le era apparso travestito come un fantasma con un lenzuolo sulla testa. Quindi la visione conteneva gli stessi elementi del ricordo: l'apparizione del fratello, il lenzuolo, la paura e le conseguenze. Ma gli elementi erano stati disposti in un contesto differente e trasferiti su altre persone. Il motivo ovvio della visione, o dei pensieri che costituiva, era la preoccupazione che il suo bambino seguisse le orme dello zio, al quale rassomigliava molto fisicamente. I due esempi che ho citato non sono completamente privi di nesso con lo stato di sonno e per tale motivo non sono forse adatti per quello che voglio dimostrare. Rinvio quindi il lettore alla mia analisi di una donna sofferente di paranoia allucinata e alle scoperte delle mie ricerche ancora inedite sulla psicologia delle psiconevrosi, per dimostrare che in tali esempi di trasformazione regressiva dei pensieri non si deve trascurare l'influenza dei ricordi, particolarmente quelli infantili, che sono stati repressi o sono rimasti inconsci. I pensieri connessi con un ricordo di questo genere e la cui espressione è vietata dalla censura sono in certo senso attirati dal ricordo nella regressione, che è la forma di rappresentazione in cui il ricordo stesso si esprime. Posso anche ricordare che uno dei fenomeni riscontrati negli studi sull'isteria è che quando è possibile portare alla coscienza scene infantili (sia ricordi che fantasie), esse sono viste come allucinazioni e perdono tale caratteristica solo mentre vengono raccontate. Si sa inoltre che anche in quelle persone la cui memoria non è generalmente visiva, i primi ricordi dell'infanzia mantengono fino ad un'età avanzata la qualità di vivacità sensoria. Se ricordiamo l'importanza delle esperienze infantili nei pensieri del sogno, se pensiamo alle fantasie basate su di esse alla frequenza con cui parti di esse riappaiono nel contenuto del sogno e a quanto spesso i desideri del sogno stesso derivano da esse, non possiamo negare la probabilità che anche nei sogni la trasformazione dei pensieri in immagini visive possa essere in parte il risultato dell'attrazione che i ricordi espressi in forma visiva e desiderosi di rivivere esercitano sui pensieri tagliati fuori dalla coscienza, che lottano per trovare espressione. Secondo questa concezione il sogno si potrebbe definire un sostituto di una scena infantile modificata mediante la traslazione su una esperienza recente. La scena infantile è incapace di rivivere da sola e si deve accontentare di ritornare in un sogno. L'indicazione del modo in cui le scene infantili (o la loro riproduzione come fantasie) funzionano in un certo senso come modelli per il contenuto dei sogni elimina la necessità di una delle ipotesi avanzate da Scherner e dai suoi seguaci riguardo alle fonti di stimolo interne. Scherner suppone che, quando i sogni mostrano degli elementi visivi particolarmente vividi o particolarmente abbondanti, ci sia uno stato di «eccitazione visiva», cioè di eccitazione interna dell'organo della vista. Non c'è bisogno che confutiamo questa ipotesi, ma possiamo limitarci ad affermare che questo stato di eccitazione è applicabile solamente al sistema psichico percettivo dell'organo visivo; possiamo tuttavia rilevare ancora che lo stato di eccitazione è stato provocato da un ricordo, che è un rivivere di un'eccitazione visiva che a suo tempo fu immediata. Non trovo nella mia esperienza un buon esempio di ricordo infantile che abbia prodotto questa specie di risultato. Penso che i miei sogni siano in genere meno ricchi di elementi sensori rispetto a quelli delle altre persone. Ma nel caso del mio sogno più vivido e più bello di questi ultimi anni, sono riuscito facilmente a ricollegare la chiarezza allucinatoria del contenuto del sogno alle qualità sensorie di impressioni recenti o abbastanza recenti. Ho raccontato precedentemente un sogno in cui il colore blu scuro dell'acqua, il bruno del fumo che usciva dalle ciminiere di una nave e il bruno e rosso scuro degli edifici lasciarono in me una profonda impressione. Se mai un sogno si può far risalire ad uno stimolo visivo, questo era tale. Che cosa aveva portato il mio organo visivo a questo stato di eccitazione? Un'impressione recente che si ricollegava a numerose altre precedenti. I colori che vidi erano in primo luogo quelli di una scatola di costruzioni, con la quale, il giorno precedente il sogno, i miei figli avevano fatto un bell'edificio e me l'avevano fatto ammirare. I mattoni grandi erano dello stesso rosso scuro e quelli piccoli dello stesso blu e bruno. A questo si associarono le impressioni di colore dei miei ultimi viaggi in Italia: il bellissimo azzurro dell'Isonzo e delle lagune e il bruno del Carso. La bellezza dei colori nel sogno era solo una ripetizione di qualcosa che avevo già visto nel ricordo. Mettiamo insieme ciò che abbiamo scoperto circa la particolare tendenza del sogno a trasformare il suo contenuto rappresentativo in immagini sensorie. Non abbiamo ancora spiegato questa caratteristica del lavoro onirico, né l'abbiamo riferita ad alcuna legge psicologica nota; l'abbiamo piuttosto presa come qualcosa che suggerisce conseguenze sconosciute e l'abbiamo caratterizzata con il termine «regressiva». Noi abbiamo manifestato l'opinione che molto probabilmente questa regressione, dovunque sia presente, è un effetto della resistenza che ostacola il progresso del pensiero nella coscienza lungo la via normale, e contemporaneamente l'effetto dell'attrazione esercitata sul pensiero dalla presenza dei ricordi che possiedono grande forza sensoria. (In qualsiasi esposizione della teoria della regressione, si dovrebbe dire che un pensiero diventa rimosso ad effetto dell'influenza combinata di due fattori su di esso. Da una parte viene respinto (dalla censura della C.) e dall'altra viene tirato (dall'Ine.), allo stesso modo in cui la gente viene trasportata sulla cima della Grande Piramide.) Nel caso dei sogni, la regressione può forse essere ulteriormente facilitata dalla cessazione della corrente progressiva che scorre durante il giorno dagli organi sensori; in altre forme di regressione, l'assenza di questo fattore accessorio può essere compensata da una maggiore intensità degli altri motivi della regressione. Né dobbiamo dimenticare di osservare che in questi casi patologici di regressione, così come nei sogni, il processo del trasferimento di energia deve essere diverso da quello che è nelle regressioni che si presentano nella vita psichica normale, poiché nei primi casi quel processo rende possibile una completa occupazione allucinatoria dei sistemi percettivi. Ciò che nella nostra analisi del lavoro onirico abbiamo chiamato «considerazione della rappresentabilità» potrebbe essere messo in relazione con l'attrazione selettiva esercitata dalle scene ricordate visivamente, sfiorate dai pensieri del sogno. Bisogna ancora osservare che la regressione è altrettanto importante nella teoria della formulazione dei sintomi nevrotici che in quella dei sogni. Si devono quindi distinguere tre tipi di regressione: a) regressione topica, nel senso dell'immagine schematica dei sistemi φ che abbiamo spiegato sopra; b) regressione temporale, nella misura in cui si tratta di un ritorno alle antiche strutture psichiche; e e) regressione formale, in cui primitivi metodi di espressione e rappresentazione prendono il posto di quelli abituali. Ma tutti questi tre tipi di regressione sono in fondo una cosa sola e in genere si manifestano insieme; infatti ciò che è più antico nel tempo e più primitivo nella forma e nella topografia psichica si trova più vicino all'estremità percettiva. E non possiamo abbandonare il tema della regressione nei sogni prima di aver stabilito un'espressione verbale per la nozione che ci ha ripetutamente colpito e che ricorrerà con nuova intensità quando ci saremo addentrati più profondamente nello studio delle psiconevrosi: cioè che il sognatore è nel complesso un esempio di regressione alla primissima situazione del sognatore, un rivivere della sua infanzia, degli impulsi istintivi che l'hanno dominata e dei metodi di espressione che allora gli erano disponibili. Dietro a questa infanzia dell'individuo intravediamo il quadro di un'infanzia filogenetica, il quadro dello sviluppo della razza umana, di cui lo sviluppo individuale è in realtà un riassunto abbreviato, influenzato dalle circostanze fortuite della vita. Possiamo ora indovinare quanto sia centrata l'affermazione di Nietzsche che nei sogni «è in opera qualche residuo primordiale dell'umanità che ora non si può più raggiungere per via diretta»; e possiamo aspettarci che l'analisi dei sogni ci porti alla conoscenza dell'eredità arcaica dell'uomo, di ciò che è psichicamente innato in lui. Sembra che sogni e nevrosi abbiano conservato più antichità psichiche di quanto avremmo potuto immaginare; quindi la psicoanalisi può reclamare un posto importante tra le scienze che si occupano della ricostruzione dei primissimi periodi più oscuri dei primordi della razza umana. Può essere che questa prima parte del nostro studio psicologico dei sogni ci lasci con un senso di insoddisfazione. Ma possiamo consolarci con la considerazione che siamo stati costretti ad aprirci il cammino nel buio. Se non abbiamo sbagliato completamente, altre linee di approccio ci porteranno nella stessa regione e allora verrà forse il momento in cui ci troveremo più a nostro agio in essa. (C) REALIZZAZIONE DI DESIDERIOIl sogno del bambino che brucia, al principio di questo capitolo, ci dà la gradita opportunità di osservare le difficoltà che deve affrontare la teoria della realizzazione di desiderio. Senza dubbio saranno tutti rimasti sorpresi nel sentirsi dire che i sogni non sono altro che realizzazioni di desideri, e non solo a causa della contraddizione costituita dai sogni di angoscia. Quando al principio l'analisi ci ha rivelato che il significato e il valore psichico erano nascosti dietro ai sogni, eravamo senza dubbio completamente impreparati a scoprire che quel significato aveva un carattere così uniforme. Secondo la definizione esatta ma scarna di Aristotele, un sogno è il pensiero che continua (finché siamo addormentati) nello stato di sonno. Allora, dal momento che il nostro pensare del giorno produce atti psichici delle specie più varie - giudizi, deduzioni, obiezioni, aspettative, intenzioni ecc. -perché durante la notte sarebbe costretto a limitarsi alla produzione dei desideri? Non ci sono forse numerosi sogni che mostrano atti psichici di altri tipi, ad esempio preoccupazioni, trasformati in forma onirica? E non era forse proprio un sogno di questo tipo, particolarmente trasparente, quello con il quale abbiamo iniziato il capitolo? Quando il bagliore della luce arrivò agli occhi del padre che dormiva, egli trasse la preoccupata conclusione che una candela era caduta e avrebbe potuto bruciare il cadavere. Egli trasformò questa conclusione in un sogno rivestendola di una situazione sensoria e mettendola al presente. Quale ruolo aveva in ciò la realizzazione di desiderio? Possiamo non vedere in esso l'influenza predominante di un pensiero che continua dalla veglia o che è stato stimolato da una nuova impressione sensoria? Tutto questo è vero e ci spinge ad osservare più da vicino il ruolo svolto dalla realizzazione di desiderio nei sogni e l'importanza dei pensieri della veglia che continuano durante il sonno. La realizzazione di desiderio ci ha già indotto a dividere i sogni in due gruppi. Abbiamo trovato dei sogni che apparivano apertamente realizzazioni di desiderio, e altri in cui la realizzazione di desiderio non era riconoscibile e spesso era mascherata con tutti i mezzi possibili. Nell'ultimo caso abbiamo percepito l'attività della censura. Abbiamo trovato sogni di desiderio non deformati, principalmente tra i bambini; ma sogni brevi, apertamente di desiderio, sembravano (ci tengo a sottolineare questa riserva) verificarsi anche negli adulti. Possiamo poi chiederci da dove provengano i desideri che si avverano nei sogni. Nel porre questa domanda, quali possibilità di contrasto o quali alternative abbiamo in mente? Credo che si tratti del contrasto tra la vita del giorno percepita coscientemente e un'attività psichica rimasta inconscia, di cui diventiamo consapevoli solo durante la notte. Posso distinguere tre possibili origini di tale desiderio: 1. Può essersi destato durante il giorno, senza poter essere soddisfatto per ragioni esterne; in tal caso un desiderio conosciuto che non è stato realizzato durante il giorno è lasciato per la notte. 2. Può essere sorto durante il giorno ed essere stato rifiutato; in tal caso resta un desiderio che non è stato realizzato ma represso. 3. Può non avere alcuna relazione con la vita diurna ed essere uno di quei desideri che emergono solo dalla parte repressa della mente e diventano attivi in noi durante la notte. Se torniamo di nuovo alla nostra immagine schematica dell'apparato psichico, potremmo localizzare i desideri del primo tipo nel sistema Prec; supporremo che i desideri del secondo tipo siano andati dal sistema Prec. a quello Inc. dove si trova, se continua ad esistere; e concluderemo che gli impulsi di desiderio del terzo tipo siano del tutto incapaci di passare al di là del sistema Inc. Ci si chiede poi se i desideri derivati da queste fonti differenti siano di pari importanza per i sogni ed abbiano pari potere di provocarli. Se pensiamo ai sogni che abbiamo a disposizione per rispondere a questa domanda, ricorderemo subito che dobbiamo aggiungere una quarta origine dei desideri dei sogni, cioè gli impulsi di desiderio attuali che sorgono durante la notte (per es., quelli causati dalla sete o da esigenze sessuali). In secondo luogo, ci formeremo l'opinione che il luogo di origine del desiderio del sogno non ha alcuna influenza sulla sua capacità di provocare i sogni. Posso rammentare il sogno della bambina che prolunga la gita sul lago, interrotta durante il giorno, e gli altri sogni di bambini che ho raccontato. Li abbiamo spiegati attribuendoli a desideri non realizzati ma non repressi del giorno precedente. I casi di desideri che sono stati repressi durante il giorno e penetrano in un sogno sono numerosissimi. Aggiungerò un altro esempio molto semplice di questo gruppo: la sognatrice era una donna cui piaceva prendere in giro la gente ed aveva un'amica, più giovane di lei, che si era appena fidanzata. Tutto il giorno le sue conoscenze le avevano chiesto se conosceva il giovane e cosa ne pensava. Lei aveva risposto solo con delle lodi, ma aveva messo a tacere il suo vero giudizio; infatti le sarebbe piaciuto dire la verità, che era un «uomo dozzinale». Quella notte sognò che le facevano la stessa domanda e che rispondeva con la frase fatta: «Per ulteriori ordinazioni basta indicare il numero». Abbiamo appreso, infine, da numerose analisi che quando un sogno subisce la deformazione, il desiderio è sorto dall'inconscio e non poteva essere percepito durante il giorno. Quindi a prima vista sembra che tutti i desideri siano di eguale importanza e di eguale potenza nei sogni. Non posso qui fornire delle prove che nonostante tutto la verità è diversa; ma posso dire che ho la forte tendenza a ritenere che i desideri dei sogni siano più strettamente determinati. È vero che i sogni dei bambini dimostrano al di là di ogni dubbio che un desiderio che non è stato realizzato durante il giorno può provocare un sogno, ma non bisogna dimenticare che si tratta del desiderio di un bambino, un impulso di desiderio della forza propria dei bambini. Credo che sia molto dubbio che nel caso di un adulto un desiderio non realizzato durante il giorno possa essere abbastanza forte da produrre un sogno. Mi sembra invece, che con il progressivo controllo esercitato sulla vita istintiva dalla nostra attività intellettuale, tendiamo sempre più a rinunciare alla formazione e conservazione di desideri così intensi come quelli dei bambini. È possibile che a riguardo ci siano delle differenze individuali e che alcune persone conservino un tipo di processo psichico infantile più a lungo di altre, allo stesso modo in cui ci sono analoghe differenze riguardo alla diminuzione di immaginazione visiva, che nei primi anni è così vivida. Ma in generale credo che un desiderio che è rimasto irrealizzato dal giorno precedente non sia sufficiente a produrre un sogno nel caso di un adulto. Sono pronto ad ammettere che un impulso di desiderio proveniente dall'inconscio contribuisca alla provocazione del sogno, ma probabilmente non farà di i più. Il sogno non si materializzerebbe se il desiderio preconscio non riuscisse a trovare rinforzi altrove. E proprio dall'inconscio. La mia supposizione è che un desiderio cosciente può diventare suscitatore di un sogno solo se riesce a ridestare un desiderio inconscio affine e ad ottenere da esso rinforzi. Dalle indicazioni ricevute dalla psicoanalisi delle nevrosi, mi sono convinto che questi desideri inconsci sono sempre vigili, pronti in qualunque momento a trovare espressione, quando si presenta loro l'occasione di allearsi con un impulso cosciente e di trasferire la propria forte intensità su quella più debole dell'altro. (Essi dividono questo carattere di indistruttibilità con tutti gli altri atti mentali che sono veramente inconsci, cioè che appartengono solo all'Ine. Questi sono strade costruite una volta per tutte, che non cadono mai in disuso e che, quando, un'eccitazione inconscia le rioccupa, sono sempre pronte a portare alla scarica il processo di eccitazione. Se mi è concesso un paragone, essi sono soggetti ad annientamento solo nel senso valido per gli spiriti sotterranei dell'Odissea, che si svegliano a nuova vita se bevono del sangue. I processi dipendenti dal sistema preconscio sono distruttibili in tutt'altro senso. La psicoterapia delle nevrosi è basata su questa distinzione.) Sembrerà allora che solo il desiderio cosciente si sia realizzato nel sogno; solo poche piccole particolarità nella configurazione del sogno ci serviranno da segnale per metterci sulle tracce del potente alleato inconscio. Questi desideri dell'inconscio, sempre vigili e, per così dire, immortali, mi ricordano i leggendari Titani, sui quali gravano da ere primordiali le pesanti masse delle montagne che gli dèi vincitori lanciarono su di loro e che di tanto in tanto sono scosse dalla convulsione delle loro membra. Ma questi desideri tenuti sotto la repressione sono essi stessi di origine infantile, come ci insegna la ricerca psicologica sulle nevrosi. Propongo quindi di mettere da parte l'asserzione appena fatta, che la collocazione dell'origine dei desideri del sogno è indifferente, e sostituirla con un'altra di questo genere: un desiderio rappresentato in sogno deve essere infantile. Nel caso degli adulti, deriva dall'Inc, nel caso dei bambini, dove non c'è ancora divisione o censura tra Prec. e Inc., o dove quella divisione si va gradualmente stabilendo, si tratta di un desiderio non realizzato e non represso proveniente dalla veglia. Sono consapevole del fatto che questa affermazione non si può dimostrare universalmente; ma si può provare che vale spesso, anche in casi insospettati, e che non può essere negata in via generale. Secondo me, dunque, gli impulsi di desiderio che restano dalla veglia cosciente devono essere relegati ad una posizione secondaria rispetto alla formazione dei sogni. Per quanto riguarda il contributo al contenuto del sogno, non posso loro concedere una parte diversa da quella svolta, per esempio, dal materiale delle sensazioni che diventano attive proprio durante il sonno. Seguirò lo stesso filo di ragionamento nel volgermi ora a considerare quegli istigatori psichici del sognare, che restano dalla veglia e non sono desideri. Quando decidiamo di addormentarci, possiamo temporaneamente riuscire a porre termine all'attività dell'energia che agisce sui nostri pensieri da svegli. Chi può fare ciò facilmente ha un buon sonno; Napoleone I sembra essere stato un campione di questa categoria. Ma noi non riusciamo sempre a farlo, né ci riusciamo sempre completamente. Problemi non risolti, preoccupazioni che tormentano, impressioni profonde trasportano l'attività di pensiero nel sonno e sostengono processi psichici nel sistema che abbiamo chiamato «preconscio». Se desideriamo classificare gli impulsi di pensiero che continuano nel sonno, possiamo dividerli nei seguenti gruppi: 1. ciò che non è stato portato a conclusione durante il giorno per qualche ostacolo fortuito; 2. ciò che non è stato affrontato per insufficiente forza intellettuale, ciò che non è risolto; 3. ciò che è stato rifiutato e represso durante il giorno. A questi dobbiamo aggiungere: 4. un potente gruppo, composto di ciò che è stato messo in azione nel nostro Inc. dall'attività del preconscio nel corso del giorno; e infine 5. il gruppo di impressioni diurne che sono indifferenti e quindi rimaste sospese. Non si deve sottovalutare l'importanza dell'intensità psichica che viene introdotta nello stato di sonno da questi residui della vita del giorno, e particolarmente da quelli del gruppo dei problemi non risolti. E certo che queste eccitazioni cercano di esprimersi anche durante la notte; e possiamo ritenere con pari certezza che lo stato di sonno rende impossibile il normale compimento del processo eccitatorio nel preconscio e la sua conclusione di accesso alla coscienza. Finché i nostri processi di pensiero sono in grado di diventare coscienti nel modo normale di notte, vuol dire che non siamo addormentati. Non sono in grado di spiegare il cambiamento provocato dallo stato dì sonno nel sistema Prec. (Ho cercato di penetrare più profondamente nella comprensione dello stato di cose predominante durante il sonno e delle condizioni determinanti le allucinazioni in uno scritto intitolato Metapsychologische Ergänzung tur Traumlehre); ma senza dubbio le caratteristiche psicologiche del sonno devono essere cercate essenzialmente nelle modificazioni dell'occupazione di questo particolare sistema, sistema che controlla anche l'accesso alla motilità, paralizzata durante il sonno. D'altra parte nulla nella psicologia dei sogni mi dà ragione di pensare che il sonno produca delle modificazioni che non siano secondarie nello stato di cose che prevale nell'Inc. Quindi non resta aperta altra via alle eccitazioni notturne nel Prec. che quella seguita dalle eccitazioni di desiderio provenienti dall'Inc; le eccitazioni preconscie devono trovare rinforzi nellVnc. e devono accompagnare le eccitazioni inconscie lungo i loro percorsi indiretti. Ma quale è la relazione tra i residui preconsci del giorno precedente e i sogni? Senza dubbio essi penetrano nei sogni in gran quantità e si servono del contenuto dei sogni per penetrare nella coscienza anche durante la notte. Anzi, a volte dominano il contenuto del sogno e lo costringono a continuare l'attività del giorno. Inoltre, certamente i residui del giorno possono essere di desiderio o di qualsiasi altro carattere; ma è molto istruttivo a riguardo e di importanza decisiva per la teoria della realizzazione di desiderio osservare la condizione cui si devono sottoporre per essere ricevuti in un sogno. Prendiamo uno dei sogni che ho già raccontato, il cui contenuto in primo luogo era assurdo e in secondo luogo non era affatto un adempimento di desiderio. Allora cominciai a indagare sull'origine di questa inadatta espressione della preoccupazione che avevo provato durante il giorno e mediante l'analisi trovai un nesso nel fatto di aver identificato il mio amico con un certo barone L. e me stesso con il professor R. C'era una sola spiegazione della mia costrizione a scegliere questo particolare sostituto per i miei pensieri diurni. Dovevo essere preparato in qualsiasi momento nel mio Inc. a identificarmi con il professor R., poiché mediante quella identificazione uno dei desideri immortali dell'infanzia, la megalomania, si realizzava. Dei cattivi pensieri ostili verso il mio amico, che certamente sarebbero stati respinti durante il giorno, avevano afferrato l'opportunità di inserirsi con il desiderio e ottenere rappresentazione nel sogno; ma la mia preoccupazione del giorno aveva anche trovato una specie di espressione nel contenuto del sogno mediante un sostituto. Il pensiero del giorno, che in sé non era un desiderio ma al contrario una preoccupazione, fu costretto a trovare un nesso in un modo o nell'altro con un desiderio infantile inconscio e represso, che gli avrebbe permesso, se opportunamente trasformato, di «sorgere» nella coscienza. Più era dominante la preoccupazione, più forzato era il legame che si poteva stabilire; non c'era bisogno che ci fosse alcun nesso tra il contenuto del desiderio e quello della preoccupazione, e in realtà non c'era nel nostro esempio tale nesso. Sarà forse utile continuare ad esaminare lo stesso problema prendendo in considerazione il comportamento di un sogno quando i pensieri del sogno gli offrono del materiale che è completamente l'opposto della realizzazione di desiderio: preoccupazioni fondate, riflessioni dolorose, conclusioni penose. I molti risultati possibili possono essere classificati nei due seguenti gruppi. A: Il lavoro onirico può riuscire a sostituire tutte le rappresentazioni penose con altre contrarie e a reprimere gli effetti sgradevoli ad esse collegati. Ne risulterà direttamente un sogno di soddisfazione, una tangibile «realizzazione di desiderio», sulla quale sembra non ci sia altro da dire. B: Le rappresentazioni penose entrano, più o meno modificate ma in ogni caso completamente riconoscibili, nel contenuto manifesto del sogno. Questo è il caso che solleva dei dubbi sulla validità della teoria di desiderio dei sogni e richiede uno studio più approfondito. I sogni di questo tipo con contenuto penoso possono essere vissuti con indifferenza, o possono essere accompagnati da tutto l'affetto penoso che il loro contenuto sembra giustificare, o possono perfino portare allo sviluppo dell'angoscia e al risveglio. L'analisi riesce a dimostrare che questi sogni sgradevoli sono realizzazioni di desiderio come tutti gli altri. Un desiderio inconscio e represso, la cui realizzazione sarebbe certamente per il sognatore un'esperienza penosa, ha afferrato l'opportunità offertagli dal persistere dei residui penosi del giorno precedente, ha offerto loro il suo sostegno e in tal modo ha permesso loro di entrare in un sogno. Ma mentre nel gruppo A il desiderio inconscio coincide con quello cosciente, nel gruppo B si rivela l'abisso tra l'inconscio e il conscio (tra il materiale represso e l'Io) e si realizza la situazione della fiaba dei tre desideri concessi dalla fata al marito e alla moglie. La soddisfazione per la realizzazione del desiderio represso può risultare così grande da controbilanciare le sensazioni penose unite ai residui del giorno; in tal caso il tenore affettivo del sogno è indifferente, nonostante esso sia da una parte la realizzazione di un desiderio e dall'altra la realizzazione di una paura. Oppure può accadere che l'Io addormentato contribuisca di più alla formazione del sogno, che reagisca alla soddisfazione del desiderio represso con violento sdegno e interrompa il sogno con il prorompere dell'angoscia. Quindi non è difficile vedere che i sogni sgradevoli e i sogni di angoscia sono realizzazioni di desiderio nella nostra teoria quanto lo sono i sogni di soddisfazione diretta. I sogni spiacevoli possono anche essere «sogni di punizione». Bisogna ammettere che il riconoscerli implica in un certo senso una nuova aggiunta alla teoria dei sogni. Ciò che in loro viene realizzato è ugualmente un desiderio inconscio, cioè il desiderio che il sognatore possa essere punito per un impulso represso e proibito. Entro tale limite i sogni di questo tipo rientrano nella condizione esposta, che la forza motrice della formazione di un sogno debba essere fornita da un desiderio appartenente all'inconscio. Ma un'analisi psicologica più approfondita dimostra che essi differiscono di molto dagli altri sogni di desiderio. Nei casi del gruppo B il desiderio che forma il sogno è inconscio e appartiene al materiale represso, mentre nei sogni di punizione il desiderio, anche se è ugualmente inconscio, non appartiene al materiale represso ma all'«Io». Quindi i sogni di punizione indicano la possibilità che l'Io abbia una partecipazione più ampia di quella presunta nella formazione dei sogni. Il meccanismo della formazione del sogno sarebbe in generale molto più chiaro se al posto dell'opposizione tra «conscio» e «inconscio», parlassimo di «Io» e «materiale rimosso». Questo comunque non si può fare senza prendere in considerazione i processi sottostanti alle psiconevrosi e per tale motivo non abbiamo potuto farlo nel presente lavoro. Aggiungerò solo che i sogni di punizione in genere non sono soggetti alla condizione che i residui del giorno siano penosi. Anzi si manifestano molto più facilmente nel caso opposto, quando i resti del giorno sono pensieri di soddisfazione, ma la soddisfazione che esprimono è proibita. L'unica traccia di questi pensieri che appare nel sogno manifesto è il loro opposto, come nel caso dei sogni che appartengono al gruppo A. La caratteristica essenziale dei sogni di punizione sarebbe quindi che nel loro caso il desiderio che forma il sogno non è un desiderio inconscio che deriva dal represso (dal sistema Inc.), ma un desiderio punitivo che reagisce contro di esso e appartiene all'Io, anche se nello stesso tempo è inconscio (cioè preconscio). Racconterò un mio sogno per illustrare quanto ho appena detto e in particolare il modo in cui il lavoro onirico tratta un residuo di aspettativa penosa del giorno precedente. «Inizio indistinto. Dissi a mia moglie che avevo una notizia per lei, qualcosa di molto particolare. Lei sì impaurì e rifiutò di ascoltare. La rassicurai che anzi si trattava di qualcosa che le avrebbe fatto molto piacere sapere e cominciai a dirle che il corpo ufficiali di nostro figlio aveva mandato una somma dì denaro (5000 corone?)... qualcosa sulla distinzione... distribuzione... Intanto ero andato con lei in una stanzetta, come una dispensa, per cercare qualcosa. Improvvisamente apparì mio figlio. Non era in uniforme, ma indossava un abito sportivo molto attillato (come una foca?) con un berretto. Egli si arrampicò su un cesto che era accanto ad un armadio, come se volesse mettere qualcosa sull'armadio. Io lo chiamai: nessuna risposta. Mi sembrava che il suo viso o la sua fronte fosse fasciata. Si stava sistemando qualcosa in bocca, vi spingeva dentro qualcosa. E i capelli erano spruzzati di grigio. Pensai: E possibile che sia così esausto? Ed ha dei denti finti?". Prima di poterlo chiamare di nuovo, mi svegliai, senza provare angoscia ma il mio cuore batteva rapidamente. La mia sveglia segnava le due e trenta». Anche questa volta mi è impossibile presentare un'analisi completa. Mi devo limitare a far rilevare pochi punti salienti. Le aspettative penose del giorno precedente avevano dato origine al sogno: eravamo di nuovo stati senza notizie di nostro figlio al fronte per più di una settimana. È chiaro che il contenuto del sogno esprimeva la convinzione che egli fosse stato ferito o ucciso. Al principio del sogno erano evidenti gli sforzi fatti per sostituire i pensieri penosi con il loro contrario. Io avevo delle notizie molto piacevoli da comunicare: qualcosa riguardante denaro spedito... distinzione... distribuzione. (La somma di denaro derivava da un piacevole episodio dell'esercizio della mia professione; era un tentativo di sviare dall'argomento). Questi sforzi però fallirono. Mia moglie sospettava qualcosa di spaventoso e rifiutava di ascoltarmi. Il travestimento era troppo sottile e i riferimenti a ciò che cercava di reprimere emergevano da tutte le parti. Se mio figlio fosse stato ucciso, i suoi compagni ufficiali avrebbero rispedito le sue cose e io avrei dovuto distribuire ciò che restava tra i suoi fratelli e le sorelle e altre persone. Un «riconoscimento» viene spesso assegnato all'ufficiale che cade in battaglia. Quindi il sogno esprimeva direttamente ciò che al principio aveva cercato di negare, anche se la tendenza alla realizzazione di desiderio era ancora attiva nelle deformazioni. (Il cambiamento di località nel corso del sogno deve essere senza dubbio ciò che Silberer ha chiamato «simbolismo della soglia»). Non sappiamo, è vero, cosa fornisse al sogno la forza motrice per dare in tal modo espressione ai miei pensieri penosi. Mio figlio non mi appariva come uno che «cade», ma come uno che si «arrampica». E in effetti era stato un abile scalatore. Non era in uniforme, ma in abiti sportivi; ciò significa che al posto dell'incidente che ora temevo, ce n'era un altro precedente, sportivo; infatti era caduto sciando e si era rotto il femore. D'altra parte il modo in cui era vestito, che lo faceva rassomigliare a una foca, ricordava una persona più giovane, il nostro buffo nipotino; mentre i capelli grigi mi ricordavano il padre di questi, nostro genero, che era stato duramente colpito dalla guerra. Cosa poteva significare tutto ciò?... Ma ho detto abbastanza. La dispensa e l'armadio dal quale egli voleva prendere qualcosa («sul quale voleva mettere qualcosa», nel sogno) erano allusioni che mi ricordavano inequivocabilmente un episodio che mi era capitato tra i due e i tre anni di età. Mi ero arrampicato su uno sgabello nella dispensa per prendere qualcosa di buono che era su un armadio o su una tavola. Lo sgabello si era ribaltato e uno spigolo aveva colpito la mia mascella inferiore; avrei potuto benissimo perdere tutti i denti. Il ricordo si univa ad un pensiero di ammonizione: «ti sta bene»; e questo sembrava un impulso ostile diretto al coraggioso soldato. L'analisi più approfondita mi permise di scoprire quale fosse l'impulso nascosto che avrebbe potuto trovare soddisfazione nell'incidente temuto di mio figlio: si trattava dell'invidia provata verso i giovani da coloro che sono diventati vecchi, ma che credono di averla completamente soffocata. E senza dubbio era proprio la forza dell'emozione dolorosa che sarebbe sorta se fosse davvero capitata tale disgrazia che faceva sì che l'emozione cercasse una realizzazione di desiderio rimosso di questo tipo per avere una qualche consolazione. Sono ora in condizioni di fare un'esposizione precisa del ruolo svolto nei sogni dal desiderio inconscio. Sono pronto ad ammettere l'esistenza di un'intera classe di sogni che vengono provocati principalmente o anche esclusivamente dai resti della vita diurna; e credo che perfino il mio desiderio di diventare un giorno professore straordinario mi avrebbe lasciato dormire in pace tutta la notte, se non fosse continuata dal giorno precedente la mia preoccupazione per la salute del mio amico. Ma solo la preoccupazione non avrebbe potuto fare un sogno. La forza motrice richiesta dal sogno doveva essere fornita da un desiderio; era compito della preoccupazione l'impadronirsi di un desiderio che agisse come forza motrice del sogno. La situazione si potrebbe spiegare con un'analogia. Un pensiero del giorno può benissimo fare la parte dell'imprenditore di un sogno; ma l'imprenditore che, come si dice, ha l'idea e l'iniziativa per svolgerla, non può far niente senza capitale; ha bisogno di un capitalista che possa affrontare la spesa, e il capitalista che fornisce l'esborso psichico per il sogno è sempre e inconfutabilmente, quali che siano i pensieri del giorno precedente, un desiderio proveniente dall'inconscio. A volte il capitalista è egli stesso imprenditore e anzi, nel caso dei sogni, questo è il fatto più comune: un desiderio inconscio viene destato dall'attività del giorno e procede a formare un sogno. Così anche le altre possibili variazioni nella situazione economica che ho preso per analogia hanno il loro parallelo nei processi onirici. L'imprenditore può egli stesso dare un piccolo contributo al capitale; molti imprenditori possono rivolgersi allo stesso capitalista; molti capitalisti possono mettersi d'accordo per riunire ciò che è necessario all'imprenditore. Allo stesso modo incontriamo sogni che sono sostenuti da più di un desiderio e così anche altre simili variazioni, che si potrebbero facilmente osservare, ma che non ci interessano più. Dobbiamo rimandare a più tardi ciò che resta da dire sul desiderio del sogno. Il tertium comparationis nell'analogia che ho appena usato, la quantità messa a disposizione dell'imprenditore in misura appropriata, si può applicare con dettaglio ancora maggiore allo scopo di chiarire la struttura dei sogni. Nella maggior parte dei sogni è possibile localizzare un punto centrale segnato da una particolare intensità sensoria, come ho indicato prima. Questo punto centrale è in genere la rappresentazione diretta della realizzazione di desiderio; infatti, se distiamo gli spostamenti prodotti dal lavoro onirico, troviamo che l'intensità psichica degli elementi dei pensieri del sogno è stata sostituita da un'intensità sensoria negli elementi del contenuto del sogno effettivo. Gli elementi circostanti la realizzazione di desiderio spesso non hanno niente a che fare con il suo significato, ma risultano dei derivati di pensieri penosi di tenore contrario al desiderio. Ma poiché sono legati da un nesso artificiale all'elemento centrale, hanno acquistato sufficiente intensità da diventare suscettibili di rappresentazione nel sogno. Così la forza della realizzazione di desiderio nel produrre la rappresentazione si estende su una certa sfera che la circonda, entro la quale tutti gli elementi, anche quelli che non possiedono mezzi propri, acquistano forza per ottenere rappresentazione. Nel caso di sogni con più desideri motori, è facile delimitare le sfere delle varie realizzazioni di desiderio e le lacune del sogno si possono spesso spiegare come zone di confine tra tali sfere. Anche se le precedenti considerazioni hanno ridotto l'importanza della parte svolta dai resti diurni nei sogni, vale la pena di dedicare ad essi ancora un po' di attenzione. Essi devono essere degli elementi essenziali nella formazione dei sogni, poiché l'esperienza ha rivelato il fatto sorprendente che nel contenuto di tutti i sogni si può trovare qualche legame con una recente impressione del giorno, spesso molto insignificante. Finora non siamo stati in grado di spiegare la necessità di questa aggiunta al miscuglio che costituisce un sogno. Ed è possibile farlo solo se si tiene bene presente il ruolo svolto dal desiderio inconscio e poi si cercano informazioni nella psicologia delle nevrosi. Apprendiamo da quest'ultima che una rappresentazione inconscia è come tale completamente incapace di entrare nel preconscio e che può esercitare qualche effetto su di esso solo stabilendo un nesso con una rappresentazione che già appartiene al preconscio, trasferendo su di essa la sua intensità e servendosene come di una «copertura». E qui abbiamo il fenomeno del transfert, che fornisce una spiegazione per tanti fatti strani della vita psichica dei nevrotici. La rappresentazione preconscia che acquista in tal modo un immeritato grado di intensità può essere lasciata inalterata dal transfert o può essere costretta ad un cambiamento, proveniente dal contenuto della rappresentazione che effettua il transfert. Mi auguro di poter essere perdonato del mio trarre analogie dalla vita di tutti i giorni, ma ho la tentazione di dire che la posizione di una rappresentazione rimossa rassomiglia a quella di un dentista americano in questo paese: non gli è permesso di esercitare la sua professione, a meno che non si serva di un professionista legalmente qualificato come «copertura» agli occhi della legge. E così come non sono i professionisti più affermati che fanno delle alleanze di questo tipo con i dentisti, così allo stesso modo le rappresentazioni preconscie o inconscie che hanno già attirato una sufficiente quantità di attenzione, che è in attività nel preconscio, non saranno quelle scelte per copertura di una rappresentazione repressa. L'inconscio preferisce intessere i suoi nessi intorno ad impressioni preconscie e a rappresentazioni che o sono indifferenti e quindi non hanno richiamato affatto l'attenzione, o sono state rifiutate e quindi sono state subito private dell'attenzione. Un noto principio della teoria associativa, che è stato interamente confermato dall'esperienza, è che una rappresentazione collegata con un nesso molto stretto in una direzione tende in un certo senso a respingere interi gruppi di nuove associazioni. Una volta ho cercato di basare una teoria delle paralisi isteriche su questa affermazione. Se presumiamo che la stessa esigenza di transfert da parte delle idee represse che abbiamo scoperto nell'analisi delle nevrosi sia attiva anche nei sogni, si risolvono di colpo due enigmi dei sogni: il fatto, principalmente, che ogni analisi di un sogno mostri delle impressioni recenti intessute nel suo contesto e che questo elemento recente sia spesso molto insignificante. Posso aggiungere che (come abbiamo già scoperto altrove) le ragioni per cui questi elementi recenti e indifferenti penetrano così spesso nei sogni come sostituti dei più antichi pensieri onirici consistono nel fatto che essi hanno ben poco da temere da parte della censura imposta dalla resistenza. Ma mentre il fatto che si preferiscono gli elementi triviali si spiega mediante la loro libertà dalla censura, il fatto che gli elementi recenti si manifestino con tale regolarità indica l'esistenza di un'esigenza di transfert. Entrambi i gruppi di impressioni soddisfano la richiesta del represso di materiale ancora libero da associazioni: le indifferenti perché non hanno offerto la possibilità di formare molti legami, e quelle recenti perché non hanno ancora avuto tempo di formarne. Vedremo poi che i resti diurni, tra cui possiamo ora classificare le impressioni indifferenti, non solo prendono in prestito qualcosa dall'Inc quando riescono a partecipare alla formazione di un sogno, cioè la forza istintiva che è la disposizione del desiderio represso, ma offrono anche all'inconscio qualcosa di indispensabile, cioè il necessario punto di attacco per un transfert. Se volessimo addentrarci di più a questo punto nei processi psichici, dovremmo maggiormente chiarire il gioco delle eccitazioni tra preconscio e inconscio, argomento verso il quale ci attira lo studio delle psiconevrosi, ma il sogno non ci può dare alcun aiuto a riguardo. Devo aggiungere solo un'altra cosa sui residui del giorno. Sono essi senz'altro i veri disturbatori del sonno e non i sogni, che anzi cercano di proteggerlo. Ritornerò in seguito su questo punto. Finora abbiamo studiato i desideri del sogno: siamo risaliti alle loro origini nella zona dell'Inc. e abbiamo analizzato i loro rapporti con i residui del giorno, che a loro volta possono essere desideri o impulsi psichici di qualche altro tipo o semplicemente impressioni recenti. In tal modo abbiamo ammesso tutte le rivendicazioni sollevate dalle numerose attività del pensiero da svegli sull'importanza del ruolo da esse svolto nel processo di formazione dei sogni. La nostra esposizione potrebbe anche aver fornito la spiegazione dei casi estremi in cui il sogno, prolungando le attività del giorno, arriva ad una felice soluzione di qualche problema non ancora risolto della veglia. Ci serve un esempio di questo tipo, in modo da poterlo analizzare e ritrovare la fonte dei desideri infantili o repressi, il cui aiuto ha cooperato e rinforzato l'attività preconscia con tanto successo. Ma tutto ciò non ci ha avvicinato alla soluzione dell'enigma sul perché l'inconscio non abbia altro da offrire durante il sonno se non le forze motrici per la realizzazione di un desiderio. La risposta a questa domanda deve chiarire la natura psichica dei desideri ed io intendo rispondere riferendomi alla nostra figura schematica dell'apparato psichico. È fuori dubbio che quell'apparato ha raggiunto la sua perfezione attuale solo dopo un lungo periodo di sviluppo. Cerchiamo di riportarlo ad uno stadio anteriore della sua capacità operativa. Ipotesi la cui giustificazione si deve ricercare altrove ci dicono che al principio gli sforzi dell'apparato erano concentrati nel mantenersi il più libero possibile dagli stimoli; di conseguenza la sua prima struttura seguiva lo schema di un apparato riflesso, in modo che qualsiasi eccitazione sensoria che agiva su di esso poteva essere prontamente scaricata lungo un percorso motorio. Ma le esigenze della vita interferiscono con questa semplice funzione e l'apparato deve ad esse l'impulso a svilupparsi ulteriormente. Le esigenze della vita lo avvicinano in primo luogo ai maggiori bisogni del corpo. Le eccitazioni prodotte dai bisogni interni cercano di scaricarsi con il movimento, che si può chiamare «cambiamento interno» o «espressione di emozione». Un bimbo affamato urla o si agita sconsolatamente. Ma la situazione resta inalterata, poiché l'eccitazione proveniente da un bisogno interno non è dovuta ad una forza che produce un'azione momentanea, ma ad una forza che è in continua attività. Un cambiamento si può produrre solo se in un modo o nell'altro (nel caso del bimbo mediante aiuto esterno) si può ottenere una «esperienza di soddisfazione» che metta fine allo stimolo interno. Una componente essenziale di questa esperienza di soddisfazione è una particolare percezione (nel nostro esempio quella del nutrimento), la cui immagine resta da quel momento associata nella memoria con la traccia mnestica dell'eccitazione prodotta dal bisogno. La conseguenza del legame così stabilito è che, quando questo bisogno sorge di nuovo, un impulso psichico emerge immediatamente e cerca di rioccupare l'immagine mnestica e rievocare la percezione stessa, cioè ristabilire la situazione della soddisfazione originaria. Un impulso di questo tipo è quello che chiamiamo un desiderio; la ricomparsa della percezione è la soddisfazione del desiderio, ed il cammino più breve per raggiungerlo è quello che porta direttamente dall'eccitazione prodotta dal bisogno all'occupazione completa della percezione. Nulla ci impedisce di pensare che ci sia stato veramente uno stato primitivo dell'apparato psichico in cui questo cammino veniva realmente percorso, cioè in cui il desiderio diventava allucinazione. Quindi lo scopo di questa prima attività psichica era quello di produrre una «identità percettiva», una ripetizione della percezione collegata con la soddisfazione del bisogno. L'amara esperienza della vita deve aver mutato questa primitiva attività di pensiero in una secondaria più ingegnosa. L'identità percettiva, stabilita lungo il breve cammino della regressione all'interno dell'apparato, non ha lo stesso effetto altrove nella mente, a differenza della catessi della stessa percezione dall'esterno. Non segue soddisfazione, il bisogno continua. Una catessi interna potrebbe avere lo stesso valore di quella esterna se fosse mantenuta costantemente, come in realtà avviene nelle psicosi allucinatorie e nelle fantasie degli affamati, che esauriscono tutta la loro attività psichica nell'afferrarsi all'oggetto dei loro desideri. Per arrivare ad un impiego più efficiente della forza psichica è necessario fermare la regressione prima che diventi completa, in modo che non proceda oltre l'immagine mnestica e possa cercare altre vie che la portino all'identità percettiva descritta, stabilita dal mondo esterno. (In altre parole, diventa evidente che ci deve essere un mezzo di «prova della realtà».) Questa inibizione della regressione e la conseguente deviazione dell'eccitazione diventavano il compito di un secondo sistema, che controlla il movimento volontario, che cioè si serve per la prima volta del movimento per i fini ricordati precedentemente. Ma tutta la complicata attività di pensiero che si estende dall'immagine di memoria al momento in cui l'identità percettiva viene stabilita dal mondo esterno costituisce semplicemente un cammino indiretto verso la realizzazione di desiderio che è stato reso necessario dall'esperienza. (L'attività di realizzazione di desiderio dei sogni è giustamente esaltata da Le Lorrain, che ne parla come di un'attività «senza seria fatica, senza la costrizione a ricorrere a quella lotta lunga e ostinata che consuma e corrode i godimenti perseguiti».) Il pensiero dopo tutto non è altro che un sostituto di un desiderio allucinatorio; ed è ovvio che i sogni debbano essere realizzazioni di desiderio, dal momento che solo un desiderio può azionare il nostro apparato psichico. I sogni che realizzano i desideri attraverso la breve via della regressione hanno semplicemente conservato per noi, sotto quell'aspetto, un esempio del primitivo metodo di funzionamento dell'apparato psichico, un metodo che è stato abbandonato perché inefficace. Ciò che una volta dominava la vita della veglia, quando la mente era ancora giovane e incompetente, sembra ora esiliato nella vita notturna, come le armi primitive, l'arco e le frecce, che sono state abbandonate dagli adulti, ma che tornano di nuovo nella stanza dei bambini. Il sognare è una parte della vita psichica infantile che è stata accantonata. Questi modi di lavorare da parte dell'apparato psichico, che generalmente nelle ore di veglia sono repressi, diventano di nuovo attivi nelle psicosi e quindi rivelano la loro incapacità di soddisfare i nostri bisogni in relazione al mondo esterno. (Ho approfondito questi pensieri in uno scritto sui due princìpi del funzionamento psichico: il principio del piacere e il principio della realtà.) Gli impulsi di desiderio inconsci chiaramente cercano di ottenere effetto anche durante il giorno, e sia il fenomeno del transfert che quello delle psicosi mostrano che essi cercano di arrivare alla coscienza attraverso il preconscio e di ottenere il controllo del potere di movimento. Quindi la censura tra l'lnc. e il Prec, la cui esistenza ci è stata mostrata dai sogni, merita di essere riconosciuta e rispettata come la sentinella della nostra salute mentale. Non è forse un atto di trascuratezza da parte della sentinella il fatto che rallenti la sua attività durante la notte, che permetta agli impulsi repressi nel'Inc. di trovare espressione e che renda possibile la regressione allucinatoria? Credo di no. Infatti, anche se questa sentinella critica si riposa e abbiamo le prove che il suo sonno non è profondo, chiude la porta al potere di movimento. Qualunque sia l'impulso proveniente dall'Inc. generalmente inibito che piomba sul palcoscenico, non dobbiamo preoccuparci; esso rimane inerme poiché non è capace di mettere in movimento l'apparato motorio, mediante il quale solamente potrebbe modificare il mondo esterno. Lo stato di sonno garantisce la sicurezza della cittadella che deve essere difesa. La posizione diventa meno innocua quando ciò che produce lo spostamento di forze non è il rilassamento notturno della quantità di forza della censura critica, ma una diminuzione patologica di tale forza o un'intensificazione patologica delle eccitazioni inconscie, mentre il preconscio è ancora occupato e la porta alla motilità è aperta. Quando succede questo, la sentinella è sopraffatta, le eccitazioni inconscie invadono il Prec. e quindi ottengono il controllo sulle nostre parole e azioni; oppure producono forzatamente la regressione allucinatoria e dirigono il corso dell'apparato (che non era designato per tale uso) mediante l'attrazione esercitata dalle percezioni sulla distribuzione della nostra energia psichica. A questo stato di cose diamo il nome di «psicosi». Siamo ora sulla strada giusta per procedere alla costruzione dell'impalcatura psicologica che avevamo interrotto nel punto in cui abbiamo introdotto i due sistemi Inc. e Prec. Ma ci sono dei motivi per cui dobbiamo continuare ancora per un po' a considerare i desideri l'unica forza motrice psichica della formazione dei sogni. Abbiamo accettato l'idea che i sogni sono sempre realizzazioni di desiderio perché sono prodotti del sistema Inc., la cui attività non conosce altro scopo che quella della realizzazione dei desideri e che non domina altre forze che gli impulsi di desiderio. Se insistiamo ancora sul nostro diritto di basare delle speculazioni psicologiche così forzate sull'interpretazione dei sogni, dobbiamo per forza dimostrare che tali speculazioni ci hanno permesso di inserire i sogni in un complesso che possa comprendere anche altre strutture psichiche. Se esiste qualcosa come un sistema Inc. (o qualcosa di analogo per gli scopi della nostra discussione), i sogni non possono essere la sua sola manifestazione; ogni sogno può essere una realizzazione di desiderio ma, a parte i sogni, ci devono essere altre forme di anormale realizzazione di desideri. Ed è un fatto che la teoria che regola tutti i sintomi psiconevrotici culmini in un'unica asserzione: anche essi devono essere considerati realizzazioni di desideri inconsci. (O, più certamente, una parte de) sintomo corrispondente alla realizzazione inconscia del desiderio, l'altra parte alla struttura psichica che reagisce contro il desiderio.) La nostra spiegazione fa dei sogni solo il primo membro di una classe che ha un'enorme importanza per gli psichiatri e la cui comprensione importa la soluzione del lato puramente psicologico del problema della psichiatria. (Come ha detto Hughlings Jackson: «Scopri tutto sui sogni e avrai scoperto tutto sulla pazzia».) Gli altri membri di questa classe di realizzazioni di desiderio, ad esempio i sintomi isterici, possiedono tuttavia una caratteristica essenziale che non ho trovato nei sogni. Ho appreso dalle ricerche che ho così spesso menzionato in questo libro che, per formare un sintomo isterico, devono convergere entrambe le correnti della nostra mente. Un sintomo non è semplicemente l'espressione di un desiderio inconscio realizzato; ci deve essere anche un desiderio del preconscio che viene realizzato dallo stesso sintomo. Quindi il sintomo avrà almeno due determinanti provenienti dai sistemi coinvolti nel conflitto. Come nel caso dei sogni, non ci sono limiti per ulteriori determinanti, per la «iperdeterminazione» dei sintomi. La determinazione che non sorge dall' Inc. è sempre, per quanto mi risulta, un pensiero che reagisce contro il desiderio inconscio, ad esempio un'autopunizione. Quindi posso formulare l'affermazione generale che un sintomo isterico si sviluppa solo dove la realizzazione di due opposti desideri, provenienti da due sistemi psichici differenti, riesce a convergere in un 'unica espressione. (Cfr. a questo proposito le mie più recenti formulazioni sull'origine dei sintomi isterici nel mio saggio sulle fantasie isteriche e la loro relazione con la bisessualità). Gli esempi non servirebbero a niente in questo punto, poiché nulla se non un'esauriente spiegazione delle complicazioni implicate potrebbe convincere. Lascerò quindi isolata la mia affermazione e citerò un esempio solo per chiarire la cosa, e non per convincere. In una mia paziente il vomito isterico risultò essere da un lato la realizzazione di una fantasia inconscia che risaliva alla sua pubertà, di un desiderio cioè di poter essere continuamente incinta ed avere numerosi bambini, e di un altro desiderio, aggiunto più tardi, di poter avere anche più uomini possibile. Un potente impulso di difesa era emerso contro questo desiderio smodato. E poiché la paziente avrebbe potuto perdere la sua linea e la bellezza a causa del vomito e non sarebbe quindi stata più attraente per nessuno, il sintomo era accettabile anche per il pensiero di punizione; e poiché era permesso da entrambe le parti, potè diventare realtà. Questo stesso modo di trattare la realizzazione di desiderio fu adottato dalla regina dei Parti nei confronti del triumviro romano Crasso. Credendo che egli avesse intrapreso la spedizione per amore dell'oro, ordinò che si versasse oro fuso nella gola del suo cadavere: «Ora hai ciò che desideravi». Ma finora tutto quello che sappiamo sui sogni è che esprimono la realizzazione di un desiderio proveniente dall'inconscio; sembra che il sistema preconscio dominante si calmi dopo un certo numero di deformazioni. Né è possibile in genere trovare un pensiero opposto al desiderio del sogno, che come suo complemento si realizzi nel sogno. Solo qua e là nelle analisi di sogni troviamo indizi di creazioni di reazioni, come, per esempio, il mio affetto per il mio amico R. nel sogno di mio zio. Ma possiamo trovare altrove le parti mancanti del preconscio. Mentre il desiderio dell'Inc. riesce a trovare espressione nel sogno dopo aver subito deformazioni di ogni genere, il sistema dominante si ritira nel desiderio di dormire, realizza quel desiderio producendo le modificazioni che è in grado di produrre nell'occupazione all'interno dell'apparato psichico e persiste in quel desiderio per tutta la durata del sonno. (Ho preso in prestito quest'idea dalla teoria del sonno di Liébeault, al quale si deve la rinascita nei tempi moderni della ricerca sull'ipnotismo.) La determinazione del desiderio di dormire da parte del preconscio in genere facilita la formazione dei sogni. Ricordiamo il sogno dell'uomo che dal bagliore di luce proveniente dalla stanza accanto fu indotto a dedurre che il corpo del bambino poteva essere in fiamme. L'uomo fece questa deduzione in un sogno invece di lasciarsi svegliare dal bagliore; e noi abbiamo suggerito che una delle forze psichiche responsabili di questo effetto fosse il desiderio che prolungava di un momento la vita del figlio, che egli immaginava nel sogno. Altri desideri, provenienti dal represso, probabilmente ci sfuggono, poiché non siamo in grado di analizzare il sogno. Ma possiamo presumere che un'altra forza motrice della produzione del sogno fosse il bisogno di dormire del padre; il suo sonno, come la vita del bambino, fu prolungato di un momento dal sogno. Il suo motivo era: lasciamo continuare il sogno, altrimenti dovrò svegliarmi. In tutti gli altri sogni, come in questo, il desiderio di dormire sostiene il desiderio inconscio. Ho descritto precedentemente dei sogni che sembravano apertamente sogni di convenienza, ma in realtà tutti i sogni si possono considerare tali. L'azione del desiderio di continuare a dormire è molto evidente nei sogni di risveglio, che modificano gli stimoli sensori esterni in modo tale da renderli compatibili con la continuazione del sogno; li intessono in un sogno per privarli di qualsiasi possibilità di ricordare il mondo esterno. Lo stesso desiderio deve comunque intervenire anche nel concedere il manifestarsi di tutti gli altri sogni, anche se essi possono minacciare solo dall'interno di svegliare il dormiente. In certi casi, quando un sogno si spinge troppo in là, il Prec. dice alla coscienza: «Non ti preoccupare! Continua a dormire! Dopo tutto è solo un sogno!». Ma questo descrive in generale l'atteggiamento della nostra attività psichica dominante nei confronti dei sogni, anche se non si può esprimere apertamente. Quindi devo concludere che durante tutto lo stato di sonno sappiamo con altrettanta sicurezza che stiamo sognando quanto che stiamo dormendo. Non dobbiamo prestare troppa attenzione all'obiezione che la coscienza non arriva mai alla seconda parte di questa conoscenza e che conosce la prima solo in determinate occasioni, quando la censura sente che in un certo senso è stata privata della sua funzione. D'altra parte, ci sono persone che durante la notte sono completamente consapevoli di essere addormentate e di sognare e che quindi sembrano possedere la facoltà di dirigere consapevolmente i loro sogni. Se, per esempio, un sognatore di questo tipo non è soddisfatto della piega presa da un sogno, può interromperlo senza svegliarsi e ricominciarlo in un altro modo, come un popolare drammaturgo può, sotto pressione, dare un finale più felice alla sua commedia. O, altre volte, se il sogno lo ha portato in una situazione di eccitazione sessuale, egli si può dire: «Non continuerò ulteriormente questo sogno per esaurirmi con una polluzione; aspetterò per una situazione reale». Il marchese d'Hervey de Saint-Denys, citato da Vaschide, sosteneva di aver acquisito la facoltà di accelerare il corso dei suoi sogni come gli pareva e di dar loro la conclusione che voleva. Sembra che nel suo caso il desiderio di dormire avesse ceduto il posto ad un altro desiderio preconscio, quello di osservare i suoi sogni e di goderne. Il sonno è compatibile con un tale desiderio quanto lo è con una riserva mentale di svegliarsi se si verifica una certa condizione (per esempio, nel caso di una madre che allatta o di una balia). Inoltre è risaputo che chi si interessa ai sogni al risveglio ne ricorda molti di più. Ferenczi, nel corso di una discussione su altre osservazioni riguardanti il dirigere dei sogni, osserva: «I sogni elaborano i pensieri che occupano la mente in quel momento da ogni punto di vista; lasciano cadere un'immagine onirica se questa minaccia il successo della realizzazione di desiderio e provano con una nuova soluzione, finché alla fine riescono a formare una realizzazione di desiderio che soddisfi entrambe le istanze della vita psichica come un compromesso». (D) RISVEGLIO A CAUSA DEI SOGNI. LA FUNZIONE DEI SOGNI. SOGNI DI ANGOSCIAOra che sappiamo che durante tutta la notte il preconscio si concentra sul desiderio di dormire, siamo in grado di arrivare ad uno stadio più avanzato della nostra comprensione del processo del sognare. Ma ricapitoliamo, prima ciò che abbiamo appreso finora. La situazione è la seguente. O l'attività della veglia ha lasciato dei residui dal giorno precedente e non è stato possibile ritirare da essi tutta l'energia; o l'attività della veglia durante il corso della giornata ha ridestato un desiderio inconscio; o questi due fatti si sono verificati contemporaneamente. (Abbiamo già parlato delle varie possibilità al riguardo). Il desiderio inconscio si lega ai residui del giorno e effettua un transfert su di essi; questo può accadere durante la giornata o nello stato di sonno. Ora sorge un desiderio che viene trasferito sul materiale recente; o un desiderio recente, che è stato represso, rivive perché è rinforzato dall'inconscio. Questo desiderio cerca di forzare il passaggio lungo la via normale presa dai processi del pensiero, attraverso il Prec. (cui anzi appartiene in parte) verso la coscienza. Ma incontra la censura che è ancora al lavoro e si sottomette alla sua influenza. A questo punto ha luogo la deformazione già preparata dal transfert del desiderio sul materiale recente. Fin qui è sulla via di diventare un'ossessione o un'allucinazione o qualcosa del genere, cioè un pensiero intensificato dal transfert e deformato nella sua espressione dalla censura. Comunque il suo avanzamento è arrestato dallo stato di sonno del preconscio. (C'è la probabilità che quel sistema si sia protetto dall'invasione mediante la riduzione delle proprie eccitazioni). Il processo onirico di conseguenza entra nella via regressiva, che trova aperta proprio a causa della particolare natura dello stato di sonno, ed è condotto lungo quella via dall'attrazione esercitata su di esso da gruppi di ricordi; alcuni di questi ricordi esistono essi stessi sotto forma di occupazioni visuali e non come trasposizioni nella terminologia degli ultimi sistemi. Nel corso del suo cammino regressivo il processo onirico acquista l'attributo della rappresentabilità. (Svolgerò in seguito la questione della compressione). Esso ha ora completato la seconda parte del suo viaggio a zig zag. La prima parte è progressiva e porta dalle scene inconscie o dalle fantasie al preconscio; la seconda parte porta dal limite della censura di nuovo indietro alle percezioni. Ma quando il contenuto del processo onirico è diventato percettivo, riesce a trovare il modo di eludere l'ostacolo posto sul suo cammino dalla censura e dallo stato di sonno nel Prec. Riesce ad attirare l'attenzione su di sé e ad essere notato dalla coscienza. Infatti la coscienza, che noi consideriamo un organo sensorio per l'apprensione delle qualità psichiche, riesce nella vita della veglia a ricevere eccitazioni da due direzioni. In primo luogo, può ricevere eccitazioni dalla periferia di tutto l'apparato, il sistema percettivo; e inoltre può ricevere eccitazioni di piacere e di dispiacere, che sembrano essere quasi le uniche qualità psichiche collegate alle trasposizioni di energia nell'interno dell'apparato. Tutti gli altri processi nei sistemi φ, compreso il Prec, mancano di qualità psichiche e quindi non possono essere oggetto della coscienza, se non nella misura in cui portano piacere o dispiacere alla percezione. Dobbiamo quindi concludere che queste scariche di piacere e dispiacere regolano automaticamente il corso dei processi di carica energetica. Ma per fare degli adattamenti più delicati si è in seguito reso necessario fare in modo che il corso delle rappresentazioni fosse più indipendente dalla presenza o assenza di dispiacere. A questo scopo era necessario che il sistema Prec. avesse delle qualità proprie che potessero attirare la coscienza; e sembra molto probabile che le abbia acquistate collegando i processi preconsci con il sistema di ricordi dei simboli linguistici, sistema non privo di qualità. Mediante le qualità di quel sistema la coscienza, che fino allora era stata solo un organo sensorio delle percezioni, divenne anche organo sensorio per una parte dei nostri processi di pensiero. Ora quindi ci sono, per così dire, due superfici sensorie, una diretta verso la percezione e l'altra verso i processi di pensiero preconsci. Devo presumere che lo stato di sonno renda la superficie sensoria della coscienza che è diretta verso il Prec. molto meno suscettibile di eccitazione, in confronto alla superficie rivolta ai sistemi percettivi. Inoltre, questo abbandono di interesse per i processi di pensiero durante la notte ha uno scopo: il pensare deve arrestarsi, perché il Prec. vuole dormire. Ma nel momento in cui un sogno è diventato una percezione, è in grado di eccitare la coscienza, mediante le qualità che ha ora acquistato. Questa eccitazione sensoria esegue poi quella che è la sua funzione essenziale: richiama l'attenzione di una parte dell'energia di occupazione disponibile nel Prec. su ciò che sta causando l'eccitazione. Bisogna quindi ammettere che tutti i sogni hanno un effetto di risveglio, che mettono in azione una parte della forza in riposo del Prec. Il sogno viene quindi sottoposto da questa forza all'influenza che abbiamo chiamato «elaborazione secondaria», con riguardo alla consecutività e ali'intellegibilità. Quindi il sogno viene trattato come qualsiasi altro contenuto percettivo; nella misura in cui il suo argomento lo permette, esso viene sottoposto alle stesse anticipazioni. Finché questa terza parte del processo onirico ha qualche direzione, essa è di nuovo progressiva. Per evitare malintesi, sarà appropriata una parola sulle relazioni cronologiche di questi processi onirici. Goblot ha fatto un'ipotesi molto attraente, suggerita senza dubbio dall'enigma del sogno della ghigliottina di Maury. Egli cerca di dimostrare che il sogno dura solo per il breve periodo di transizione tra il sonno e il risveglio. Il processo del risveglio richiede un certo lasso di tempo e durante quel tempo si manifesta il sogno. Noi immaginiamo che l'ultima immagine onirica sia così potente da farci svegliare; mentre in realtà essa è così forte perché in quel momento stiamo per svegliarci. «Un sogno è l'inizio del risveglio». È stato già rilevato da Dugas che Goblot ha dovuto trascurare molti fatti per poter generalizzare la sua tesi. Ci sono dei sogni dai quali non ci risvegliamo, per esempio quelli in cui sogniamo di sognare. Date le nostre conoscenze sul lavoro onirico non possiamo accettare che esso duri solo il periodo del risveglio. Sembra piuttosto probabile che la prima parte del lavoro onirico cominci già durante il giorno, sotto il controllo del preconscio. La seconda parte, la trasformazione imposta dalla censura, l'attrazione esercitata da scene inconscie e il penetrare fino alla percezione, senza dubbio dura tutta la notte; e sotto questo aspetto potremmo avere forse ragione quando abbiamo la sensazione di aver sognato tutta la notte, anche se non sappiamo dire che cosa abbiamo sognato. Ma non mi sembra necessario ipotizzare che i processi onirici mantengano effettivamente, fino al momento in cui diventano coscienti, l'ordine cronologico che ho seguito per descriverli: che in primo luogo appare il desiderio del sogno traslato, che segue la deformazione da parte della censura, poi il cambio di direzione regressivo, e così via. Sono stato costretto ad adottare questo ordine per la mia descrizione, ma ciò che accade in realtà è certamente un'indagine simultanea sull'una e sull'altra strada, un'oscillazione dell'eccitazione ora in un senso ora nell'altro, finché si concentra nella direzione più adatta ed un particolare raggruppamento diventa permanente. In base a delle esperienze personali sono portato a supporre che il lavoro onirico richieda spesso più di un giorno e una notte per ottenere il suo risultato; e se questo è vero, non dovremmo più meravigliarci della straordinaria ingegnosità mostrata nella costruzione del sogno. Secondo me perfino l'esigenza che il sogno sia reso comprensibile come fatto percettivo si può realizzare prima che il sogno attiri a sé la coscienza. Da quel punto in poi, però, il ritmo viene accelerato, poiché il sogno subisce lo stesso trattamento di qualsiasi altra cosa che venga percepita. È come un fuoco d'artificio che richiede ore e ore di preparazione, ma si estingue in un momento. A questo punto il processo onirico può aver acquistato, attraverso il lavoro onirico, sufficiente intensità per attirare a sé la coscienza e svegliare il preconscio, senza tener conto della durata e della profondità del sonno; oppure la sua intensità è insufficiente e allora deve attendere il momento in cui, subito prima del risveglio, l'attenzione diventa più mobile e gli va incontro. Sembra che la maggioranza dei sogni operi con una intensità psichica relativamente bassa, poiché generalmente essi aspettano il momento del risveglio. Ma questo spiega il fatto che, se ci svegliamo all'improvviso da un sonno profondo, generalmente percepiamo qualcosa che abbiamo sognato. In questi casi, così come quando ci svegliamo spontaneamente, vediamo in primo luogo il contenuto percettivo che è stato elaborato dal lavoro onirico e subito dopo il contenuto percettivo che ci viene offerto dall'esterno. Tuttavia, un maggiore interesse teorico si ricollega ai sogni che riescono a svegliarci in pieno sonno. Possiamo chiederci perché un sogno, cioè un desiderio inconscio, abbia il potere di interferire nel sonno, cioè nella realizzazione del desiderio preconscio. La spiegazione si trova senza dubbio nei rapporti di energia che noi non conosciamo. Se possedessimo tale conoscenza, scopriremmo probabilmente che il conceder via libera al sogno, dedicandogli una determinata misura di attenzione più o meno distaccata, rappresenta un'economia di energia in confronto al mantenere l'inconscio sotto stretto controllo sia di notte che di giorno. L'esperienza dimostra che il sognare è compatibile con il dormire, anche se interrompe il sonno parecchie volte durante la notte. Ci si sveglia per un istante e poi ci si riaddormenta subito. È come scacciare una mosca durante il sonno: un caso di risveglio ad hoc. Se ci si riaddormenta, l'interruzione viene eliminata. Gli esempi noti del sonno della madre che allatta o della balia dimostrano che la realizzazione del desiderio di dormire è pienamente compatibile con un certo impiego di attenzione in una determinata direzione. A questo punto si solleva un'obiezione su una migliore conoscenza dei processi inconsci. Io stesso ho affermato che i desideri inconsci sono sempre attivi. Ma, nonostante questo, sembra che non siano abbastanza forti da rendersi percettibili durante il giorno. Ma se un desiderio inconscio, mentre prevale lo stato di sonno, si è mostrato abbastanza forte da formare un sogno e destare con esso il preconscio, perché questa forza dovrebbe venire meno una volta che si è conosciuto il sogno? Non dovrebbe il sogno continuare a presentarsi perpetuamente, proprio come la mosca continua a tornare dopo che è stata cacciata via? Quale diritto abbiamo di affermare che i sogni eliminano i disturbi del sonno? È del tutto vero che i desideri inconsci restano sempre attivi. Essi rappresentano le strade che possono sempre essere percorse, ogni volta che un gruppo di eccitazioni se ne serve. Anzi l'indistruttibilità è una caratteristica preminente dei processi inconsci. Nell'inconscio nulla può finire, nulla è passato o dimenticato. Ciò appare in modo particolarmente chiaro quando si studiano le nevrosi e, particolarmente l'isterismo. La via dei pensieri inconsci, che porta a scaricarsi attraverso un attacco isterico, può essere ripercorsa immediatamente quando si è accumulata una sufficiente quantità di eccitazione. Un'umiliazione subita trenta anni prima agisce come se fosse recente per tutti i trenta anni, appena trova l'accesso alle fonti emotive inconscie. Appena ne viene sfiorato il ricordo rivive e appare caricata di eccitazione, che trova la scarica motoria in un attacco. E' proprio a questo punto che la psicoterapia deve intervenire. Il suo compito è quello di far sì che i processi inconsci vengano affrontati definitivamente e dimenticati. Infatti l'impallidirsi dei ricordi e la debolezza emotiva delle impressioni che non sono più recenti, che noi siamo portati a considerare naturali e a spiegare come effetti primari del tempo sulle tracce psichiche di ricordi, sono in realtà modificazioni secondarie effettuate mediante un elaborato lavoro. E il preconscio che compie questo lavoro e la psicoterapia non può seguire altra via che quella di portare l'Inc. sotto il dominio del Prec. Ci sono dunque due possibili risultati per qualsiasi particolare processo di eccitazione inconscio: esso può essere abbandonato a se stesso, nel qual caso penetrerà probabilmente fino a un certo punto e scaricherà l'eccitazione nel movimento; oppure può finire sotto l'influenza del preconscio e la sua eccitazione invece di essere scaricata può essere legata dal preconscio. Questa seconda alternativa è quella che si verifica nel processo del sognare. La carica energetica che dal preconscio va incontro al sogno divenuto percettivo, essendo diretta dall'eccitazione della coscienza, lega l'eccitazione inconscia del sogno e la priva della capacità di disturbare il sonno. Se è vero che il sognatore si sveglia per un istante, tuttavia egli ha effettivamente scacciato la mosca che minacciava di disturbare il suo sonno; comincia a diventare chiaro che è effettivamente più conveniente ed economico permettere che il desiderio inconscio segua il suo corso, lasciare aperto il cammino verso la regressione, in modo che possa formare un sogno, e poi legare il sogno e servirsene con un modico impiego di lavoro preconscio, piuttosto che continuare a imbrigliare strettamente l'inconscio per tutta la durata del sonno. C'era davvero da aspettarsi che il sognare, anche se in origine era un processo senza alcuno scopo utile, si sarebbe procurato qualche funzione nel gioco delle forze psichiche. Ed ora siamo in grado di individuare questa funzione. Il sognare ha assunto il compito di riportare sotto il controllo del preconscio l'eccitazione dell'Inc. che è rimasta libera; facendo questo, scarica l'eccitazione inconscia, serve da valvola di sicurezza e nello stesso tempo preserva il sonno del preconscio con un modesto impiego di attività vigile. Così, come tutte le altre strutture psichiche alla cui serie appartiene, esso costituisce un compromesso; è al servizio di entrambi i sistemi perché realizza entrambi i desideri finché sono reciprocamente compatibili. Se torniamo alla «teoria dell'eliminazione » di Robert, che ho spiegato precedentemente, vedremo subito che dobbiamo essenzialmente accettare la sua esposizione delia funzione dei sogni, anche se contestiamo le sue premesse e la sua concezione del processo onirico in sé. (È questa l'unica funzione che si può attribuire ai sogni? Io non ne conosco altre. È vero che Maeder ha cercato di dimostrare che i sogni hanno altre funzioni «secondarie». Egli è partito dall'osservazione esatta che alcuni sogni tentano di risolvere conflitti, tentativi che vengono poi applicati nella realtà e quindi sembrano degli esercizi di prova per le azioni della veglia. Egli ha quindi fatto un parallelo tra i sogni e il gioco degli animali e dei bambini, che può essere considerato pratica dell'esercizio di istinti innati e preparazione per successive attività serie; poi ha formulato l'ipotesi di una funzione di gioco (fonction ludique) dei sogni. Poco prima di Maeder, anche Alfred Adler ha insistito sul possesso della funzione di «pensare anticipato» dei sogni. In un'analisi che ho pubblicato nel 1905, un sogno, che poteva solo essere considerato come l'espressione di un'intenzione, fu ripetuto ogni notte, finché fu realizzato. Basta però riflettere appena per convincersi che questa funzione «secondaria» dei sogni non ha diritto di essere considerata parte dell'argomento dell'interpretazione dei sogni. Il pensare anticipato, il formulare intenzioni, il delineare tentativi di soluzioni che saranno magari realizzati più tardi nella vita da svegli, tutte queste e molte altre cose simili sono prodotti dell'attività inconscia e preconscia della mente; possono restare nello stato di sonno come residui diurni e combinarsi con un desiderio inconscio per formare un sogno. Quindi la funzione del sogno di pensare anticipatamente è piuttosto una funzione del pensiero preconscio della veglia, i cui prodotti ci possono essere rivelati dall'analisi dei sogni o di altri fenomeni. È una vecchia abitudine quella di identificare i sogni con il loro contenuto manifesto; ma dobbiamo ora ugualmente guardarci dall'errore di confondere i sogni con i pensieri onirici latenti.) La limitazione «finché i due desideri sono reciprocamente compatibili» implica la possibilità che la funzione del sognatore possa fare fiasco. E concesso al processo onirico di cominciare come realizzazione di un desiderio inconscio; ma se questa tentata realizzazione di desiderio turba il preconscio così violentemente che esso è incapace di continuare a dormire, allora il sogno ha interrotto il compromesso e non è riuscito a compiere la seconda parte del suo compito. In tal caso il sogno viene immediatamente troncato e sostituito da uno stato di veglia completa. Anche qui non è davvero colpa del sogno, se deve apparire nel ruolo di disturbatore del sonno invece che nel suo ruolo abituale di custode del sonno; e non dobbiamo per questo fatto credere che non abbia uno scopo utile. Questo non è l'unico esempio che troviamo nell'organismo di un congegno generalmente utile che diventa inutile appena le condizioni che lo provocano vengono in qualche modo modificate; e il disturbo serve almeno al nuovo scopo di attirare l'attenzione sulla modificazione e a mettere in movimento i mezzi di regolamento dell'organismo. Penso naturalmente al caso dei sogni di angoscia e, affinché non si creda che io eviti questa prova contro la teoria della realizzazione dei desideri ogni volta che l'incontro, darò almeno qualche cenno sulla loro spiegazione. Non c'è più alcuna contraddizione alla nostra affermazione che un processo psichico che sviluppa angoscia possa nonostante ciò essere un adempimento di desiderio. Sappiamo che la spiegazione consiste nel fatto che il desiderio appartiene ad un sistema, l'lnc. ma è stato rifiutato e soppresso dall'altro sistema, il Prec.. (Un secondo fattore, molto più importante ed esteso, ma ugualmente trascurato dai profani, è il seguente. Senza dubbio una soddisfazione di desiderio deve procurare piacere; ma allora ci si deve chiedere a chi. Alla persona che ha il desiderio, naturalmente. Ma, come sappiamo, il rapporto del sognatore con i suoi desideri è piuttosto particolare. Egli li rifiuta e li censura, in breve non gli piacciono. Quindi la loro realizzazione non gli procurerà piacere, ma proprio il contrario; e l'esperienza mostra che questo contrario appare sotto forma di angoscia, un fatto che si deve ancora spiegare. Quindi il sognatore in rapporto ai suoi desideri onirici si può solo paragonare all'unione di due persone legate da alcuni importanti elementi comuni. Invece di approfondire in questo senso, voglio ricordarvi una nota fiaba, in cui si trova questa situazione. Una buona fata promise ad una povera coppia la realizzazione dei loro tre primi desideri. Essi ne furono felici e decisero di sceglierli accuratamente. Ma la donna, tentata dal profumo di salsicce fritte che veniva dalla casa accanto, ne desiderò un paio. Ed eccole in un lampo; il primo desiderio era esaudito. Il marito era furioso e nella sua ira desiderò che le salsicce pendessero dal naso della moglie. Successe anche questo; e le salsicce non si potevano smuovere dalla loro nuova posizione. Questa era la soddisfazione del secondo desiderio, ma il desiderio era del marito e la sua realizzazione era estremamente sgradevole per la moglie. Conoscete il resto della storia. Poiché dopotutto erano una persona sola - marito e moglie - il terzo desiderio doveva per forza essere che le salsicce venissero via dal naso della moglie. Questa fiaba potrebbe servire per molti altri riguardi, ma qui serve solo per illustrare la possibilità che, se due persone non sono d'accordo, la realizzazione del desiderio di una porti solo dispiacere all'altra.) Anche quando la salute psichica è perfetta, la sottomissione dell'Inc. al Prec. non è totale; la misura della soppressione indica il grado di normalità psichica. I termini nevrotici indicano che i due sistemi sono in conflitto l'uno con l'altro; essi sono il prodotto di un compromesso che pone fine al conflitto per il momento. Da un lato essi concedono all'Inc. una via di uscita per la scarica dell'eccitazione e gli forniscono una specie di ancora di salvezza, mentre dall'altro permettono al Prec. di controllare entro certi limiti l'lnc. E' istruttivo considerare, ad esempio, il valore di una fobia isterica o di una agorafobia. Supponiamo che un paziente nevrotico sia incapace di attraversare la strada da solo - condizione che giustamente consideriamo come un «sintomo». Se eliminiamo questo sintomo costringendolo a compiere l'atto di cui si ritiene incapace, la conseguenza sarà un attacco di angoscia; e anzi il manifestarsi di una crisi di angoscia per la strada è spesso la causa prima dell'agorafobia. Vediamo quindi che il sintomo è stato costruito per evitare un attacco di angoscia; la fobia viene elevata come fortificazione di frontiera contro l'angoscia. Non possiamo proseguire nella nostra trattazione senza aver esaminato il ruolo svolto in questi processi dagli affetti; ma in questo contesto possiamo farlo solo in modo incompleto. Supponiamo dunque che la repressione dell'Inc. sia necessaria soprattutto perché se il corso delle sue rappresentazioni venisse abbandonato a se stesso, esso produrrebbe un affetto in origine piacevole, che diventerebbe però spiacevole dopo il processo di rimozione. Lo scopo, quindi, e l'effetto della repressione sono quelli di impedire questa scarica di dispiacere. La repressione si estende al contenuto rappresentativo dell'Inc, poiché la scarica di dispiacere potrebbe avere origine da tale contenuto. Ciò presuppone un'ipotesi ben precisa per quanto riguarda la natura della produzione di un affetto. La si considera un'attività motoria o secretoria, la cui chiave di innervazione si trova nelle rappresentazioni dell'Inc. A causa del dominio stabilito dal Prec, queste rappresentazioni vengono in un certo senso soffocate e inibite in modo da non poter inviare gli impulsi che genererebbero l'affetto. Se dunque cessa l'occupazione da parte del Prec, c'è il pericolo che le eccitazioni inconscie scarichino uno stato affettivo che (per effetto della repressione già avvenuta) possa essere sentito solo come dispiacere o angoscia. Questo pericolo si materializza, se si permette al processo onirico di seguire il suo corso. Perché si determini la sua realizzazione è necessario che ci siano state le rimozioni e che gli impulsi di desiderio repressi siano in grado di diventare sufficientemente forti. Queste determinanti sono quindi completamente al di fuori della struttura psicologica della formazione del sogno. Se non fosse per il fatto che il nostro tema è connesso con l'argomento della produzione dell'angoscia mediante l'unico legame della liberazione dell'Inc. durante il sonno, sarei in grado di tralasciare qualsiasi trattazione dei sogni di angoscia e di eludere la necessità di affrontare in queste pagine tutte le oscurità ad essi inerenti. La teoria dei sogni di angoscia, come ho già ripetutamente asserito, rientra nella psicologia delle nevrosi. Non avremo più niente a che fare con essa, una volta che abbiamo indicato il suo punto di contatto con il tema del processo onirico. C'è solo un'altra cosa che posso fare. Poiché ho asserito che l'angoscia nevrotica proviene da fonti sessuali, posso sottoporre ad analisi alcuni sogni d'angoscia per indicare il materiale sessuale presente nei loro pensieri onirici. Ho le mie buone ragioni per tralasciare nella presente trattazione i numerosi esempi offertimi dai miei pazienti nevrotici e preferire le citazioni di alcuni sogni d'angoscia fatti da persone giovani. Sono passate decine d'anni da quando io ho avuto un vero sogno d'angoscia, ma ne ricordo uno fatto a sette o otto anni, che ho sottoposto all'interpretazione dopo circa trenta anni. Era molto chiaro: vidi la mia cara madre con un'espressione sul volto particolarmente tranquilla, addormentata, mentre veniva portata nella stanza da due (o tre) persone con becchi d'uccello e deposta sul letto. Mi svegliai piangendo e gridando e interruppi il sonno dei miei genitori. Le figure stranamente vestite, di altezza non naturale e con i becchi d'uccelli, erano prese dalle illustrazioni della Bibbia di Philippson. Immagino che siano stati degli dèi dalla testa di falco presi dal bassorilievo di un'antica tomba egiziana. Inoltre, l'analisi mi fece venire in mente un ragazzo maleducato, figlio di un portinaio, che giocava generalmente con noi sul prato davanti casa quando eravamo piccoli; e mi sembra si chiamasse Philipp. E mi pare di aver udito da questo ragazzo per la prima volta il termine volgare che definisce il rapporto sessuale, al posto del quale le persone colte usano sempre una parola latina, «coire», e che era abbastanza chiaramente delineata dalla scelta delle teste di falco. Devo aver indovinato il significato sessuale della parola dall'espressione del mio giovane istruttore, che era molto esperto sui fatti della vita. L'espressione sul volto di mia madre nel sogno era copiata dalla visione che avevo avuto di mio nonno pochi giorni prima della sua morte mentre giaceva in coma, rantolando. L'interpretazione compiuta nel sogno dalla «revisione secondaria» deve essere stata quindi la morte di mia madre; il bassorilievo di tomba si accordava ad essa. Mi svegliai angosciato, e l'angoscia non cessò finché non ebbi svegliato i miei genitori. Ricordo che mi calmai immediatamente quando vidi il viso di mia madre, come se avessi bisogno di rassicurarmi che non era morta. Ma questa interpretazione «secondaria» del sogno era stata già fatta sotto l'influenza dell'angoscia che si era sviluppata. Non ero angosciato perché avevo sognato che mia madre stava morendo; ma interpretai il sogno in quel senso sotto l'influenza dell'angoscia. Se si prende in considerazione la repressione, l'angoscia si può far risalire ad un desiderio oscuro ed evidentemente sessuale, che aveva trovato espressione adatta nel contenuto visivo del sogno. Un uomo di ventisette anni, che era stato gravemente ammalato per un anno, raccontò che tra i suoi undici e tredici anni aveva ripetutamente sognato (e insieme provato una forte angoscia) che un uomo con un'ascia lo rincorreva; egli cercava di correre ma gli sembrava di essere paralizzato e non riusciva a muoversi. Questo è un buon esempio di un tipo molto comune di sogni d'angoscia, di cui non si sospetterebbe mai la sessualità. Nell'analisi il sognatore parlò di una storia (avvenuta in un tempo successivo al sogno) raccontatagli da suo zio: era stato assalito di notte per strada da un individuo sospetto; il sognatore stesso aveva concluso da questa associazione che al tempo del sogno aveva forse sentito un episodio simile. A proposito dell'ascia egli ricordò che all'incirca in quel periodo si era ferito una mano con un'ascia mentre faceva a pezzi del legno. Quindi passò immediatamente ai suoi rapporti con il fratello minore. Egli aveva l'abitudine di maltrattare questo fratello e buttarlo a terra; e ricordava particolarmente un'occasione in cui gli aveva dato un calcio in testa con lo stivale e, mentre scorreva il sangue, sua madre aveva detto: «Temo che un giorno o l'altro l'ammazzerà». Mentre sembrava che fosse ancora concentrato sul tema della violenza, gli venne in mente improvvisamente un ricordo di quando aveva nove anni. I suoi genitori erano tornati a casa tardi ed erano andati a letto, mentre egli faceva finta di essere addormentato; presto aveva udito un affannare e altri rumori che gli sembravano strani ed era anche riuscito a capire la loro posizione nel letto. Altri pensieri mostravano che egli ne aveva tratto una analogia tra questo rapporto dei suoi genitori e il suo rapporto con il fratello minore. Aveva riassunto ciò che accadeva tra i suoi genitori nel concetto di violenza e lotta; e aveva trovato una verifica di questa sua opinione nel fatto che aveva spesso notato del sangue nel letto di sua madre. Posso dire che è di esperienza quotidiana il fatto che il rapporto sessuale tra adulti sembri spaventoso ai bambini che lo osservano e che provochi angoscia in essi. Ho spiegato questa angoscia deducendo che stiamo trattando di una eccitazione sessuale che la loro intelligenza non è in grado di affrontare, e che inoltre essi indubbiamente rifiutano poiché implica i loro genitori; e quindi si trasforma in angoscia. In un periodo di vita ancora precedente gli impulsi sessuali rivolti al genitore di sesso opposto non incontrano ancora la repressione e, come abbiamo visto, si esprimono liberamente. Non esiterei a dare la stessa spiegazione agli attacchi di terrore notturni uniti ad allucinazione (pavor nocturnus), che sono così frequenti nei bambini. Anche in questo caso può essere solo una questione di impulsi sessuali che non sono stati compresi e che sono stati rifiutati. L'indagine mostrerebbe probabilmente una periodicità nel presentarsi degli attacchi, poiché un aumento della libido sessuale può essere prodotto non solo da impressioni eccitanti accidentali, ma anche da successive ondate di processi spontanei di sviluppo. Mi manca materiale sufficiente basato sull'osservazione per poter confermare questa spiegazione. (In seguito, nella letteratura psicoanalitica è comparsa una grande quantità di questo materiale.) I pediatri, d'altra parte, sembrano ignorare l'unica linea di approccio che potrebbe rendere comprensibile tutta questa classe di fenomeni, sia dal punto di vista somatico che da quello psichico. Non posso resistere alla tentazione di citare un divertente esempio del modo in cui i paraocchi della mitologia medica possano impedire all'osservatore la comprensione di tali casi per uno stretto margine. Il mio esempio è tratto da una tesi sul pavor nocturnus di Debacker. Un ragazzo di tredici anni, di salute delicata, cominciò ad essere pauroso e trasognato. Il suo sonno veniva disturbato e interrotto almeno una volta alla settimana da gravi crisi di angoscia unite ad allucinazioni. Egli conservava sempre un ricordo molto chiaro di questi sogni. Diceva che un diavolo gli gridava: «Ora ti abbiamo preso, ora ti abbiamo presto!». Poi si sentiva odore di pece e di zolfo e la sua pelle bruciava. Si svegliava dal sonno terrorizzato e al principio non riusciva a gridare. Quando ritrovava la voce, diceva chiaramente: «No, no, non me; io non ho fatto nulla!», oppure «Per favore, no! Non lo farò più!» o ancora «Alberto non l'ha mai fatto!». In seguito, rifiutava di spogliarsi «perché le fiamme lo bruciavano solo quando era spogliato». Mentre faceva ancora questi sogni, che erano una minaccia alla sua salute, fu mandato in campagna. Là si ristabilì dopo un anno e mezzo e una volta, quando aveva quindici anni, confessò: «Non osavo dirlo, ma provavo continuamente una sensazione di solletico e di sovreccitazione alle parti; alla fine mi snervava talmente che pensavo di gettarmi dalla finestra del dormitorio». Non è davvero difficile dedurre che: 1. il ragazzo si era masturbato quando era più piccolo e probabilmente lo aveva negato ed era stato minacciato di severe punizioni per la sua cattiva abitudine (vedi la sua confessione: «Non lo farò più», il suo diniego «Alberto non l'ha mai fatto»); 2. con la pubertà si era ridestata la tentazione di masturbarsi con il prurito ai genitali; 3. c'era in lui una lotta a causa della rimozione che aveva soppresso la libido e l'aveva trasformata in angoscia; e l'angoscia si era impadronita delle punizioni di cui era stato minacciato precedentemente. Ed ora vediamo le deduzioni tratte dal nostro autore: «Da questa osservazione si possono trarre le seguenti conclusioni: 1. L'influenza della pubertà su un ragazzo di salute delicata può provocare uno stato di grande debolezza e può sfociare in un grado considerevole di anemia cerebrale. (Corsivo mio.) 2. Questa anemia cerebrale provoca cambiamenti di carattere, allucinazioni demonomaniache e stati d'angoscia notturni (e forse anche diurni) molto evidenti. 3. La demonomania del ragazzo e gli autorimproveri risalgono alle influenze della sua educazione religiosa, che aveva agito su di lui da piccolo. 4. Tutti i sintomi sono scomparsi dopo un prolungato soggiorno in campagna, grazie agli esercizi fisici e al recupero delle forze con la fine della pubertà. 5. Un'influenza predisponente sull'origine dello stato cerebrale del bambino si può forse attribuire all'ereditarietà e ad una passata sifilide del padre». Ed ecco la conclusione finale: «Abbiamo classificato questo caso tra i deliri apiretici di inanizione, poiché ricolleghiamo questo particolare stato all'ischemia cerebrale». (E) IL PROCESSO PRIMARIO E IL PROCESSO SECONDARIO. LA RIMOZIONENeil'avventurarmi nel tentativo di penetrare più profondamente nella psicologia dei processi onirici mi sono posto un compito difficile, che non corrisponde alle mie capacità di esposizione. Gli elementi di questo complicato insieme, che nella realtà sono simultanei, possono essere rappresentati in una descrizione successiva, mentre, nel presentare ogni punto, devo evitare di dare l'impressione di anticipare le basi sulle quali esso è fondato: non ho la forza di padroneggiare difficoltà di questo tipo. In tutto questo sto scontando il fio per non essere riuscito, nella mia esposizione della psicologia dei sogni, a seguire lo sviluppo storico delle mie opinioni. Anche se il mio approccio all'argomento dei sogni era determinato dal mio precedente studio della psicologia delle nevrosi, non intendo servirmi di quest'ultimo come punto di riferimento per l'attuale lavoro. Ciononostante sono continuamente portato a fare ciò, invece di avanzare, come avrei voluto, nella direzione contraria e di usare i sogni come un mezzo di avvicinamento alla psicologia della nevrosi. Mi rendo conto delle complicazioni che ne deriveranno per i lettori, ma non vedo il modo di evitarlo. Nella mia insoddisfazione per questo stato di cose, sono lieto di soffermarmi un attimo su un'altra considerazione che sembra valorizzare maggiormente i miei sforzi. Mi sono trovato ad affrontare un argomento sul quale, come ho indicato nel primo capitolo, le opinioni degli autori sono acutamente contraddittorie. La mia esposizione del problema dei sogni ha fatto posto alla maggior parte di queste concezioni contraddittorie. Mi è sembrato necessario negarne categoricamente solo due: l'idea che il sognare sia un processo privo di significato e quella che sia un processo somatico. A parte questo, sono riuscito a trovare una giustificazione per tutte queste idee reciprocamente contraddittorie in un punto o nell'altro della mia complicata tesi ed ho dimostrato che avevano raggiunto una parte della verità. L'opinione che i sogni continuino le occupazioni e gli interessi della vita da svegli è stata interamente confermata dalla scoperta dei pensieri del sogno celati. Questi ultimi riguardano solo ciò che ci sembra importante e che ci interessa notevolmente. I sogni non si occupano mai dei dettagli insignificanti. Ma abbiamo trovato le ragioni per accettare anche l'opinione opposta, che i sogni raccolgono i residui indifferenti del giorno precedente e che non possono ottenere il controllo di alcun interesse diurno importante, finché esso non è stato in una qualche misura sottratto all'attività della veglia. Abbiamo scoperto che ciò è valido per il contenuto del sogno, che dà espressione ai pensieri del sogno in una forma modificata dalla deformazione. Come abbiamo visto, per motivi connessi al meccanismo dell'associazione, il processo onirico si impadronisce più facilmente del materiale rappresentativo recente o indifferente, che non è stato ancora utilizzato dall'attività di pensiero della veglia; e per motivi di censura trasferisce l'intensità psichica da ciò che è importante ma confutabile a ciò che è indifferente. L'ipermnesia dei sogni e il loro accesso al materiale infantile sono diventati i pilastri del nostro insegnamento. La nostra teoria dei sogni considera i desideri che risalgono all'infanzia come la forza motrice indispensabile per la formazione dei sogni. Naturalmente non ci è venuto in mente di mettere in dubbio il valore, che è stato dimostrato sperimentalmente, degli stimoli sensori esterni durante il sonno; ma abbiamo mostrato che questo materiale si trova rispetto al desiderio del sogno nello stesso rapporto dei resti di pensiero avanzati dall'attività diurna. Né abbiamo trovato alcuna ragione per contestare l'opinione secondo la quale i sogni interpreterebbero gli stimoli sensori oggettivi come le illusioni; ma abbiamo trovato il motivo di questa interpretazione, motivo che non è stato specificato dagli altri autori. L'interpretazione viene condotta in modo tale che l'oggetto percepito non interrompa il sonno e possa essere impiegato per lo scopo della realizzazione di desiderio. Per quanto riguarda gli stati di eccitazione soggettiva degli organi sensori durante il sonno, la cui presenza sembra essere dimostrata da Trum-bull Ladd, è vero che non li abbiamo accettati come una fonte particolare di sogni; ma siamo riusciti a spiegarli come il risultato del ridestarsi regressivo dei ricordi che operano dietro al sogno. Le sensazioni organiche interne, che generalmente sono state prese come punto cardine delle spiegazioni dei sogni, hanno anche esse mantenuto un posto, anche se modesto, nella nostra teoria. Sensazioni quali, ad esempio, quella di cadere, o di fluttuare o di essere inibiti, forniscono del materiale che è accessibile in qualsiasi momento e del quale il lavoro onirico si serve ogni volta che ne ha bisogno, per esprimere i pensieri del sogno. La concezione per cui il processo onirico è rapido o istantaneo è secondo noi esatta per quanto riguarda la percezione da parte della coscienza del contenuto del sogno già costruito; sembra probabile che le precedenti parti del processo onirico abbiano un corso lento e incerto. Siamo riusciti a contribuire alla soluzione dell'enigma dei sogni che contengono una grande quantità di materiale compreso in un brevissimo istante; abbiamo suggerito che in tali casi si tratta di afferrare delle strutture già pronte e presenti nella mente. Noi accettiamo il fatto che i sogni siano deformati e mutilati dalla memoria, ma non lo consideriamo un ostacolo; infatti non è che l'ultima parte manifesta di un'attività deformante che ha agito proprio dal principio della formazione del sogno. Per quanto riguarda la disputa accesa e apparentemente inconciliabile concernente la possibilità che la mente dorma di notte o mantenga il possesso di tutte le sue facoltà come durante il giorno, abbiamo scoperto che entrambe le opinioni sono esatte, ma nessuna delle due è completamente esatta. Nei pensieri del sogno abbiamo trovato la dimostrazione di una funzione intellettuale notevolmente complessa, che agisce con quasi tutte le risorse dell'apparato psichico. Tuttavia non si può contestare che questi pensieri del sogno sono nati durante il giorno ed è inevitabile ammettere che esiste uno stato di sonno della mente. In tal modo anche la teoria del sonno parziale ha dimostrato il suo valore, nonostante noi abbiamo scoperto che ciò che caratterizza lo stato di sonno non è la disgregazione dei legami psichici, ma la concentrazione del sistema psichico che opera durante il giorno sul desiderio di dormire. L'elemento del ritiro dal mondo esterno mantiene il suo valore nel nostro schema; pur non essendo la sola determinante, esso contribuisce a rendere possibile il carattere regressivo della rappresentazione nei sogni. Non si può contestare la rinuncia a dirigere volontariamente il corso delle idee, ma ciò non priva la vita psichica di ogni scopo, poiché abbiamo visto che, quando le rappresentazioni volute e intenzionali vengono abbandonate, subentrano nel comando quelle involontarie. Non ci siamo limitati ad accettare il fatto che le connessioni associative nei sogni sono deboli, ma abbiamo dimostrato che questo fenomeno è ancora più esteso di quanto si potesse sospettare; abbiamo comunque rilevato che questi deboli nessi sono solo dei necessari sostituti di altri nessi validi e significativi. È vero che abbiamo definito assurdi dei sogni; ma gli esempi ci hanno insegnato che un sogno può essere ragionevole anche quando sembra assurdo. Non abbiamo alcuna opinione contrastante per quanto riguarda le funzioni che si devono attribuire ai sogni. La concezione secondo la quale i sogni sono una valvola di sicurezza della mente e, con le parole di Robert, tutte le cose dannose diventano innocue mediante la rappresentazione nel sogno, questa concezione non solo coincide esattamente con la nostra teoria della doppia realizzazione di desiderio compiuta dai sogni, ma è anche a noi più comprensibile di quanto lo fosse a Robert stesso per la sua formulazione. Il libero gioco delle funzioni della mente nei sogni è rappresentato nella nostra teoria dal fatto che l'attività preconscia permette che i sogni seguano il loro corso. L'affermazione «il ritorno della mente al punto di vista embrionale nei sogni» o l'espressione usata da Havelock Ellis per definire i sogni - «un mondo arcaico di vaste emozioni e di pensieri imperfetti» - ci sembrano felici anticipazioni della nostra convinzione che i primitivi modi di agire, che durante il giorno vengono repressi, siano impegnati nella formazione del sogno. Abbiamo potuto accettare pienamente ciò che ha scritto Sully: «I nostri sogni sono un mezzo per conservare queste personalità successive. Quando siamo addormentati, ritorniamo all'antico modo di vedere e sentire le cose, agli impulsi e alle attività che molto tempo fa ci dominavano». Per noi, come per Delage, ciò che è stato «represso» diventa «la forza motrice dei sogni». Abbiamo pienamente valutato l'importanza della parte attribuita da Scherner alla fantasia del sogno, ed anche le sue stesse interpretazioni, ma siamo stati costretti, in un certo senso, a collocarle in una posizione diversa nel problema. Il punto non è che i sogni creano la fantasia, ma piuttosto che l'attività inconscia della fantasia contribuisce notevolmente alla formazione dei pensieri del sogno. Restiamo debitori di Scherner per aver egli indicato l'origine dei pensieri del sogno, ma quasi tutto ciò che egli attribuisce al lavoro onirico si può attribuire in realtà all'attività dell'inconscio durante il giorno, che provoca i sogni quanto i sintomi nevrotici. Noi siamo stati costretti a differenziare il lavoro onirico e a delimitarlo più rigidamente. E infine non abbiamo affatto tralasciato il rapporto tra i sogni e i disturbi mentali, ma l'abbiamo stabilito più saldamente su nuove basi. Siamo così riusciti a far entrare nella nostra struttura le scoperte più diverse e contraddittorie degli autori precedenti, grazie alla novità della nostra teoria dei sogni, che le riunisce quasi in un'unità superiore. Ad alcune di quelle teorie abbiamo attribuito degli scopi differenti, ma solo alcune di esse sono state da noi completamente rifiutate. Tuttavia la nostra costruzione è ancora incompleta. A parte le perplessità che ci si sono presentate nel penetrare nelle oscurità della psicologia, sembra che ci dobbiamo preoccupare di una nuova contraddizione. Da un lato abbiamo supposto che i pensieri del sogno sorgessero da un'attività psichica del tutto normale; dall'altro abbiamo scoperto una quantità di processi di pensiero completamente anormali tra i pensieri del sogno che si spingono fin nel contenuto del sogno e che noi poi ripetiamo nel corso della nostra interpretazione del sogno. Tutto ciò che abbiamo chiamato «lavoro onirico» sembra così lontano da quelli che consideriamo processi di pensiero razionali, che i giudizi più severi espressi dagli autori precedenti sul basso livello di funzionamento psichico nei sogni appaiono ora pienamente giustificati. Forse potremo superare questa difficoltà solo proseguendo oltre nella nostra indagine. Comincerò con l'esaminare in modo più approfondito una delle situazioni che possono portare alla formazione di un sogno. Un sogno, come abbiamo visto, sostituisce un certo numero di pensieri presi dalla nostra vita diurna, che formano una sequenza perfettamente logica. Non possiamo quindi dubitare che questi pensieri abbiano origine nella nostra vita psichica normale. Tutti gli attributi che valutiamo altamente nei nostri pensieri, e che li caratterizzano come creazioni complesse di alto grado, si ritrovano anche nei pensieri del sogno. Non è necessario tuttavia ipotizzare che questa attività di pensiero venga eseguita durante il sonno, possibilità che procurerebbe grande confusione a quello che è stato finora il nostro quadro definito dello stato psichico durante il sonno. Anzi, questi pensieri potrebbero benissimo provenire dal giorno precedente, o essere avanzati inosservati dalla coscienza ed essere già completi all'inizio del sonno. La cosa più importante che possiamo dedurre da ciò è la dimostrazione che le elaborazioni di pensiero più complicate sono possibili senza la partecipazione della coscienza; fatto questo che non potevamo fare a meno di apprendere in ogni caso dalle psicoanalisi di pazienti sofferenti di isterismo o di idee ossessive. Questi pensieri del sogno non sono in sé esclusi dalla coscienza; ci possono essere state molte ragioni per cui non ne siamo stati coscienti durante il giorno. Il divenire cosciente è connesso all'applicazione di una particolare funzione psichica, quella dell'attenzione, funzione che sembra disponibile solo in quantità determinante e che può essere stata distolta dal gruppo di pensieri in questione e diretta ad altri scopi. C'è anche un altro modo per tenere lontano dalla coscienza la serie di pensieri di questo tipo. Dal corso delle nostre riflessioni coscienti si vede che seguiamo una via determinata nella nostra applicazione dell'attenzione. Se nel seguire questa via incontriamo una rappresentazione che non sopporta la critica, ci fermiamo: lasciamo cadere l'attenzione che vi abbiamo investito. Ora, sembra che i pensieri che sono così incominciati e sono poi stati abbandonati possano continuare a svilupparsi senza che l'attenzione si rivolga loro di nuovo, a meno che non raggiungano in qualche punto un grado particolarmente alto di intensità, tale da attirare forzatamente l'attenzione. Così se una serie di pensieri è inizialmente rifiutata (forse coscientemente) da un giudizio che la considera errata o inutile per gli immediati scopi intellettuali essa può continuare ad avanzare, non osservata dalla coscienza, fino all'inizio del sonno. Per concludere, diciamo che un simile processo di pensiero è «preconscio»; lo consideriamo completamente razionale e crediamo che sia stato semplicemente trascurato, oppure interrotto e represso. Voglio aggiungere un'esposizione franca del modo in cui immaginiamo che si manifestino le serie di rappresentazioni. Riteniamo che a partire da una rappresentazione intenzionale, una certa quantità di eccitazione, che chiamiamo «energia di carica», venga collocata lungo le vie associative scelte da quella rappresentazione. Un processo di pensieri «trascurato» non ha ricevuto quella catessi; un processo di pensiero «represso» o «rifiutato» è un processo dal quale è stata ritirata la catessi. In entrambi i casi essi vengono abbandonati alle loro proprie eccitazioni. In determinate condizioni un processo di pensiero con catessi di scopo può attrarre l'attenzione della coscienza a sé e in tale occasione, attraverso l'azione della coscienza, ricevere una «iper-catessi». Saremo quindi costretti a spiegare più avanti la nostra opinione sulla natura e sulla funzione della coscienza. Un processo di pensiero che è stato così messo in moto nel preconscio può cessare spontaneamente oppure persistere. Immaginiamo che il primo di questi risultati implichi la diffusione dell'energia collegata al processo di pensiero lungo tutte le vie associative che da esso diramano; questa energia pone tutta la rete di pensiero in uno stato di eccitazione che dura per un certo tempo e poi si estingue, poiché l'eccitazione in cerca di scarica si trasforma in una catessi tranquilla. Se si verifica questo primo effetto, il processo non ha più alcun valore per quanto riguarda la formazione del sogno. Ci sono tuttavia altre rappresentazioni di scopo nascoste nel nostro preconscio, che provengono da fonti inconscie e da desideri sempre attivi. Questi possono assumere il controllo dell'eccitazione collegata al gruppo di pensieri abbandonato a se stesso, possono stabilire una connessione tra di esso e un desiderio inconscio e possono «traslare» su di esso l'energia appartenente al desiderio inconscio. Da quel momento il gruppo di pensieri trascurato o represso è nelle condizioni di continuare ad esistere, anche se il rinforzo che ha ricevuto non gli dà alcun diritto di entrare nella coscienza. Ciò si può esprimere dicendo che quello che finora era un processo di pensiero preconscio è stato ora attirato nell'inconscio. Ci sono altre situazioni che possono portare alla formazione di un sogno. Il processo di pensiero preconscio può essere stato collegato al desiderio inconscio fin dal principio e per tale ragione può essere stato rifiutato dalla catessi intenzionale dominante; oppure un desiderio inconscio può diventare attivo per altri motivi (per cause somatiche, ad esempio) e può cercare di effettuare un transfert sui resti psichici che non sono ancora occupati dal preconscio, senza che essi gli vengano incontro. Ma tutti questi tre casi hanno lo stesso risultato finale: nasce nel preconscio un processo di pensiero che non ha una catessi preconscia, ma ha ricevuto una catessi da un desiderio inconscio. Da questo momento in poi il processo di pensiero subisce una serie di trasformazioni che non possiamo più considerare come processi psichici normali e che portano ad un risultato che ci stupisce: una struttura psicopatologica. 1. Le intensità delle rappresentazioni individuali diventano capaci di scaricarsi in blocco e passano da una rappresentazione all'altra, in modo che determinate rappresentazioni acquistano una grande intensità. E poiché questo processo si ripete parecchie volte, l'intensità di tutta una serie di pensieri può a un certo punto concentrarsi su di un unico elemento rappresentativo. E qui abbiamo il fenomeno della «compressione» o «condensazione», che ci è diventato familiare nel lavoro onirico. Esso è il principale responsabile dell'impressione di stupore prodotta su di noi dai sogni, poiché nulla di analogo ci è noto nella vita psichica normale e accessibile alla coscienza. Anche nella vita psichica normale troviamo rappresentazioni che, essendo i punti nodali o i risultati finali di intere catene di pensieri, possiedono un alto grado di valore psichico; ma il loro valore non viene espresso in alcun tratto che sia evidente in maniera sensibile alla percezione interna; la loro presentazione percettiva non è affatto sotto alcun aspetto più intensa a causa del loro valore psichico. Nel processo di condensazione, d'altro canto, qualsiasi interconnessione psichica si trasforma in una intensificazione del suo contenuto rappresentativo. E' la stessa situazione di quando, preparando un libro per la stampa, scrivo in grassetto una parola che è di particolare importanza per la comprensione del testo; in un discorso pronuncerei le stesse parole ad alta voce e lentamente, con particolare enfasi. La prima di queste due analogie ci fa venire subito in mente un esempio presentatoci proprio dal lavoro onirico: la parola «trimetilammina» nel sogno dell'iniezione a Irma. Gli studiosi di storia dell'arte hanno attirato la nostra attenzione sul fatto che le sculture primitive obbediscono ad un principio analogo: esprimono il rango dei personaggi raffigurati mediante la grandezza della figura. Un re viene rappresentato due o tre volte più grande dei suoi aiutanti o dei nemici sconfitti. Una scultura romana si servirà di mezzi più sottili per produrre lo stesso risultato. La figura dell'imperatore sarà collocata al centro, eretta, e sarà modellata con cura particolare, mentre i suoi nemici saranno prostrati ai suoi piedi; tuttavia egli non sarà più un gigante tra nani. Gli inchini con i quali oggi gli inferiori salutano i loro superiori rappresentano un'eco degli stessi tipici antichi principi di rappresentazione. La direzione in cui procede la condensazione nel sogno è determinata da un lato dalle relazioni razionali preconscie dei pensieri del sogno e dall'altro dall'attrazione esercitata dai ricordi visuali dell'inconscio. Il risultato dell'attività di condensazione è il conseguimento delle intensità necessarie per penetrare nei sistemi percettivi. 2. Ancora una volta, grazie alla libertà con la quale si possono trasferire le intensità, si formano delle «rappresentazioni intermedie», simili a compromessi, sotto il dominio della condensazione. (Vedi i numerosi esempi fatti precedentemente). Questa è ancora una cosa sconosciuta al normale concatenamento dei concetti, dove si pone enfasi sulla selezione e sulla conservazione del «giusto» elemento rappresentativo. Invece si verificano con notevole frequenza le strutture composte e i compromessi, quando cerchiamo di esprimere i pensieri preconsci a parole. Allora vengono considerati una specie di «lapsus linguae». 3. Le rappresentazioni che trasferiscono l'una all'altra le loro intensità sono legate da relazioni reciproche molto deboli. Sono unite da associazioni di un tipo disprezzato dal nostro normale modo di pensare e relegato all'uso dei giochi di parole. In particolare vediamo che associazioni basate su omonimie e somiglianze verbali vengono considerate di valore equivalente alle altre. 4. Pensieri reciprocamente contraddittori non cercano di eliminarsi a vicenda, ma continuano ad esistere l'uno accanto all'altro. Spesso si riuniscono per formare delle condensazioni, proprio come se non fossero in contraddizione, oppure arrivano a compromessi che i nostri pensieri coscienti non potrebbero mai tollerare, ma che spesso accettiamo nelle nostre azioni. Questi sono alcuni dei più sorprendenti processi anormali ai quali i pensieri del sogno, in un primo momento formati su basi razionali, vengono sottoposti nel corso del lavoro onirico. Si vedrà che la principale caratteristica di questi processi è che tutta l'enfasi è rivolta a rendere mobile l'energia di occupazione e capace di scarica; il contenuto e il significato vero degli elementi psichici ai quali sono collegate le catessi sono considerati elementi secondari. Si potrebbe pensare che la condensazione e la formazione di compromessi vengano eseguite solo per facilitare la regressione, quando cioè si tratta di trasformare pensieri in immagini. Ma l'analisi, e ancora di più la sintesi, dei sogni che non contengono questa regressione alle immagini, per esempio il sogno dell'«Autodidasker», hanno mostrato la presenza degli stessi processi di spostamento e condensazione. Siamo quindi portati a concludere che ci troviamo di fronte a due diversi tipi di processi psichici nella formazione dei sogni. Uno di questi produce dei pensieri del sogno perfettamente razionali, di validità non minore del pensiero normale, mentre l'altro tratta questi pensieri in maniera notevolmente strana e irrazionale. Nel capitolo vi abbiamo già separato questo secondo processo psichico dal resto, considerandolo il lavoro onirico vero e proprio. Come dobbiamo ora spiegare la sua origine? Non ci sarebbe possibile rispondere a questo interrogativo se non avessimo già fatto qualche progresso nello studio della psicologia delle nevrosi e particolarmente dell'isteria. Abbiamo scoperto che gli stessi processi psichici irrazionali, e gli altri che non abbiamo specificato, dominano la produzione dei sintomi isterici. Anche nell'isteria si trova una serie di pensieri perfettamente razionali, di valore pari ai nostri pensieri coscienti; ma prima di tutto non sappiamo nulla della loro esistenza sotto questa forma e possiamo solo ricostruirli in seguito. Se si fanno notare in un punto qualsiasi, analizzando il sintomo prodotto scopriamo che questi pensieri normali sono stati sottoposti ad un trattamento anormale: sono stati trasformati in un sintomo mediante la condensazione e la formazione di compromessi, attraverso associazioni superficiali e ignorando le contraddizioni, ed anche probabilmente lungo il cammino regressivo. In considerazione della completa identità tra i tratti caratteristici del lavoro onirico e quelli dell'attività psichica che si manifesta nei sintomi psiconevrotici, ci sentiamo giustificati ad estendere ai sogni le conclusioni cui siamo stati condotti dall'isterismo. Prendiamo quindi la seguente tesi dalla teoria dell'isteria: un pensiero normale viene sottoposto a trattamento psichico anormale, del tipo che abbiamo descrìtto, se è stato trasferito su di esso un desiderio inconscio, che risale all'infanzia ed è in uno stato di rimozione. Secondo questa tesi abbiamo costruito la nostra teoria dei sogni, supponendo che il desiderio del sogno che fornisce la forza motrice derivi sempre dall'inconscio: ipotesi questa la cui validità generale non può essere provata, ma neppure confutata. Ma per spiegare che cosa si intende con il termine «rimozione», termine con il quale abbiamo giocato parecchie volte, è necessario fare un passo avanti nella nostra impalcatura psicologica. Abbiamo già studiato la finzione di un apparato psichico primitivo le cui attività siano regolate dal tentativo di evitare un'accumulazione di eccitazioni e di mantenersi per quanto possibile privo di eccitazioni. Per questa ragione è costruito sullo schema di un apparato riflesso. La capacità di movimento, che in un primo momento è un mezzo per produrre modificazioni interne nel corpo, è a sua disposizione come via di scarica. Abbiamo proseguito parlando delle conseguenze psichiche di una «esperienza di soddisfazione»; e a tale proposito siamo stati in grado di aggiungere già una seconda ipotesi, per cui l'accumulazione di eccitazione (prodotta in diversi modi, che non ci interessano) è sentita come dispiacere e mette in movimento l'apparato per ripetere l'esperienza della soddisfazione, che implica una diminuzione di eccitazione e viene sentita come piacere. Abbiamo chiamato «desiderio» una corrente di questo tipo nell'apparato, che parte dal dispiacere e tende al piacere; e abbiamo sostenuto che solo un desiderio è capace di mettere in moto l'apparato e che il corso dell'eccitazione è automaticamente regolato dalle sensazioni di piacere e dispiacere. Il primo desiderio sembra sia stato un'occupazione allucinatoria del ricordo di soddisfazione. Tali allucinazioni però, a meno che non si volessero mantenere fino all'esaurimento, si rivelarono insufficienti a produrre la cessazione del bisogno, o il piacere collegato alla soddisfazione. Divenne necessaria una seconda attività, o, come abbiamo detto, l'attività di un secondo sistema, che avrebbe impedito alla catessi del ricordo di procedere fino alla percezione e da lì legare le forze psichiche; doveva far deviare l'eccitazione proveniente dal bisogno lungo una via indiretta, che in ultima istanza, mediante il movimento volontario, avrebbe alterato il mondo esterno in modo da rendere possibile il raggiungimento di una percezione reale dell'oggetto di soddisfazione. Abbiamo già tracciato la nostra immagine schematica dell'apparato psichico fino a questo punto: i due sistemi sono il germe di ciò che, nell'apparato pienamente sviluppato, abbiamo chiamato l'lnc. e il Prec. Per poter impiegare la capacità di movimento in modo da alterare in modo efficace il mondo esterno, è necessario accumulare un gran numero di esperienze nei sistemi di ricordo e molteplici registrazioni permanenti delle associazioni suscitate nel materiale della memoria dalle diverse rappresentazioni intenzionali. Possiamo ora procedere con le nostre ipotesi. L'attività di questo secondo sistema, che tasta costantemente il suo cammino, che alternativamente invia e ritira catessi, necessita da un lato del libero dominio su tutto il materiale della memoria; ma dall'altro lato sarebbe uno spreco di energia se mandasse grandi quantità di occupazioni, lungo le diverse vie del pensiero, facendole scorrere via senza alcuno scopo utile e diminuendo la quantità a disposizione per modificare il mondo esterno. Suppongo quindi che per motivi di efficienza il secondo sistema riesca a trattenere la maggior parte della sua occupazione di energia in uno stato di tranquillità e a impiegarne solo una piccola parte per lo spostamento. Il meccanismo di questi processi mi è completamente sconosciuto; chiunque volesse prendere seriamente queste idee, dovrebbe cercarne delle analogie fisiche e tentare di immaginare i movimenti che accompagnano l'eccitazione dei neutroni. Quello su cui insisto è l'idea che l'attività del primo sistema Ψ sia rivolta ad assicurare il libero deflusso delle quantità di eccitazione, mentre il secondo sistema, mediante le occupazioni che da esso emanano, riesce ad impedire questa scarica e a trasformare l'occupazione rendendola tranquilla, con un simultaneo aumento del suo potenziale. Suppongo quindi che sotto il dominio del secondo sistema la scarica dell'eccitazione sia regolata da condizioni meccaniche completamente diverse da quelle che agiscono sotto il dominio del primo sistema. Una volta che il secondo sistema ha concluso la sua attività di pensiero esplorativa, rilascia le inibizioni e lo sbarramento delle eccitazioni e concede loro di scaricarsi nel movimento. Sarà interessante considerare i rapporti tra questa inibizione sulla scarica esercitata dal secondo sistema e la regolarizzazione effettuata dal principio del dispiacere. Esaminiamo l'antitesi dell'esperienza primaria di soddisfazione, cioè l'esperienza di una paura esterna. Supponiamo che uno stimolo percettivo, che è fonte di eccitazione dolorosa, agisca sul primitivo apparato. Seguiranno delle manifestazioni motorie non coordinate, finché una di esse ritirerà l'apparato dalla percezione e nello stesso tempo dal dolore. Se riappare la percezione, verrà subito ripetuto il movimento (un movimento di fuga, ad esempio) finché la percezione sia di nuovo scomparsa. In questo caso non resterà la tendenza a rioccupare la percezione della fonte di dolore sia in modo allucinatorie che in altro modo. Anzi, ci sarà nell'apparato primario la tendenza a lasciare cadere immediatamente l'immagine del ricordo penoso, se succede qualcosa che la ridesti, proprio perché se la sua eccitazione arrivasse alla percezione, provocherebbe dispiacere (o più precisamente, comincerebbe a provocarlo). L'elu-sione del ricordo, che non è altro che una ripetizione della fuga iniziale della percezione, è facilitata anche dal fatto che la memoria, a differenza della percezione, non possiede qualità sufficienti ad eccitare la coscienza e quindi attrarre a sé una nuova occupazione. Questa facile e regolare elusione da parte del processo psichico del ricordo di qualsiasi cosa che una volta sia stata penosa costituisce il prototipo e il primo esempio della repressione psichica. È noto che l'elusione di ciò che è penoso, la politica dello struzzo, resta ancora nella normale vita mentale degli adulti. Per effetto del principio del dispiacere, dunque, il primo sistema è totalmente incapace di produrre qualcosa di sgradevole nel contesto del suo pensiero. Non è capace di fare altro all'infuori di desiderare. Se le cose restassero a questo punto, l'attività di pensiero del secondo sistema sarebbe ostacolata, dal momento che essa richiede il libero accesso a tutti i ricordi accumulati dall'esperienza. Ora si presentano due possibilità. L'attività del secondo sistema potrebbe liberarsi completamente dal principio del dispiacere e continuare ad avanzare senza preoccuparsi del dispiacere dei ricordi; oppure potrebbe trovare il metodo di occupare i ricordi spiacevoli in modo da evitare la scarica spiacevole. Dobbiamo tralasciare la prima possibilità, perché il principio del dispiacere regola evidentemente il corso dell'eccitazione nel primo come nel secondo sistema. Ci resta dunque l'altra possibilità, che il secondo sistema occupi i ricordi in modo tale che ci sia una inibizione alla loro scarica, intendendo dunque anche una inibizione di scarica (paragonabile a quella di una innervazione motoria) nella direzione dello sviluppo del dispiacere. Da due direzioni siamo dunque arrivati all'ipotesi che l'occupazione da parte del secondo sistema implichi una simultanea inibizione della scarica di eccitazioni: ci siamo arrivati considerando il principio del dispiacere ed anche il principio del minimo impiego di innervazione. Fissiamolo bene in mente, poiché è la chiave a tutta la teoria della rimozione: il secondo sistema può investire una rappresentazione solo se è in una posizione tale da impedire qualsiasi sviluppo di dispiacere che possa da essa provenire. Qualunque cosa che potrebbe sfuggire a questa inibizione sarebbe inaccessibile sia al primo che al secondo sistema; poiché sarebbe subito abbandonata in obbedienza al principio del dispiacere. Non è tuttavia necessario che l'inibizione del dispiacere sia totale: se ne deve concedere l'inizio, poiché è quello che informa il secondo sistema sulla natura del ricordo in questione e sulla sua possibile inopportunità per lo scopo cui mira il processo di pensiero. Propongo di chiamare «processo primario» il processo psichico ammesso solo dal primo sistema e «processo secondario» il processo che deriva dall'inibizione imposta dal secondo sistema. Posso mostrare che c'è ancora un'altra ragione per cui il secondo sistema è costretto a correggere il processo primario. Il processo primario tenta di produrre una scarica di eccitazione per potere, con l'aiuto della quantità di eccitazione così accumulata, stabilire una «identità percettiva». Ma il processo secondario ha abbandonato questa intenzione e l'ha sostituita con un'altra, lo stabilire una «identità di pensiero». Il pensiero non è altro che una via indiretta dal ricordo di una soddisfazione (un ricordo che è stato adottato come rappresentazione intenzionale) ad una occupazione identica dello stesso ricordo, che spera di ottenere ancora una volta attraverso uno stadio intermedio di esperienze motorie. Il pensiero si deve preoccupare delle vie di collegamento tra le rappresentazioni, senza lasciarsi sviare dalle intensità di quelle rappresentazioni. Ma è evidente che il raggiungimento dell'identità voluta debba essere ostacolato dalle condensazioni di rappresentazioni, dalle strutture intermedie e di compromesso. Poiché sostituiscono una rappresentazione all'altra, provocano una deviazione dalla via che si sarebbe dovuta seguire partendo dalla prima rappresentazione. I processi di questo tipo sono dunque scrupolosamente evitati dal pensiero secondario. Ed è anche facile vedere che il principio del dispiacere che in altri casi procura i sostegni più importanti al processo del pensiero renda difficile il suo cammino verso la «identità di pensiero». Di conseguenza, il pensiero deve cercare di liberarsi sempre di più dalla regolarizzazione esclusiva del principio del dispiacere e di restringere lo sviluppo di affetti nell'attività di pensiero al minimo richiesto che serva da segnale. Il conseguimento di questo funzionamento più raffinato si ricerca mediante una iper-occupazione, prodotta dalla coscienza. Ma, come ben sappiamo, raramente si ottiene lo scopo in modo completo, anche nella normale vita psichica, e il nostro pensiero resta sempre esposto alla falsificazione per l'ingerenza del principio di dispiacere. Ma non è questa la lacuna dell'efficienza funzionale del nostro apparato mentale che fa sì che i pensieri, che si rappresentano come prodotti dell'attività di pensiero secondaria, vengano assoggettati al processo psichico primario: questa è infatti la formula con la quale possiamo ora descrivere l'attività che porta ai sogni e ai sintomi isterici. L'inefficienza deriva dalla convergenza di due fattori della storia del nostro sviluppo. Uno di questi fattori è rivolto interamente all'apparato psichico ed ha avuto una influenza decisiva sul rapporto tra i due sistemi, mentre l'altro si fa sentire a gradi diversi e introduce forze istintive di origine organica nella vita psichica. Entrambi nascono durante l'infanzia e sono un deposito delle modificazioni subite dal nostro organismo psichico e somatico dal tempo dell'infanzia in poi. Quando ho chiamato «primario» uno dei processi psichici che si verificano nell'apparato mentale, non avevo in mente solo delle considerazioni di importanza ed efficienza relative: intendevo anche scegliere un nome che avrebbe contenuto una indicazione della sua priorità cronologica. È vero che, per quanto ne sappiamo, non esiste un apparato psichico che abbia solo un processo primario e che tale apparato sotto questo aspetto è una finzione teorica. Ma un fatto è certo: i processi primari si trovano nell'apparato psichico dal principio, mentre solo durante il corso della vita si sviluppano i processi secondari e vengono ad ostacolare e a sovrapporsi ai primari; può anche essere che il loro dominio non si ottenga prima della maturità. In conseguenza della tardiva apparizione dei processi secondari, il nucleo del nostro essere, fatto di impulsi di desiderio inconsci, resta inaccessibile alla comprensione e inibizione del preconscio; il ruolo svolto da quest'ultimo viene limitato definitivamente a guidare lungo le vie più convenienti gli impulsi di desiderio che sorgono dall'inconscio. Questi desideri inconsci esercitano una forza compulsiva su tutte le successive correnti psichiche, una forza che quelle correnti saranno costrette ad accettare, o chi potranno forse cercare di distogliere e dirigere a scopi più elevati. Un'altra conseguenza della ritardata apparizione dei processi secondari è che gran parte del materiale della memoria sia inaccessibile all'occupazione preconscia. Tra questi impulsi di desiderio derivati dall'infanzia, che non possono essere distrutti né inibiti, ce ne sono alcuni la cui realizzazione sarebbe in contraddizione con le rappresentazioni intenzionali nel pensiero secondario. La realizzazione di questi desideri non produrrebbe più un sentimento di piacere, ma di dispiacere; ed è proprio questa trasformazione di affetti che costituisce l'essenza di ciò che chiamiamo rimozione. Il problema della rimozione consiste nel chiedersi come e per quali forze motrici avvenga questa trasformazione; ma è un problema che qui basta solo sfiorare. E sufficiente per noi chiarire che una trasformazione di questo tipo avviene nel corso dello sviluppo (basta ricordare il modo in cui compare il disgusto nell'infanzia, pur essendo mancato al principio) e che si riferisce all'attività del sistema secondario. I ricordi sulla base dei quali il desiderio inconscio produce la scarica affettiva non sono mai stati accessibili al Prec; di conseguenza la scarica affettiva collegata a quei ricordi non può essere ostacolata. È proprio per il motivo della produzione di affetto che queste rappresentazioni sono ora inaccessibili anche attraverso i pensieri preconsci sui quali hanno trasferito la forza del loro desiderio. Anzi, il principio del dispiacere prende il controllo e fa in modo da distogliere il Prec. dal pensiero del transfert. Essi vengono abbandonati a se stessi, «rimossi», e da qui viene la presenza di un mucchio di ricordi infantili che fin dal principio sono sottratti al Prec. e diventano condizione indispensabile della repressione. Nel migliore dei casi la produzione di dispiacere si estingue con il ritiro della catessi dai pensieri di transfert nel Prec.; e questo risultato significa che l'intervento di principio di dispiacere stato utile. Ma la situazione è diversa quando il desiderio inconscio represso riceve un rinforzo organico, che passa ai pensieri di transfert; in tal modo può metterli in posizione di fare un tentativo di penetrare con la loro eccitazione anche se hanno perduto l'occupazione del Prec. Allora segue una lotta difensiva, poiché il Prec. a sua volta rinforza la sua opposizione ai pensieri rimossi (per esempio, produce una «contro-carica») e in seguito i pensieri di traslazione, che sono i veicoli del desiderio inconscio, penetrano sotto forma di compromesso, ottenuto con la produzione di un sintomo. Ma dal momento in cui i pensieri repressi sono fortemente occupati dall'impulso di desiderio inconscio e nello stesso tempo sono abbandonati dalla carica preconscia, si assoggettano al processo psichico primario e il loro unico scopo è la scarica motoria oppure, se la via è accessibile, la rinascita allucinatoria dell'identità percettiva desiderata. Abbiamo già scoperto empiricamente che i processi irrazionali che abbiamo descritto vengono eseguiti solo su pensieri rimossi. Ora possiamo avere una visione più ampia di tutta la situazione. I processi primari. Essi appaiono dovunque le rappresentazioni sono abbandonate dalla carica preconscia, sono lasciate a se stesse e possono caricarsi con l'energia non inibita dell'inconscio, che cerca di trovare una via di uscita. Delle altre osservazioni sostengono l'opinione che questi processi che chiamiamo irrazionali non sono in realtà delle falsificazioni di processi normali, degli errori intellettuali, ma sono modi di agire dell'apparato psichico liberati dall'inibizione. Vediamo così che il passaggio dall'eccitazione preconscia al movimento è regolato dagli stessi processi e che il legame tra rappresentazioni preconscie e parole può facilmente mostrare gli stessi spostamenti e confusioni, che sono poi attribuite alla distrazione. Infine si trova la prova dell'aumento di attività, che diviene necessario quando questi modi di funzionamento primari sono inibiti, nel fatto che produciamo un effetto comico, cioè un'eccedenza di energia che deve essere scaricata in risate, se permettiamo a questi modi di pensare la penetrazione nella coscienza. La teoria delle psiconevrosi sostiene come fatto incontestabile e universale che solo gli impulsi di desiderio sessuale dell'infanzia, che hanno subito la rimozione (ad esempio, una trasformazione del loro affetto) durante il periodo di sviluppo infantile, possono essere rivissuti in periodi di sviluppo successivi (sia a causa della costituzione sessuale dell'individuo, che deriva dalla bisessualità iniziale, sia a causa di influenze sfavorevoli che hanno agito sul corso della sua vita sessuale) e sono così in grado di fornire la forza motrice per la formazione di sintomi psiconevrotici di qualsiasi genere. Solo facendo riferimento a queste forze sessuali possiamo colmare le lacune che sono ancora evidenti nella teoria della rimozione. Lascerò aperta la questione della necessità o meno di questi fattori sessuali e infantili nella teoria dei sogni: lascerò la teoria incompleta a questo punto, poiché sono già andato al di là di ciò che può essere dimostrato supponendo che i desideri del sogno derivino sempre dall'inconscio. (Qui e altrove ho lasciato di proposito delle lacune nello svolgimento del mio argomento, poiché colmarle richiederebbe da un lato uno sforzo troppo grande e implicherebbe dall'altro un fondamento su materiale estraneo all'argomento dei sogni. Per esempio, non ho detto se attribuisco significati diversi alle parole «represso» e «rimosso». Dovrebbe tuttavia essere chiaro che il secondo accentua più del primo il collegamento con l'inconscio. Né ho approfondito il problema del perché i pensieri onirici siano soggetti alla deformazione della censura anche nei casi in cui hanno abbandonato la via progressiva verso la coscienza e hanno scelto quella regressiva. E ci sono molte omissioni analoghe. Quello che mi premeva fare era creare un'impressione dei problemi ai quali deve condurre un'approfondita analisi del lavoro onirico e accennare agli altri argomenti con i quali è connessa quell'analisi. Non è sempre stato facile per me decidere il punto in cui interrompermi nell'esposizione. Per ragioni particolari, probabilmente diverse da quelle che si aspettano i lettori, non ho trattato esaurientemente il ruolo svolto nei sogni dal mondo delle rappresentazioni sessuali ed ho evitato di analizzare sogni di contenuto ovviamente sessuale. Nulla è più lontano dalle mie opinioni e teorie neuropatologiche che il considerare la vita sessuale come qualcosa di vergognoso, cosa che non riguarda il medico o il ricercatore scientifico. Inoltre, mi fa ridere l'indignazione morale che ha spinto il traduttore dell'Onirocritica di Artemidoro a saltare il capitolo sui sogni sessuali. La mia decisione deriva dal fatto che una spiegazione dei sogni sessuali mi farebbe invischiare in problemi ancora insoluti della perversione e della bisessualità; di conseguenza, riservo questo materiale ad un'altra occasione.) Né intendo indagare ulteriormente sulla natura della distinzione tra il gioco delle forze psichiche nella formazione dei sogni e nella formazione dei sintomi isterici: siamo ancora privi di sufficienti nozioni esatte su uno dei due termini di paragone. Tuttavia c'è un altro punto cui attribuisco importanza; e devo confessare che solo per esso ho intrapreso tutte queste discussioni sui due sistemi psichici, sul loro modo di agire, sulla repressione. Non è questione di stabilire ora se mi sono formato un'opinione abbastanza corretta dei fattori psicologici dei quali ci stiamo occupando, o se il mio quadro è deformato e incompleto, il che è possibile in materie così difficili. Per quante modificazioni possano essere fatte sulla censura psichica e sulle revisioni razionali e anormali del contenuto dei sogni, resta vero che i processi di questa specie sono attivi nella formazione dei sogni e mostrano una strettissima analogia nella loro essenza con i processi rilevati nella formazione dei sintomi isterici. Tuttavia il sogno non è un fenomeno patologico; non presuppone un disturbo dell'equilibrio psichico; non lascia dietro di sé una perdita di efficienza. Si può suggerire che non si possono trarre conclusioni sui sogni di persone sane dai sogni miei e dei miei pazienti; ma credo che si possa trascurare questa obiezione. Se poi possiamo dedurre dai fenomeni le loro forze motrici, dobbiamo riconoscere che il meccanismo psichico delle nevrosi non è creato dall'influenza di un disturbo patologico sulla mente, ma è già presente nella normale struttura dell'apparato psichico. I due sistemi psichici, la censura sul passaggio da uno all'altro, l'inibizione e il sovrapporsi di un'attività all'altra, i rapporti con la coscienza - o qualsiasi altra interpretazione più esatta dei fatti osservati che possa sostituirli - tutto ciò fa parte della normale struttura del nostro strumento mentale, e i sogni ci indicano una delle vie che portano alla comprensione della sua struttura. Se ci limitiamo al minimo delle nuove nozioni che sono state stabilite con certezza, possiamo ancora affermare dei sogni che hanno dimostrato che ciò che è represso continua ad esistere nelle persone normali e in quelle anormali e rimane capace di attività psichiche. Gli stessi sogni sono una manifestazione di questo materiale represso; ciò è valido teoricamente in tutti i casi e si può osservare empiricamente almeno in un gran numero di casi, e precisamente nei casi che mostrano più chiaramente le strane caratteristiche della vita onirica. Durante la veglia il materiale represso nella mente non può esprimersi ed è isolato dalla percezione interna, per il fatto che le contraddizioni presenti in esso sono eliminate; ma durante la notte, governato da un impeto verso la formazione di compromessi, questo materiale represso riesce a penetrare nella coscienza. Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. L'interpretazione dei sogni è la strada maestra verso la conoscenza delle attività inconscie della mente. Analizzando i sogni, possiamo fare un passo avanti nella comprensione della composizione del più meraviglioso e misterioso di tutti gli strumenti. Solo un piccolo passo, senza dubbio, ma è un inizio; e questo inizio ci permetterà di procedere con la sua analisi, sulla base di altre strutture che dovremo definire patologiche. Poiché le malattie - almeno quelle che sono giustamente chiamate «funzionali» - non presuppongono la distruzione dell'apparato né la produzione di nuove lesioni nel suo interno si devono spiegare su una base dinamica, con il rafforzamento o l'indebolimento delle varie componenti nel gioco delle forze, i cui effetti sono in gran parte nascosti finché le funzioni sono normali. Spero di poter mostrare altrove che la composizione dell'apparato fatta di due istanze rende possibile un funzionamento della mente anche normale più raffinato di quello che si avrebbe con una sola istanza. (I sogni non sono gli unici fenomeni che ci permettano di trovare nella psicologia una base per la psicopatologia. In una breve serie di articoli, non ancora completata, ho cercato di interpretare alcuni fenomeni della veglia, per dimostrare questa affermazione. Questi scritti, insieme con altri sulla dimenticanza, sui lapsus ecc., sono stati riuniti sotto il titolo di Psicopatologia della vita quotidiana.) (F) L'INCONSCIO E LA COSCIENZA. LA REALTÀUn esame più attento ci mostrerà che la discussione psicologica dei capitoli precedenti ci invita a postulare non l'esistenza di due sistemi vicini all'estremità motoria dell'apparato, ma l'esistenza di due tipi di processi di eccitazione o modi di scarica. Per noi si tratta di una cosa sola, perché dobbiamo sempre essere pronti a lasciar cadere la nostra impalcatura di concetti, se riteniamo di essere in grado di sostituirla con qualcosa che si avvicini maggiormente alla realtà ignota. Cerchiamo perciò di correggere alcuni concetti che potrebbero sviarci se consideriamo i due sistemi nel senso più letterale e rozzo come due località dell'apparato psichico; concetti che hanno lasciato le loro tracce nelle espressioni «rimuovere» e «penetrare». Possiamo quindi parlare di un pensiero inconscio che cerca di portarci nel preconscio per poter poi penetrare nella coscienza. Non intendiamo così dire che si forma un secondo pensiero collocato in un nuovo posto, come una trascrizione che continua ad esistere insieme all'originale; e la nozione di penetrazione nella coscienza non deve implicare l'idea di un cambiamento di posto. Ancora, possiamo parlare di un pensiero preconscio che viene represso o espulso e poi accolto dall'inconscio. Queste immagini, prese da una serie di idee che si riferiscono alla lotta per un po' di spazio, ci tentano a credere che sia letteralmente vero che un raggruppamento mentale in una località si estingua e venga sostituito da uno nuovo in un'altra. Sostituiamo queste metafore con qualcosa che sembri corrispondere meglio allo stato reale delle cose e diciamo piuttosto che un'occupazione di energia è stata collegata ad un particolare raggruppamento psichico, o è stata da esso ritirata, in modo che la formazione in questione è venuta ad assoggettarsi ad un'istanza particolare o è stata sottratta ad essa. Qui stiamo di nuovo sostituendo ad un modo topografico di rappresentare le cose un modo dinamico. Non consideriamo mobile la struttura psichica stessa ma la sua innervazione. (È stato necessario elaborare e modificare questa opinione quando si è riconosciuto che la caratteristica essenziale di una idea preconscia era il suo nesso con i residui di rappresentazioni verbali.) Tuttavia mi sembra conveniente e giustificato continuare ad usare il quadro figurativo dei due sistemi. Possiamo evitare qualsiasi possibile abuso di questo metodo di rappresentazione ricordando che le idee, i pensieri e le strutture psichiche in genere non devono mai essere considerati come localizzati in elementi organici del sistema nervoso, ma piuttosto tra essi, per modo di dire, dove le resistenze e le agevolazioni forniscono i loro corrispondenti. Tutto ciò che può essere oggetto della nostra percezione interna è virtuale, come l'immagine prodotta in un telescopio dal passaggio di un raggio di luce. È giusto però ritenere che i sistemi esistano (anche se non sono in alcun modo delle entità psichiche e non possono mai essere accessibili alla nostra percezione psichica) come le lenti del telescopio che riflettono l'immagine. E continuando con l'analogia, possiamo paragonare la censura tra i due sistemi alla rifrazione che avviene quando un raggio di luce passa in un nuovo mezzo. Finora abbiamo fatto della psicologia per conto nostro. È tempo di prendere in considerazione le teorie che dominano l'attuale psicologia e di esaminare la loro relazione con le nostre ipotesi. Il problema dell'inconscio nella psicologia, secondo l'efficace espressione di Lipps, è più il problema della psicologia che un problema psicologico. Finché la psicologia risolveva questo problema con una spiegazione verbale dicendo che «psichico» significava «conscio» e che parlare di «processi psichici inconsci» era un tangibile controsenso, era fuori questione qualsiasi valutazione psicologica delle osservazioni fatte dai medici su stati psichici anormali. Il medico e il filosofo si incontrano solo se entrambi riconoscono che l'espressione «processi psichici inconsci» è «l'espressione giusta e adatta di un fatto assodato con certezza». Il medico può solo scrollare le spalle, se si sente dire che «la coscienza è la caratteristica indispensabile di ciò che è psichico», e forse, se nutre ancora abbastanza rispetto per le espressioni dei filosofi, penserà che non si sono occupati della stessa cosa e non hanno lavorato per la stessa scienza. Poiché anche una sola osservazione comprensiva della vita psichica di un nevrotico o un'unica analisi di un sogno devono lasciargli l'irremovibile convinzione che i più complicati e razionali processi del pensiero, cui certamente non si può negare il nome di processi psichici, possono manifestarsi senza eccitare la coscienza del soggetto. (Sono lieto di poter indicare un autore che ha tratto dallo studio dei sogni le mie stesse conclusioni sul rapporto tra attività conscia e inconscia. Du Prel scrive: «Il problema della natura della mente richiede evidentemente un'indagine preliminare per stabilire se coscienza e mente siano identiche. A questa domanda preliminare i sogni rispondono negativamente, poiché mostrano che il concetto di mente è più ampio di quello di coscienza, allo stesso modo in cui la forza gravitazionale di un corpo celeste si estende al di là della sfera luminosa».) È vero che il medico ignora questi processi inconsci finché essi non abbiano prodotto qualche effetto sulla coscienza, che può essere comunicato o osservato. Ma questo effetto cosciente può mostrare un carattere psichico del tutto differente da quello del processo inconscio, cosicché la percezione interna non ha la possibilità di considerare l'uno un surrogato dell'altro. Il medico deve sentirsi libero di dedurre dall'effetto conscio il processo psichico inconscio. Egli apprende così che l'effetto cosciente è solo un remoto effetto psichico del processo inconscio e che quest'ultimo non è diventato cosciente come tale; e che inoltre era presente e attivo senza rivelare in alcun modo la sua esistenza alla coscienza. È necessario abbandonare la sopravvalutazione della qualità di essere coscienti per potersi formare una visione esatta dell'origine di ciò che è psichico. Secondo l'espressione di Lipps, si deve ritenere che l'inconscio sia la base generale della vita psichica. L'inconscio è la sfera più larga, che comprende all'interno la più piccola del conscio. Qualsiasi cosa cosciente ha uno stadio preliminare inconscio; mentre ciò che è inconscio può restare a quello stadio e tuttavia reclamare il valore pieno di processo psichico. L'inconscio è la vera realtà psichica; nella sua intima essenza ci è sconosciuto quanto la realtà del mondo esterno, e la coscienza ce lo presenta in modo così incompleto come i nostri organi sensori ci comunicano il mondo esterno. Ora che l'antica antitesi tra vita cosciente e vita onirica è stata ridotta alle sue giuste proporzioni mediante la definizione della realtà psichica inconscia, molti problemi onirici che avevano preoccupato gli autori precedenti hanno perso il loro significato. Così alcune attività la cui perfetta esecuzione durante il sogno destava stupore non si attribuiscono più ai sogni ma al pensare inconscio, che è attivo sia durante il giorno che durante la notte. Se, come ha detto Scherner, sembra che i sogni siano impegnati a fare delle rappresentazioni simboliche del corpo, sappiamo ora che quelle rappresentazioni sono il prodotto di determinate fantasie inconscie (derivanti probabilmente da impulsi sessuali) che trovano espressione non solo nei sogni, ma anche nelle fobie isteriche e in altri stimoli. Se un sogno continua le attività del giorno e le completa e porta perfino alla luce delle nuove idee, dobbiamo solo spogliarlo della maschera onirica, che è il prodotto del lavoro onirico e l'indizio dell'aiuto prestato da forze oscure della profondità della psiche (cfr. il diavolo nel sogno della sonata di Tartini); il risultato intellettuale è dovuto alle stesse forze mentali che producono altri risultati simili durante il giorno. Siamo probabilmente portati a sopravvalutare notevolmente il carattere cosciente della produzione intellettuale e artistica. I racconti fatti da alcuni degli uomini più produttivi, quali Goethe e Helmholtz, ci mostrano piuttosto che ciò che è essenziale e nuovo nelle loro creazioni è venuto loro senza premeditazione e quasi come un insieme già pronto. Non c'è nulla di strano se in altri casi, dove si richiedeva una concentrazione di tutte le facoltà intellettuali, anche l'attività cosciente abbia dato il suo contributo. Ma l'attività cosciente abusa troppo del suo privilegio per cui, ogni volta che ha un ruolo, nasconde ai nostri occhi tutte le altre attività. Non vale la pena di esporre separatamente il valore storico dei sogni. Un sogno può aver spinto qualche condottiero a intraprendere un'impresa audace, il cui successo ha cambiato la storia. Ma questo solleva un nuovo problema nella misura in cui un sogno viene considerato una forza estranea contrastante con le altre forze più note della mente; non resta più un tale problema se si riconosce il sogno come una forma espressiva di impulsi, che sono riusciti durante la notte a ricevere rinforzi da fonti di eccitazioni profonde. (Cfr. a questo proposito il sogno di Alessandro il Grande durante l'assedio di Tiro) Il rispetto rivolto ai sogni nell'antichità è tuttavia basato su una corretta introspezione psicologica ed è un omaggio alle forze incontrollate e indistruttibili della mente umana, al potere demoniaco che produce il desiderio del sogno e che opera nel nostro inconscio. Non a caso parlo del «nostro» inconscio. Perché così non intendo dire lo stesso che l'inconscio dei filosofi o l'inconscio di Lipps. Essi usano il termine semplicemente per indicare il contrasto con il cosciente: la tesi che essi sostengono con tanto ardore e difendono con tanta energia è che oltre al cosciente ci siano anche processi psichici inconsci. Lipps arriva al punto di affermare che tutto ciò che è psichico esiste inconsciamente e che una parte di esso esiste anche coscientemente. Ma noi non abbiamo richiamato i fenomeni dei sogni e della formazione dei sintomi isterici per dimostrare questa tesi; l'osservazione della vita normale della veglia basterebbe da sola a dimostrarla al di là di ogni dubbio. L'elemento nuovo che abbiamo appreso dall'analisi delle formazioni psicopatologiche e del primo anello di quella classe, il sogno, si trova nel fatto che l'inconscio (cioè, lo psichico) è una funzione in due sistemi separati e che questo è valido nella vita normale come in quella patologica. Quindi ci sono due tipi di inconscio, che non sono ancora stati distinti dagli psicologi. Sono entrambi inconsci nel senso usato dalla psicologia; ma nel nostro senso uno di essi, che chiamiamo Inc., non può accedere alla coscienza, mentre chiamiamo l'altro Prec. perché le sue eccitazioni, dopo aver osservato certe regole e subito una nuova censura, ma indipendentemente dall'Inc, possono raggiungere la coscienza. Il fatto che le eccitazioni per raggiungere la coscienza debbano passare attraverso una serie prefissata o gerarchia di istanze (che ci vengono rivelate dalle modificazioni operate dalla censura) ci ha permesso di costruire un paragone spaziale. Abbiamo descritto i rapporti dei due sistemi tra loro e con la coscienza dicendo che il sistema Prec. si erge come uno schermo tra il sistema Inc. e la coscienza. Il sistema Prec. non solo sbarra l'accesso alla coscienza, ma controlla anche l'accesso alla capacità di movimento volontario e regola la distribuzione di un'energia di occupazione mobile, di cui ci è nota una parte in forma di attenzione. (Cfr. il mio articolo Bemerkungen über den Begriff des Unbewussten in der Psychoanalyse nei «Proceedings of the Society for Psychal Research», dove ho distinto i significati (descrittivo, dinamico e sistematico) dell'ambigua parola «inconscio».) Dobbiamo anche evitare la distinzione tra «supercosciente» e «subcosciente», che è diventata così popolare nella letteratura più recente delle psiconevrosi, poiché tale distinzione sembra proprio voler sottolineare l'equivalenza di ciò che è psichico e ciò che è conscio. Ma quale ruolo svolgerà nel nostro schema la coscienza, che una volta era così onnipotente e nascondeva tutto il resto? Solo quello di un organo sensorio per la percezione di qualità psichiche. In seguito ai concetti su cui si basa il nostro tentativo di un quadro schematico, possiamo considerare la percezione cosciente solo come la funzione propria di un particolare sistema, per il quale sembra adatta l'abbreviazione C. Per quanto riguarda le sue proprietà meccaniche, consideriamo questo sistema simile ai sistemi percettivi P, cioè eccitabile da qualità, ma incapace di trattenere le tracce delle alterazioni e quindi privo di memoria. L'apparato psichico che è rivolto al mondo esterno con il suo organo sensorio dei sistemi percettivi rappresenta esso stesso il mondo esterno rispetto all'organo sensorio della C, la cui giustificazione teleologica consiste in questa situazione. Anche qui troviamo il principio della gerarchia delle istanze, che sembrano dominare la struttura dell'apparato. Le eccitazioni arrivano all'organo sensorio della C da due direzioni: dal sistema P, la cui eccitazione, determinata da qualità, è probabilmente sottoposta a una nuova revisione prima di diventare una sensazione cosciente, e dall'interno dell'apparato stesso, i cui processi quantitativi sono sentiti qualitativamente nella serie piacere-dispiacere quando, sottoposti a determinati cambiamenti, penetrano nella coscienza. Quei filosofi che si sono accorti della possibilità di strutture di pensiero razionali e notevolmente complesse, senza la partecipazione della coscienza, hanno trovato difficoltà nell'assegnare una funzione qualsiasi alla coscienza; sembrava loro che non potesse essere altro che un'immagine riflessa superflua del processo psichico completo. L'analogia tra il nostro sistema C e i sistemi percettivi elimina per noi questo imbarazzo. Sappiamo che la percezione dei nostri organi sensori ha l'effetto di dirigere una catessi di attenzione verso le vie lungo le quali si sta diffondendo l'eccitazione sensoria; l'eccitazione qualitativa del sistema percettivo regola la scarica della quantità mobile nell'apparato psichico. Possiamo attribuire la stessa funzione all'organo sensorio sovrapposto al sistema C Con la percezione di nuove qualità, esso contribuisce nuovamente a dirigere le quantità mobili di catessi e a distribuirle in maniera conveniente. Con l'aiuto della sua percezione del piacere e dispiacere, influenza la scarica delle catessi all'interno di quello che è altrimenti un apparato inconscio, che opera mediante lo spostamento delle quantità. Sembra probabile che in un primo momento il principio del dispiacere regoli lo spostamento di occupazioni automaticamente. Ma è molto possibile che la coscienza di queste qualità aggiunga una seconda regolazione più discriminante, che può anche opporsi alla prima e che completa l'efficienza dell'apparato mettendolo in grado, contrariamente al progetto originario, di occupare e elaborare ciò che è associato con la scarica di dispiacere. Apprendiamo dalla psicologia delle nevrosi che questi processi di regolazione compiuti dall'eccitazione qualitativa degli organi sensori hanno una parte importante nell'attività funzionale dell'apparato. Il dominio automatico del principio del dispiacere primario e la conseguente limitazione imposta sull'efficienza vengono interrotti dai processi di regolazione sensoria, che agiscono a loro volta automaticamente. Riteniamo che la repressione (che, pur essendo utile al principio, porta in ultima analisi ad una dannosa perdita di inibizione e di controllo mentale) influenzi tanto più facilmente i ricordi che le percezioni, perché i primi non possono ricevere altra catessi dall'eccitazione degli organi sensori psichici. È vero che un pensiero che deve essere scartato, da un lato, può diventare cosciente perché ha subito la repressione; ma, d'altro canto, avviene a volte che un pensiero di questo tipo venga represso solo perché per altri motivi è stato ritirato dalla percezione cosciente. Questi sono alcuni cenni di ciò di cui ci avvantaggiammo nel nostro procedimento terapeutico per sciogliere le repressioni che sono state già effettuate. Il valore della iper-catessi stabilita nelle quantità mobili dall'influenza regolatrice dell'organo sensorio della C è ben illustrato nel suo aspetto teleologico dalla sua creazione di una nuova serie di qualità e di conseguenza di un nuovo processo di regolazione, che costituisce la superiorità dell'uomo sull'animale. I processi di pensiero in sé sono privi di qualità, tranne per le eccitazioni piacevoli e spiacevoli che li accompagnano e che devono essere frenate, in vista del possibile disturbo effettuato sul pensare. Perché i processi di pensiero acquistino qualità, vengono associati negli esseri umani con ricordi di parole, i cui residui di qualità sono sufficienti ad attirare l'attenzione della coscienza in sé e a dotare il processo del pensare di una nuova occupazione mobile da parte della coscienza. I molteplici problemi della coscienza si possono afferrare solo mediante un'analisi dei processi di pensiero nell'isteria. Questi danno l'impressione che il passaggio da una catessi preconscia ad una cosciente sia segnato da una censura simile a quella esistente tra l'lnc. e il Prec. Anche questa censura agisce solo al di sopra di un certo limite quantitativo, cosicché le strutture di pensiero di bassa intensità la sfuggono. Nella struttura dei fenomeni psiconevrotici si possono trovare tutti i possibili esempi di come un pensiero venga sottratto alla coscienza o penetri nella coscienza con determinate limitazioni; e tutti mettono in evidenza le intime relazioni reciproche tra censura e coscienza. Porterò a termine queste riflessioni psicologiche con il racconto di due di questi esempi. Fui chiamato a consulto l'anno scorso per visitare una ragazza intelligente e spigliata. La sua tenuta è sorprendente. Infatti, mentre in genere gli abiti di una donna sono curati fin nel minimo particolare, una delle sue calze pendeva giù e due bottoni della sua camicetta erano aperti. Si lamentava di avere dolori a una gamba e, senza che glielo chiedessi, denudò il polpaccio. Si lamentava principalmente, nelle sue stesse parole, di avere la sensazione che nel suo corpo fosse conficcato qualcosa che andava avanti e indietro e la scuoteva continuamente: a volte le faceva sentire rigido il suo corpo. Il mio collega che era presente alla visita mi guardò; non gli era difficile capire il significato di quella sua lamentela. Ma quello che ci sembrava straordinario era il fatto che non significasse nulla per la madre della paziente, anche se essa doveva essersi trovata spesso nella situazione che la figlia stava descrivendo. La ragazza stessa non aveva idea della portata delle sue affermazioni; infatti, se avesse capito, non le avrebbe mai espresse. In questo caso era stato possibile ingannare la censura concedendo che una fantasia che normalmente sarebbe rimasta nel preconscio arrivasse alla coscienza sotto la maschera innocente di una lamentela. Ed ecco un altro esempio. Un ragazzo di quattordici anni venne da me per un trattamento psicoanalitico, poiché soffriva di tic convulsi, vomito isterico, emicranie ecc. Cominciai il trattamento assicurandogli che, se avesse chiuso gli occhi, avrebbe visto delle immagini o avuto dei pensieri, che poi mi doveva comunicare. Egli rispose in immagini. L'ultima impressione che aveva avuto prima di venire da me rivisse visualmente nel suo ricordo. Egli aveva giocato a dama con suo zio e vedeva la scacchiera davanti a sé. Pensò a varie posizioni favorevoli o sfavorevoli e alle mosse che non bisognava fare. Poi vide un pugnale sulla scacchiera, un oggetto che apparteneva a suo padre, ma che la sua fantasia collocava sulla tavola. Poi c'era una falce sulla scacchiera e una roncola. E poi apparve l'immagine di un vecchio contadino che falciava l'erba davanti alla casa del paziente. Dopo qualche giorno scoprii il significato di questa serie di immagini. Il ragazzo era stato sconvolto da un'infelice situazione familiare. Il padre era un uomo duro, irascibile, il cui matrimonio con la madre del paziente non era stato felice e i cui sistemi educativi erano fatti di minacce. Il padre aveva divorziato dalla madre, una donna tenera e affettuosa, si era sposato di nuovo e un giorno aveva portato a casa una giovane donna che doveva essere la nuova madre del ragazzo. Pochi giorni dopo il ragazzo di quattordici anni si era ammalato. Era stata la sua ira repressa contro il padre a fargli costruire quella serie di immagini con le loro comprensibili allusioni. Il materiale derivava da un ricordo mitologico. La roncola era quella con la quale Giove evirò il padre; la falce e l'immagine del vecchio contadino rappresentavano Crono, il vecchio violento che divorò i figli e sul quale Giove si vendicò in modo così poco filiale. Il matrimonio del padre aveva fornito al ragazzo l'occasione per restituire i rimproveri e le minacce che aveva udito dal padre molto tempo prima, perché giocava con i suoi genitali. (Cfr. il gioco a dama; le mosse proibite; il pugnale che si poteva usare per uccidere). In questo caso, ricordi rimossi da molto tempo e derivati che erano rimasti incosci penetrarono nella coscienza con un giro vizioso, sotto forma di immagini apparentemente prive di significato. Quindi cercherei il valore teorico dello studio dei sogni nel suo contributo alla conoscenza psicologica e nei chiarimenti preliminari sui problemi delle psiconevrosi che esso offre. Chi può prevedere l'importanza dei risultati che si potrebbero ottenere da una comprensione totale della struttura e delle funzioni dell'apparato psichico, dal momento che anche lo stato attuale delle nostre conoscenze ci permette di esercitare una favorevole influenza terapeutica sulle forme guaribili di psiconevrosi? Ma mi sento chiedere quale sia il valore pratico di questo studio come mezzo per la comprensione della mente, per la rivelazione delle caratteristiche nascoste dei singoli uomini. Gli impulsi inconsci svelati dai sogni non hanno forse il valore di forze reali nella vita psichica? Bisogna ricercare il valore etico dei desideri repressi, desideri che come portano ai sogni, potrebbero un giorno portare ad altre azioni? Non mi sembra giusto rispondere a queste domande: non ho approfondito questo aspetto del problema dei sogni. Tuttavia credo che l'imperatore romano che fece uccidere uno dei suoi uomini perché aveva sognato di assassinare l'imperatore avesse torto. Avrebbe dovuto cominciare con il cercare di scoprire il significato del sogno; molto probabilmente il suo significato era diverso da quello che sembrava. E anche se un sogno con un contenuto diverso contenesse un atto di lesa maestà come significato, non sarebbe forse giusto ricordare il detto di Platone, che l'uomo virtuoso si accontenta di sognare ciò che un uomo malvagio fa realmente? Credo che la cosa migliore sia lasciar liberi i sogni. Non sono in grado di dire se dobbiamo attribuire realtà ai desideri inconsci; dobbiamo negarla naturalmente a tutti i pensieri di passaggio o intermedi. Se consideriamo i desideri inconsci ridotti alla loro forma più fondamentale e autentica, dovremo senza dubbio concludere che la realtà psichica è una particolare forma di esistenza da non confondere con la realtà materiale. Quindi non sembra che ci sia alcuna giustificazione per la riluttanza della gente ad accettare la responsabilità per l'immoralità dei propri sogni. Quando il funzionamento dell'apparato psichico verrà giustamente apprezzato e la relazione tra il conscio e l'inconscio sarà compresa, la maggior parte di ciò che è eticamente contestabile nelle nostre fantasie e nei nostri sogni scomparirà. Secondo l'espressione di Hanns Sachs: «Se osserviamo nella nostra coscienza qualcosa che ci è stato detto da un sogno su una situazione attuale (reale), non dovremmo sorprenderci di scoprire che il mostro che abbiamo visto sotto la lente d'ingrandimento dell'analisi è piccolo come un infusore». Per giudicare agli effetti pratici il carattere dell'uomo, sono in genere sufficienti le azioni e le opinioni espresse coscientemente. Innanzitutto le azioni; infatti molti impulsi che si fanno strada fino alla coscienza vengono tuttavia annullati dalle forze reali della vita psichica prima di poter maturare in azioni. Anzi, tali impulsi spesso non trovano ostacoli psichici al loro avanzamento, proprio perché l'inconscio è sicuro che essi saranno fermati in qualche altro stadio. In ogni caso è istruttivo riuscire a sapere da quale suolo calpestato spuntano fiere le nostre virtù. Molto raramente la complessità del carattere umano, spinto qua e là da forze dinamiche, si sottopone a una scelta tra semplici alternative, come la nostra antica morale vorrebbe farci credere. E il valore dei sogni per farci conoscere il futuro? Naturalmente un simile problema non esiste. Sarebbe più esatto dire piuttosto che ci fanno conoscere il passato. Infatti i sogni derivano dal passato in tutti i sensi. Tuttavia l'antica opinione che i sogni predicano il futuro non è del tutto priva di verità. Nel mostrarci i nostri desideri realizzati, i sogni dopo tutto ci portano nel futuro. Ma questo futuro, che il sognatore immagina come presente, è stato modellato dal desiderio indistruttibile a immagine di quel passato. |