Mauro ManciaSonno e sognoLaterza, Roma-Bari 1996 |
Capitolo nonoPSICOFISIOLOGIA DEL SONNOLa ricerca psicofisiologica ha dimostrato che durante il sonno la nostra mente non conosce riposo. Tuttavia, le caratteristiche di questa attività mentale in rapporto all'addormentamento e alle diverse fasi del sonno non sono state completamente chiarite. Varie sono le difficoltà in questo tipo di ricerca: da una parte, si pongono questioni di natura metodologica come il setting sperimentale, le aspettative dello sperimentatore, le modalità con cui vengono raccolti i dati, il tempo di risveglio in rapporto alle diverse fasi del sonno, il tipo di stimolo che si usa per il risveglio e le modalità elaborative del materiale raccolto nei risvegli; dall'altra, non è affatto semplice definire le esperienze mentali che sono oggetto di indagine. Ad esempio, lo stesso sogno può andare incontro a definizioni estremamente estensive come quella di Fromm (1951), secondo il quale è sogno qualsiasi attività mentale che compare nel sonno, o a definizioni più restrittive come quella di Bosinelli e Franzini (1986, p. 302), che definiscono il sogno «una esperienza mentale del sonno che abbia carattere di alienità o comunque di non sovrapponibilità rispetto al presente topo-cronologico (hic et nunc) del dormiente, che mostri una maggiore o minore vividezza percettiva con frequente sentimento di partecipazione personale del sognatore, e che sia accompagnata da inefficacia dell'esame di realtà e da perdita del controllo volontario del corso del pensiero». Le esperienze classiche di psicofisiologia del sonno nascono negli anni '50 da parte di Aserinsky e Kleitman (1953), Dement (1965) e Dement e Kleitman (1957). Questi ultimi, risvegliando i soggetti volontari da esperimento in coincidenza di episodi di sonno REM, potevano registrare un protocollo che era classificato come sogno nel 79% dei casi. Quando il risveglio avveniva nelle fasi di sonno non-REM, i sogni erano presenti solo nel 7% dei casi. Questi dati erano confermati da Wolpert e Trosman (1958), che riportavano sogni dettagliati per risvegli in fase REM nell'85% dei casi, mentre non si avevano sogni quando il risveglio avveniva al di fuori di queste fasi. Si ponevano quindi le basi per un modello dicotomico REM/non-REM come equivalente neurobiologico di un'attività mentale differenziata. Lavorando nell'ambito degli episodi REM, vari autori hanno collegato la durata di un singolo episodio con la quantità di materiale onirico raccolto (Wolpert e Trosman, 1958), la quantità di movimenti oculari in rapporto ai contenuti onirici (Dement e Wolpert, 1958) e persino la direzione specifica dei movimenti oculari in rapporto alla organizzazione spaziale degli eventi del sogno (Dement, 1965; Molinari e Foulkes, 1969; Roffwarg et al., 1962). In rapporto all'attività motoria oculare nel sonno REM, Molinari e Foulkes (1969) hanno proposto un ulteriore modello dicotomico tra episodi REM con movimenti oculari (REM-m) e REM senza movimenti oculari (REM-q). Nel primo caso l'esperienza onirica è molto più ricca in allucinazioni visive, mentre l'esperienza mentale in REM-q presenta una maggiore ricchezza in elaborazioni cognitive e una minore partecipazione percettiva. Tutte queste esperienze confermano l'ipotesi che il sonno REM sia la base neurofisiologica per l'evento sogno, ipotesi che si basa evidentemente su un isomorfismo tra eventi mentali (l'esperienza onirica soggettiva) ed eventi neurofisiologici (gli aspetti tonico-fasici obiettivi del sonno REM). Tra questi ultimi eventi, di notevole importanza ai fini della ricerca psicologica sono la desincronizzazione EEG, i movimenti oculari, le onde ponto- genicolo-occipitali (PGO). La desincronizzazione EEG esprime un elevato grado di attivazione neocorticale che costituisce la base per un alto grado di attività percettiva e cognitiva, oltre che per l'attivazione della memoria, eventi essenziali e caratterizzanti l'esperienza onirica. I movimenti oculari sono stati considerati come l'equivalente motorio di una attività allucinatoria capace di contribuire alla creazione dello spazio onirico. Le onde PGO, che si collegano ad una inibizione dell'input visivo e ad una esaltazione del circuito talamo-corticale visivo, sono state considerate come l'espressione elettrica di un processo di decodificazione e lettura delle informazioni che nascono all'interno del sistema nervoso centrale e che sono esperite dal soggetto come allucinazioni visive. La ricchezza del materiale psicofisiologico in sonno REM e la quantità di osservazioni psicofisiologiche hanno permesso a Hobson e McCarley (1977) di elaborare una teoria cosiddetta del «generatore interno», secondo la quale il cervello in sonno REM sarebbe un vero e proprio generatore dello stato di sogno: attivando le strutture pontine responsabili del sonno REM, esso inibirebbe l'input sensoriale e solleciterebbe il cervello dall'interno, producendo informazioni che verrebbero poi elaborate dalle strutture prosencefaliche. Il sogno costituirebbe l'espressione di questa elaborazione neurofisiologica. Da questa teoria deriva un modello del processo onirico che gli stessi autori hanno definito di attivazione-sintesi, per il quale: a) la forza primaria che produce il sogno è fisiologica e non psicologica, in quanto prodotta dall'attivazione periodica e ricorrente di eventi neurali delle regioni pontine determinati genotipicamente; b) la elaborazione delle informazioni che partono automaticamente dal ponte è una operazione di sintesi compiuta dal prosencefalo e finalizzata alla organizzazione delle percezioni, delle emozioni e delle attività cognitive tipiche del sogno; c) il cervello in sonno REM può essere paragonato ad un sofisticato computer in cerca di parole chiave, con il compito di adeguare dati fenotipici derivati dall'esperienza a stimoli genotipici. Rimando ai prossimi capitoli il mio commento all'ipotesi di Hobson e McCarley. Tra le esperienze mentali che sono state descritte in sonno REM, meritano un cenno i sogni di angoscia o incubi, il cui contenuto è facilmente memorizzabile e che spesso risvegliano il sognatore permettendogli di recuperare l'esame di realtà. L'incubo non va confuso con gli episodi di pavor nocturnus, che compaiono invece nella fase non-REM del sonno. In sonno REM è possibile osservare anche il sogno lucido, un episodio di tipo onirico in cui il sognatore si rende conto di sognare ed è quindi in grado di gestire il suo materiale onirico. Questo tipo di sogno sembra coincidere con quelle fasi REM con ritmi alfa e bouffées di movimenti oculari rapidi definiti come alfa-REM che indicano un aumento del livello di vigilanza. Esperienze psicofisiologiche sempre concentrate nella fase REM hanno dimostrato che l'organizzazione del sogno, almeno nei suoi aspetti geometrico-spaziali e di codifica-decodifica emozionale, avviene in prevalenza nell'emisfero destro (Antrobus et al., 1983; Bertini e Violani, 1984; Lavie e Tzinchinsky, 1983). Tuttavia, anche l'emisfero sinistro partecipa all'organizzazione del sogno e certamente alla sua narrazione. I numerosi dati sperimentali di questi ultimi trent'anni sembrano dunque convergere su un dato essenziale: il sonno REM ha un ruolo centrale nel meccanismo di produzione del sogno. Una serie di osservazioni eseguite con metodologie più raffinate ed iniziate con Foulkes (1962) ha dimostrato tuttavia l'esistenza di una complessa attività mentale all'addormentamento e nelle fasi non-REM, attività non facilmente distinguibile da quella prodotta in sonno REM. Infatti lo stesso Foulkes, con la richiesta di riferire «ogni cosa che fosse passata per la mente» prima del risveglio, ha ottenuto dei ricordi di sogni nel 74% dei risvegli, di cui il 72% nella fase 2, il 64% nella fase 3 e il 46% nella fase 4 di sonno non-REM. Un esame di questi protocolli (Bosinelli et al., 1974) ha suggerito che nelle fasi non-REM l'attività mentale possa avere delle caratteristiche pensiero-simili, più concettuali, con frammenti di pensieri e riflessioni collegate a esperienze quotidiane orientate verso la realtà, senza allucinazioni e senza autorappresentazioni e, infine, con scarso coinvolgimento emotivo. La ricerca più recente, soprattutto del gruppo di psicologi sperimentali di Bologna, ha fornito un contributo importante all'attività mentale in tutte le fasi del sonno, a cominciare con l'addormentamento. In questa fase, Bosinelli (1991) descrive una progressiva riduzione della coscienza, intesa come consapevolezza di sé, e una caduta dei sistemi di controllo sulla realtà. Questa caduta produce un esito allucinatorio che consiste nel riconoscere un'origine reale alle proprie immagini mentali e nel portarle nello spazio esterno. Ma questo è un processo onirico che fa sì che i sogni di addormentamento non differiscano da quelli che si producono nelle altre fasi del sonno. Un'analisi dei processi psicologici nell'addormentamento, eseguita da Bosinelli (1991), dimostra che il soggetto va incontro ad una frammentazione del pensiero per la progressiva perdita di controllo volontario sulla realtà e sul suo pensiero. E’ questa perdita di controllo a permettere l'intrusione di contenuti involontari bizzarri e regressivi che vanno a costituire il materiale per la successiva produzione onirica. Tali contenuti intrusivi diventano successivamente immagini visive e uditive che costituiscono la base di quelle allucinazioni ipnagogiche descritte da tempo in letteratura (vedi la bibliografia relativa in Bosinelli, 1991). In termini psicodinamici si assiste, all'addormentamento, ad un ritiro di interesse da parte dell'Io da quelle funzioni psicologiche che stabiliscono un contatto con la realtà: prima dal controllo sul pensiero, quindi dalla percezione esterna e, infine, dall'esame di realtà. E’ stata così avanzata l'ipotesi psicodinamica (Vogel, 1978) che l'addormentamento rappresenti un'esperienza destrutturante e ristrutturante l'Io secondo il seguente schema temporale: all'inizio l'Io si destruttura per l'improvvisa deafferentazione sensoriale e successivamente si ristruttura in senso onirico-allucinatorio con la sua partecipazione parziale alla scena onirica. Le esperienze oniriche in addormentamento sono state così classificate: sogni diversi da quelli che compaiono in sonno REM e sogni indistinguibili da questi ultimi. Alcuni protocolli REM e di addormentamento mostrano delle differenze per quel che riguarda la strutturazione spaziale in cui il sogno si svolge e il livello e la qualità della partecipazione personale del sognatore al sogno (Bosinelli et al., 1982). Antrobus (1983) ha suggerito che il parametro quantitativo del conteggio delle parole nelle due diverse esperienze potrebbe rappresentare il mezzo più efficace per l'analisi delle differenze psicologiche tra i due tipi di sogni. Un altro parametro potrebbe essere costituito dal maggior numero di rappresentazioni di sé nel sogno REM rispetto al sogno che compare all'addormentamento (Bosinelli et al., 1974). Una notevole mole di dati riguarda le esperienze mentali nelle varie fasi di sonno non-REM (2, 3, 4) (vedi bibliografia in Cipolli, 1991). Sulla base di questi dati si può oggi affermare che esperienze onirosimili sono prodotte in tutte le fasi del sonno non-REM e REM. Le caratteristiche e i contenuti presenti nei protocolli ottenuti nelle diverse fasi di sonno dipendono in realtà più dalla lunghezza dei resoconti che dalla qualità di essi. Pertanto, le differenze di tipo qualitativo sono riconducibili a differenze di tipo quantitativo. Questa ipotesi è in linea con il pensiero di Antrobus (1986), secondo il quale durante tutte le fasi sono presenti sogni, anche se soltanto in sonno REM esistono condizioni di sufficiente attivazione corticale da poter produrre un recupero della memoria in grado di garantire resoconti di una certa lunghezza. Alcuni autori ritengono infatti che, a causa delle caratteristiche uniche del sonno REM, in particolare l'intensa desincronizzazione EEG con ritmi a 40 Hz (Llinas e Ribary, 1993), la natura dell'attività cognitiva in questa fase non può che essere diversa da quella che compare in sonno non-REM (Lavie, 1994). Per altri autori (Cavallero et al., 1988), invece, le fonti mnestiche accessibili non sono qualitativamente e quantitativamente diverse nei due tipi di sonno, nonostante il diverso livello di attivazione corticale in REM e non-REM. Bisogna comunque riconoscere che il materiale ricavato dai vari risvegli si è rivelato linguisticamente meno organizzato in sonno non-REM rispetto al sonno REM. Questo dato permette anche di ipotizzare che la ridotta attivazione corticale in sonno non- REM comporta una minore capacità di elaborare i materiali immagazzinati in memoria e di distenderli in sequenze narrative. Un'ipotesi, questa, in linea anche con l'esperienza di Antrobus (1983), che ha riscontrato differenze quantitative tra i resoconti in sonno REM e in sonno non-REM, suggerendo che le differenze fondamentali tra le funzioni cognitive nel sonno non-REM e REM consistono: a) nella maggiore capacità in sonno REM di ricordare e descrivere le esperienze mentali; b) nel prestare una maggiore attenzione agli eventi interni; e) in una maggiore quantità di parole usate nella narrazione; d) in una proporzione diretta tra la quantità di parole usate e la bizzarria del sogno. Sono queste le differenze quantitative presenti nelle esperienze oniriche calcolate nelle diverse fasi del sonno. Questi risultati dimostrano che nei due tipi di sonno (REM e non-REM) operano modalità di elaborazione del tutto simili che permettono l'ipotesi di un unico sistema di produzione dell'attività onirica. Le differenze sono di carattere quantitativo, collegate a un'asimmetria funzionale tra le diverse fasi del sonno nei processi di livello superiore e in particolare in quelli relativi alla narrazione. La bizzarria del sogno, più frequente in fase REM, sembra essere dovuta ad un epifenomeno in quanto legata alle differenze quantitative nella lunghezza della narrazione in questa fase del sonno. Capitolo decimoCONSIDERAZIONI SUL SIGNIFICATO FUNZIONALE DEL SONNOSebbene l'uomo trascorra quasi un terzo della sua vita dormendo, non siamo ancora in grado di dare una definizione soddisfacente del significato funzionale che questo stato fisiologico ha per l'individuo. Come abbiamo discusso precedentemente, la privazione di sonno comporta un grave stress per l'organismo e, nell'animale, si assiste ad un deperimento organico fino alla morte. Ciò suggerisce che il sonno è indispensabile per l'economia biologica dell'individuo e per la sua stessa vita. Tuttavia, la trasformazione del sonno e delle sue fasi nel corso della filogenesi in rapporto alla corticalizzazione e nel corso della ontogenesi in rapporto alla maturazione del sistema nervoso centrale, l'estrema variabilità individuale rispetto al bisogno di sonno, la relativa indipendenza della durata del sonno dalle funzioni mentali, permettono di avanzare l'ipotesi che il sonno assolva importanti compiti di adattamento che si accordano con l'estrema plasticità del sistema nervoso centrale. In questa prospettiva evoluzionistica, il sonno presenta analogie con altre funzioni che favoriscono l'adattamento dell'animale alla propria nicchia ecologica facilitandone la sopravvivenza. L'assenza di sonno REM in alcuni cetacei (delfini), ad esempio, risponderebbe a queste esigenze adattative e di sopravvivenza. Un discorso sul significato funzionale del sonno non può non prendere in considerazione i due diversi fondamentali stadi di sonno: quello REM e quello non-REM. È opinione comune che quest'ultima fase, specie nelle sue componenti più lente (onde delta), sia indispensabile per la conservazione e il recupero di funzioni metaboliche e vegetative di base, mentre la fase REM sembra collegata soprattutto a funzioni cerebrali superiori e mentali. In particolare, il sonno delta non-REM sembra collegato alla durata della veglia precedente e alle necessità metaboliche, termoregolatorie e omeostatiche, correlate con la veglia. A favore di questa ipotesi sono la secrezione dell'ormone della crescita, i processi omeostatici e termoregolatori attivi proprio in questa fase di sonno e l'aumento della sua percentuale nella notte successiva a un esercizio fisico prolungato (Walker et al., 1978). Anche la biologia molecolare ha recentemente portato evidenze in favore dell'ipotesi che il sonno abbia funzioni di ristoro (Shiromani et al., 1995). Per contro, il sonno REM è implicato in funzioni psicologiche e costituisce una cornice biologica più adeguata rispetto al sonno non-REM per lo sviluppo di specifiche attività mentali. A sostegno di questa ipotesi sta il fatto che l'organizzazione del sogno, il numero di parole per narrarlo, la sua bizzarria e l'attivazione della memoria indispensabile al processo onirico, sono più evidenti in sonno REM rispetto al sonno non-REM. Inoltre, in sonno REM si assiste ad un aumento della sintesi proteica (Giuditta et al., 1984). Tutto ciò permette di pensare alla fase REM come a una base biologica che facilita il processo di elaborazione delle informazioni e una loro memorizzazione (ipotesi elaborativa e di memorizzazione). E’ necessario qui ricordare che il sonno REM, nel feto e nel neonato, costituisce anche uno stimolo endogeno che facilita la sinaptogenesi e la sua maturazione (ipotesi sinaptogenico-maturativa). Il particolare interesse suscitato dal sonno REM e dai suoi correlati psicofisiologici ha giustificato la comparsa di varie teorie sul significato funzionale di questa fase del sonno. Una ipotesi neurochimico-metabolica (Hartmann, 1973) suggerisce che il sonno REM possa essere deputato al ristoro del sistema catecolaminergico. Questa ipotesi si basa sul fatto che sostanze antidepressive, che aumentano l'attività delle catecolamine, riducono il bisogno di sonno REM. Inoltre, l'autostimolazione dell'animale con elettrodi impiantati nel fascicolo longitudinale mediale facilita la produzione di catecolamine e riduce parallelamente la percentuale di sonno REM. Tuttavia, si è osservato che la privazione di sonno REM può avere un effetto terapeutico in pazienti depressi in cui si ha una deplezione di catecolamine, sicché l'ipotesi di Hartmann deve essere considerata con prudenza. Un'altra ipotesi sulle funzioni del sonno REM, definibile come energetica, considera questa fase del sonno come una stimolazione endogena capace di produrre un certo risveglio della corteccia cerebrale il cui tono è caduto durante il sonno sincrono. Secondo questa ipotesi, il sonno REM rappresenta un momento di riequilibrio omeostatico delle funzioni corticali (Ephron e Carrington, 1966) e costituisce un supporto alla teoria cognitivista secondo la quale la desincronizzazione EEG è l'equivalente elettrico dei processi di apprendimento e attivazione della memoria, indispensabili per la organizzazione del materiale onirico. Una nuova teoria del gruppo neuronale per le funzioni del sonno non-REM è stata recentemente proposta da Krueger e Obal (1993) sulla base dell'ipotesi elaborata da Edelman (1992), secondo la quale le connessioni macroscopiche del cervello sono codificate geneticamente, mentre quelle microscopiche si sviluppano epigenetica- mente e risentono fortemente dell'uso. E quest'ultimo che potrà aumentare l'efficacia sinaptica e facilitare la for mazione di gruppi neuronali che verranno a costituire le unità fondamentali della organizzazione cerebrale. 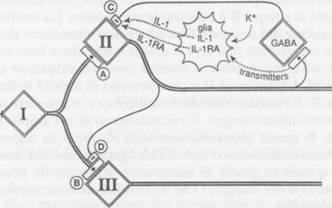
Fig. 26. Diagramma che illustra una possibile funzione del sonno. Nella veglia viene attivato il neurone I che rinforza la sinapsi A, mentre la sinapsi B è relativamente inattiva. L'attivazione del neurone II mette in moto un circuito a feed-back negativo che inibisce il neurone II e pertanto facilita l'attivazione della sinapsi B. Il sistema è così oscillante, con attivazione alternata delle due sinapsi. IL-1: interleuchina 1; IL-1RA: antagonista recettoriale della interleuchina 1 (da Krueger e Obal, 1993). Poiché il sonno inizia come un evento di gruppi neuronali caratterizzato da oscillazioni sinaptiche eccitatorie/inibitorie, è condizionato da circuiti rientranti (ad esempio talamo-corticali e cortico-talamici) che coinvolgono determinate sinapsi, ed è regolato dalla produzione di sostanze il cui catabolismo dipende dall'uso di particolari sinapsi, sembra giustificata l'ipotesi che il sonno serva a stimolare l'uso delle strutture sinaptiche insufficientemente attivate durante la veglia, in modo da rinforzarle e prevenire la loro atrofia. In questa linea di pensiero, il sonno sarebbe una funzione dipendente dall'uso, piuttosto che semplicemente dipendente dalla veglia. Il disegno della figura 26 illustra questa ipotesi: durante la veglia viene attivato, ad esempio, il neurone I che rinforza la sinapsi A, mentre la sinapsi B è relativamente inattiva. La continua eccitazione del neurone II produce una attivazione dei sistemi recettoriali dell'IL-1 e dell'IL-lRA, che a loro volta tendono a far oscillare il sistema con una riduzione dell'attività del neurone II e un aumento di attività della sinapsi B. Il risultato sarebbe la tendenza a mantenere attiva quest'ultima sinapsi. Il reclutamento di un ampio numero di questi elementi neuronali risulterà in ingresso nel sonno sincrono o non-REM. Questa fase del sonno sarà quindi in grado di mantenere attive quelle sinapsi (come la B del disegno) che sono relativamente meno attive in veglia. Tornando al sonno REM, un'altra ipotesi, che potremmo definire strutturale, suggerisce che esso possa avere una funzione specifica di elaboratore delle informazioni da parte dell'emisfero destro e di reset del sistema di registrazione delle informazioni che raggiungono il cervello durante la veglia. Questa ipotesi è in linea con l'osservazione di Bertini e Violani (1984) secondo la quale l'emisfero destro è maggiormente implicato del sinistro nell'elaborazione dei processi onirici che si sviluppano in sonno REM. Alle ipotesi neurobiologiche fin qui menzionate è necessario aggiungere le ipotesi di natura psicologica e psicodinamica relative a quegli stati mentali con caratteristiche specifiche che si organizzano proprio in quella cornice biologica creata dall'addormentamento e dalle diverse fasi del sonno non-REM e REM di cui ho parlato precedentemente. Comunque si vedano le funzioni del sonno, è necessario riconoscere allo stato fisiologico e mentale ad esso collegato un carattere di necessità istintuale e di adattabilità che fa di queste funzioni un elemento indispensabile nel processo vitale di adattamento dei mammiferi e dell'uomo. Capitolo undicesimoSONNO E SOGNO: FISIOLOGIA E PSICOLOGIA A CONFRONTOFra i molteplici scopi del sonno uno, in particolare, è degno di nota per i suoi effetti sulla nostra vita mentale: durante il sonno produciamo metafore su cui possiamo costruire i sogni. Si tratta di un'esperienza specificamente umana, che avviene soltanto durante il sonno. Ma parlare dell'attività mentale e dei sogni nel contesto di un evento biologico complesso come il sonno fa sorgere spontanea una domanda di carattere epistemologico, e cioè quale relazione esiste tra il sonno, i cui principali componenti (comportamentali, elettrici, chimici) sono stati misurati e definiti biologicamente, e l'attività mentale ad esso connessa. E’ chiaro che l'attività onirica è soltanto uno degli aspetti del sonno. Essa è totalmente soggettiva e impossibile da quantificare (come esperienza soggettiva), sebbene il testo riferito al risveglio possa essere quantificato secondo diversi parametri (vedi Bosinelli e Cicogna, 1991). Alcuni neurofisiologici (Hobson e McCarley, 1977; Jouvet, 1991, 1992) sono convinti dell'esistenza di una stretta relazione causale tra eventi fisiologici ed eventi mentali e si sentono liberi di discutere l'attività onirica dal punto di vista biologico, anche se in realtà essa rientra nell'ambito della psicologia. Questi autori interpretano i sogni sulla base di un concetto isomorfico mente-cervello, in cui gli eventi mentali (che sono soggettivi) sono semplicernente presi in considerazione insieme con gli eventi neurobiologici (che sono oggettivi, e dunque misurabili). Per esempio, Hobson e McCarley (1977) hanno proposto - come ho già detto precedentemente - la teoria del generatore interno, secondo la quale il cervello, attivando le cellule colinergiche giganti del ponte che inducono e mantengono il sonno REM, può autonomamente e causalmente generare uno speciale tipo di informazioni, le confronta con le altre, presenti nella memoria a lungo termine, quindi le trasforma e le condensa nell'esperienza e nella narrazione dei sogni. Questa teoria ha dato luogo al modello dell''attivazione- sintesi, basato sul presupposto che le stesse strutture in grado di indurre il sonno REM generino anche informazioni di natura sensoriale che, con l'attivazione della memoria e delle emozioni (attraverso il sistema limbico), creano l'effetto sommativo che dà ai sogni dimensioni spazio-temporali particolari e un carattere drammatico. Il corollario di questa ipotesi costituisce una pesante svalutazione della psicologia rispetto allo studio del sogno, e della storia personale del soggetto rispetto al suo significato. Hobson e McCarley (1982) definiscono pertanto l'attività onirica essenzialmente come «una concomitante obbligatoria e relativamente non distorta di quel determinato stato del cervello detto sonno D [REM]» (p. 125). Questa definizione, ai miei occhi, appare molto povera e fuorviante rispetto al sottile problema epistemologico che il sonno/sogno pone, problema che appartiene a quello più generale della relazione tra mente e cervello. L'ipotesi di Hobson e McCarley può essere criticata da vari punti di vista (Lairy e Salzarulo, 1975; vedi anche Schulz e Salzarulo, 1993). Anzitutto, il sonno REM non è indotto soltanto dall'attivazione delle strutture pontine; altre strutture, come l'amigdala (Sanford et al., 1995; Mariotti et al., 1994), l'ipotalamo posteriore (Sallanon et al., 1988) o alcuni nuclei talamici intralaminari (Marini et al., 1992a), sono coinvolti nel controllo del sonno REM. In secondo luogo - ma non di secondaria importanza - gli psicologi sperimentali hanno recentemente osservato che gli individui non sognano soltanto durante il sonno REM, ma anche mentre si addormentano e in fasi di sonno non-REM (vedi Bosinelli e Cicogna, 1991). Come ho già discusso nei capitoli precedenti, gli psicologi sperimentali (Bosinelli, 1991) affermano che le differenze qualitative tra «protocolli di sogno» nelle diverse fasi di sonno (non-REM e REM) derivano principalmente da differenze quantitative nell'elaborazione di un sistema comune per produrre i sogni. Queste osservazioni concordano con quelle di Salzarulo e Cipolli (1979), secondo cui «i resoconti verbali sono descrizioni dettagliate e abbastanza lunghe dell'esperienza di sonno mentale sia dopo il sonno REM sia dopo quello non-REM, come è dimostrato dalla lunghezza media dei resoconti verbali, dal numero di frasi di cui essi sono composti e dalla frequenza di nuclei di frasi riferite al sonno sia per i resoconti REM sia per quelli non-REM» (pp. 773-774). È stata inoltre osservata una differenza trascurabile nei resoconti verbali dopo il sonno REM-m (con motilità oculare) e REM-q (con quiescenza oculare) (Foulkes e Pope, 1973), in contrasto con le osservazioni di Molinari e Foulkes (1969). Si inserisce in questa linea la recente osservazione di Solms (1995), eseguita su 332 pazienti neurologici con lesioni di varie aree cerebrali. Solms ha dimostrato che i sogni e il sonno REM si sviluppano da strutture anatomiche diverse e interessano meccanismi psicologici differenti. In particolare, i meccanismi psicologici essenziali per la produzione del sogno non sono regolati da quelle strutture del tronco encefalico, in particolare quelle pontine, note come induttori e regolatori fisiologici del sonno REM. I sogni, infatti, sono preservati in pazienti con lesioni anche estese del tronco encefalico, mentre sono aboliti dopo lesioni parietali inferiori e bifrontali. Sogni con una perdita di immaginazione visiva e di allucinazioni sono presenti in soggetti con lesioni dei lobi occipitotemporali, mentre individui con una compromissione delle strutture limbiche diventano incapaci di distinguere i sogni dalla realtà e possono esperire una situazione pressoché continua di sogni. Presi nel loro insieme, questi risultati creano molti dubbi riguardo alla teoria di Hobson e McCarley secondo la quale le strutture del tronco encefalico sono in grado di regolare in maniera critica i processi del sogno; al contrario, suggeriscono che sono proprio quelle parti del cervello implicate nelle operazioni simboliche, nel pensiero spaziale e nel controllo pulsionale, come le aree parietali e frontali, che appaiono essenziali per il processo del sogno. Per Solms, la scena primaria di azione dell'attività mentale durante il sonno si sposta in senso retrospettivo, sotto il controllo inibitorio e regolatore delle aree frontali e limbiche, verso il sistema mnestico-percettivo e simbolico delle regioni parieto-occipitali. Questi sembrano essere i meccanismi essenziali nella produzione del sogno dal punto di vista strettamente neuropsicologico. Il contributo della neurobiologia alla definizione dei vari stati del sonno e delle varie forme di attività mentale ad essi correlate ha costituito un importante strumento di indagine anche per la ricerca cognitivista sull'attività onirica. Per Cavaliere (1991), l'iniziatore dell'approccio cognitivista al sogno è stato Ulric Neisser (1967), il primo a cercare di integrare i processi onirici in uno schema di riferimento cognitivista. In seguito, numerosi altri autori (Antrobus, 1977, 1978; Foulkes, 1978, 1983) hanno fornito contributi significativi. Tre sono i filoni che costituiscono l'approccio cognitivista al sogno: lo human information processing, che pone l'accento sul processo di produzione dell'esperienza onirica; il filone fenomenologico-sperimentale, che costruisce modelli che cercano di spiegare le funzioni simboliche e gli aspetti emotivo-affettivi del sogno; il filone clinico-sperimentale, che tende a mettere in relazione i dati sperimentali con i modelli psicofisiologici di tipo cognitivista. Per Foulkes (1985), il sogno è un processo cognitivo a pieno titolo, prodotto da un unico sistema psicologico che opera nei diversi stadi del sonno. Esso costituisce un processo simbolico di elaborazione, interpretazione, riorganizzazione, in una sequenza narrativa, di tutto il materiale accumulato nella memoria durante la veglia. Le strutture mentali il cui compito è quello di ottenere questa rappresentazione simbolica sono organizzate nella ontogenesi. Secondo Foulkes (1985), questa intelligenza rappresentazionale si sviluppa a partire dal secondo anno di vita attraverso la memoria evocativa. Ma poiché può evocare e rappresentare un oggetto assente, questa è anche definibile come memoria simbolica. Tale processo consente all'individuo di sognare mentre dorme. L'attività onirica è quindi correlata allo sviluppo delle strutture cerebrali e cognitive e deve poter essere trasformata durante l'ontogenesi. Come si vede, il modello cognitivista proposto da Foulkes è interessato non tanto a che cosa viene sognato e al significato del sogno, quanto piuttosto a come il sogno si forma e si organizza. Il punto centrale dell'ipotesi di Foulkes consiste nel rifiuto dell'idea che il sogno sia programmato dall'alto allo scopo di veicolare un messaggio definito e alterato, ipotesi, questa, cara alla psicoanalisi. Secondo questo modello cognitivista, l'elaborazione onirica necessita che siano soddisfatte alcune condizioni: a) l'attivazione fisiologica del cervello, la cui attività desincronizzata (come nel sonno REM) può costituire la condizione ideale per la riattivazione della memoria; b) una maturazione sufficiente delle strutture che presiedono alla organizzazione simbolica dell'esperienza in stati coscienti; c) una possibilità per il cervello di creare nel sogno un'esperienza multimediale simile a quella della veglia con la capacità di incorporare degli stimoli. E’ in linea con questo modello cognitivista l'ipotesi proposta recentemente da Llinas e Paré (1991) secondo cui il sonno REM può essere interpretato come uno stato di attenzione modificato, in cui l'attenzione è distolta dall'input sensoriale ed è diretta ai ricordi. Questi autori sostengono che l'attività onirica può essere essenzialmente considerata uno stato di iper-attenzione simile, per molti versi, alla veglia. Il presupposto fondamentale è che i sogni avvengano durante la desincronizzazione EEG, e questo rende il sogno e la veglia stati paragonabili. E’ evidente che l'ipotesi di Llinas e Paré e il modello cognitivista di Foulkes sono valorizzati dall'ipotesi dicotomica (REM/non-REM) secondo la quale l'attività più propriamente onirica avviene durante il sonno REM, con gli eventi tonici (desincronizzazione EEG) e fasici (movimenti oculari e onde PGO) che lo contraddistinguono. Il contributo di Antrobus (1986) presenta un certo interesse poiché si caratterizza come un modello neurocognitivo che trova i suoi fondamenti neurofisiologici nel modello di attivazione-sintesi di Hobson e McCarley. Per Antrobus, il sogno necessita di un'attivazione corticale e avviene in virtù di una sintesi che consiste in un legame neurocognitivo specifico tra attivazione corticale e organizzazione cognitiva (Cavallero, 1991). Antrobus propone l'esistenza nel sogno, a livello cognitivo, di tre moduli: il modulo di riconoscimento, che riguarda i processi percettivi primari che elaborano l'informazione derivante dalla sensorialità; il modulo associativo, che riunisce e integra questi processi percettivi; il modulo di esecuzione motoria, che programma le risposte motorie dell'organismo. In veglia si avrebbe la prevalenza del primo e del terzo modulo, mentre in sonno REM prevarrebbe il modulo associativo con l'attivazione corticale e l'organizzazione dei processi del sogno. I modelli cognitivisti sottolineano anche un altro aspetto importante dell'attività onirica: le sue analogie e similarità con il linguaggio, nel senso che le leggi biologiche e psicologiche della ontogenesi che governano lo sviluppo e la produzione del linguaggio sono le stesse di quelle coinvolte nella organizzazione, rappresentazione e narrazione di sogni. L'ipotesi avanzata dai cognitivisti è che il sistema organizzatore del sogno (nei suoi aspetti narrativi e rappresentazionali) sia lo stesso che organizza il linguaggio (nei suoi aspetti sintattici e semantici). A favore di questa ipotesi sono stati descritti pazienti con disordini afasici, i quali presentavano anche un disturbo dei processi del sogno (Epstein e Simmons, 1983). A questa osservazione aggiungerei quella più recente di Mark Solms (1995), in cui i disturbi del sogno si presentavano legati essenzialmente a lesioni delle aree parietali e frontali, ovvero ad aree dell'emisfero sinistro che presiedono anche alla organizzazione semantica e sintattica del linguaggio. In conclusione di questo capitolo, vorrei sottolineare in che modo l'attività onirica che compare nel sonno si pone come processo che attiva un interesse interdisciplinare da parte dei neurobiologi, degli psicologi sperimentali e dei cognitivisti, oltre che degli psicoanalisti. Dirò subito che nessuna di queste discipline può rivendicare un diritto esclusivo relativamente agli eventi mentali che si verificano nelle diverse «cornici biologiche» prodotte dai diversi stadi del sonno. La nostra conoscenza dell'attività onirica e dei suoi correlati biologici, in particolare dei processi che organizzano il sogno e il significato di questa esperienza, dipende essenzialmente dall'approccio e dal setting adatti per investigarlo. La neurobiologia (nei suoi aspetti neurofisiologici, neurochimici e biologico-molecolari) può fornire preziose informazioni sui meccanismi di produzione e mantenimento delle varie fasi del sonno e sui principali trasmettitori e circuiti cerebrali coinvolti nelle diverse fasi in rapporto alla veglia. Interessante a questo riguardo l'idea di Llinas e Paré (1991) che il sistema talamo-corticale sia in definitiva responsabile della generazione della coscienza e sia modulato dalla corteccia cerebrale, essendo attivato quando l'individuo è in stato di veglia dall'input sensoriale, e quando è addormentato da circuiti che mantengono i ricordi. Comunque le si consideri, le fasi di sonno costituiscono delle preziose cornici all'interno delle quali l'attività mentale può organizzarsi come attività onirica più o meno articolata e complessa. La psicologia sperimentale collega i diversi stadi del sonno con le diverse forme narrative e i diversi aspetti del sogno (lunghezza, frequenza della comparsa di parole, numero di parole e suo rapporto con il grado di bizzarria del sogno). La psicologia cognitivista è interessata a come si formano i sogni e suggerisce ipotesi relative ai processi che conducono all'elaborazione delle informazioni sensoriali, all'attivazione della memoria a lungo termine, alla organizzazione del pensiero nel sogno e alla sua narrazione. La psicoanalisi, di cui ci occuperemo nel prossimo capitolo, studia il lavoro della mente durante il sogno ed è in grado di attribuire un significato ai sogni in quanto può contestualizzarli nell'ambito di una relazione. Comunque la si consideri, non possiamo dimenticare che l'attività onirica è un'esperienza affettivo-cognitiva specifica per ogni individuo, costruita sulla sua storia affettiva personale. Il sonno, d'altra parte, con le sue varie fasi di sincronizzazione e desincronizzazione, è un processo non-specifico collegato a condizioni omeotermiche, sostanzialmente identiche per tutti gli individui appartenenti alla stessa specie. L'attività onirica, quindi, anche se è una funzione del sonno, non può essere confusa tout court con le strutture biologiche che producono i diversi stati del sonno. Nonostante il grande sviluppo delle neuroscienze, infatti, non conosciamo ancora le relazioni causali tra gli eventi biologici tipici delle varie fasi di sonno e l'attività mentale che si sviluppa all'interno di ogni fase. Sappiamo che la mente lavora durante il sonno, generando un'attività metaforica e simbolica, ma essa non è chiaramente sullo stesso livello epistemologico dell'attività dei neuroni cerebrali. Dobbiamo quindi affrontare la questione della relazione tra l'attività onirica e il sonno suggerendo un tipo di dualismo epistemologico, in cui la mente si pone ad un livello diverso, anche se ad esso correlato, rispetto al cervello. Quest'ultimo rimane il «referente» per la neurobiologia, mentre la mente è il «referente» per altre discipline (come ad esempio la psicologia cognitivista e la psicoanalisi). Capitolo dodicesimoIL SOGNO: UN PERCORSO DA FREUD AI NOSTRI GIORNINegli anni che vanno dal 1895 al 1900, il pensiero di Freud relativamente alla teoria della mente va incontro ad una profonda trasformazione. Freud abbandona il modello positivista che identificava le funzioni mentali con quelle del cervello e propone un nuovo modo di studiare la mente. L'interpretazione dei sogni è il risultato di questa metamorfosi, che vede Freud (1899b) impegnato nel dare un senso al sogno e un significato all'esperienza del sognare. Il nucleo di questa nuova concezione della mente, che permette un accesso ai misteri del sogno, lo troviamo nel 7° capitolo di L'interpretazione dei sogni, che può essere paragonato ad un albero che fiorisce su radici poste dal Progetto di una psicologia del 1895. Quest'ultimo lavoro rappresenta il tentativo, da parte di Freud, di usare un linguaggio solo in apparenza neurofisiologico, nella realtà profondamente metaforico, per presentare ai suoi colleghi dell'Università di Vienna una concezione della mente innovativa e rivoluzionaria che costituirà le fondamenta della psicoanalisi. In particolare, nel Progetto Freud propone l'operatività di tre grandi sistemi: il sistema φ, quale base della percezione, il sistema ψ, quale base della memoria e dei bisogni istintuali fondamentali, e il sistema ω, collegato al principio di realtà. Il modello che Freud propone nel Progetto è quello di un'attività riflessa di stampo sherringtoniano che parte dalle porte della percezione (φ e, dopo aver attraversato il sistema ψ (dove si organizza come memoria), raggiunge la motricità. Questo è quanto avviene nella veglia, durante la quale il sistema ω controlla che il flusso di energia Qη che parte dalle porte della percezione, arrivi alle soglie della motricità secondo un cammino progressivo. Nel sonno, quando i nostri muscoli sono profondamente paralizzati e la deafferentazione sensoriale ci ha allontanato dalla realtà, il sistema ω non è più quel sapiente semaforo che regola la progressione del flusso dell'energia. L'energia, sotto forma di memoria e desiderio, accumulata nel sistema ψ, deve poter essere liberata per il principio di costanza dell'energia (che Freud aveva mutuato da Bernouilli e che informerà tutto il suo pensiero). Trovando chiuse le porte della motricità, questa energia si rivolgerà allora regressivamente alle porte della percezione, colpendole dall'interno e riattivando attraverso il sistema φ un'antica percezione, questa volta senza oggetti, creando un'allucinazione, è l'allucinazione del sogno, che soddisfa un desiderio rimosso nel sistema ψ poiché il desiderio più intenso e più represso dell'uomo è quello che ha luogo nell'infanzia, l'allucinazione non potrà che riguardare il desiderio infantile rimosso. Nel Progetto si radica dunque la definizione di sogno che Freud non abbandonerà lungo tutta la sua vita: la soddisfazione allucinatoria di un desiderio rimosso nell'infanzia. Nel 7° capitolo di L'interpretazione dei sogni, intitolato Psicologia dei processi onirici, Freud riprende i concetti del Progetto e dà loro una nuova collocazione, rappresentata graficamente nello schema riportato a pagina seguente. A sinistra è posto il sistema della percezione (collegata al sistema φ del Progetto) e in ascissa il sistema ψ, che a sua volta struttura sia le varie forme di memoria (tracce mnestiche Tmn, Tmn') che l'inconscio (Inc.) e il preconscio (Prec.). 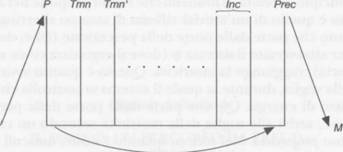
Quest'ultimo è più vicino alla coscienza (da localizzare a destra nella figura). Il sistema inconscio posto dietro al preconscio non può ovviamente arrivare alla coscienza se non passando attraverso quest'ultimo. E’ l'inconscio la forza motrice del sogno, cioè la molla che spinge l'apparato psichico a lavorare. Nel sogno la direzione nella quale si propaga l'energia che dà luogo ad una allucinazione ha un carattere regressivo, in quanto viene a mancare il test di realtà affidato al sistema ω. La regressione permette la trasformazione dei pensieri in immagini (soprattutto visive), per cui i pensieri vengono a conservare un intimo rapporto con i ricordi repressi rimasti inconsci. La nuova situazione facilita anche il trasferimento nell'attualità dei ricordi infantili e la trasformazione del loro contenuto rappresentativo in immagini sensoriali. Tre sono, per Freud, le forme di regressione che avvengono nel sogno: regressione topica che, secondo il modello del Progetto, consiste nell'energia Qη che si sposta dall'inconscio (sistema ψ) verso le porte della percezione (sistema φ) e produce una allucinazione; regressione temporale, che consiste nel trasferimento di un desiderio antico collegato all'infanzia all'attualità della rappresentazione; regressione formale, che permette nel sogno l'uso di espressioni e rappresentazioni molto arcaiche che riguardano il passato ontogenetico e filogenetico dell'individuo. Questa considerazione permette a Freud di pensare al sogno come ad «un tipo di regressione verso le più antiche situazioni del sognatore, una rianimazione della sua infanzia, delle spinte pulsionali in lui allora dominanti, e dei modi espressivi allora disponibili. Dietro quest'infanzia individuale, poi, ci è permesso uno sguardo sull'infanzia filogenetica, lo sviluppo del genere umano, di cui quello del singolo è in verità una ripetizione abbreviata, influenzata dalle circostanze fortuite della vita» (Freud, 1899b, p. 501). E’ con questa idea che Freud pensa ai sogni come rivelatori dell'eredità arcaica dell'uomo, cioè di quanto è psichicamente innato in lui, e pensa alla psicoanalisi come scienza capace di ricostruire le fasi più antiche e più oscure delle origini dell'umanità. Questo concetto sarà ripreso più tardi da Freud (1915a) nel XII Saggio metapsicologico. Nel carteggio Ferenczi-Freud, riportato in questo saggio, l'uomo appare come il protagonista di un dramma filogenetico che inizia nell'epoca glaciale e arriva allo stadio patriarcale della civiltà. Una fantasia filogenetica che si presenta come una variazione sul grande tema già affrontato in Totem e tabù (1912-13): la ontogenesi ripete la filogenesi. Conseguenza di questo assunto è che la memoria umana è il risultato di una memoria della specie trasmessa geneticamente seguendo un percorso tracciato sulle linee del pensiero di Lamarck. La simbolizzazione stessa diventa un patrimonio umano con radici nella filogenesi in cui l'individuo, al di là della propria personale storia ed esperienza, attinge all'esperienza preistorica dell'umanità. Interessante a questo riguardo l'estensione di questo concetto da parte della psicoanalisi post- freudiana. Money-Kyrie (1978) definisce la stessa identificazione proiettiva (modalità con cui opera la mente nella veglia e nel sogno) come una modalità filogenetica di tipo pre-umano e ontogenetica di tipo pre-verbale, con cui gli uomini esprimono i propri sentimenti (ovviamente anche nel sogno). In L'interpretazione dei sogni il sogno appare come determinato da una forza: il desiderio, che tende a realizzarsi allucinatoriamente. Ma da dove proviene questo desiderio che si realizza nel sogno? L'analisi dei nevrotici permette a Freud di affermare che questo desiderio è di origine infantile, rimosso nell'inconscio, dove resta sempre attivo ed immortale. Naturalmente, stimoli durante la veglia possono partecipare come residui diurni alla organizzazione del sogno e avere anche un carattere non necessariamente collegato al desiderio. Tuttavia, per poter partecipare al sogno, essi devono piegarsi al desiderio rimosso e ad esso collegarsi attraverso i processi del lavoro onirico (condensazione, spostamento, simbolizzazione, drammatizzazione) di cui parlerò in seguito. Il percorso del desiderio infantile implica ovviamente per Freud l'attivarsi del processo della memoria, che diventa la funzione cardine intorno alla quale ruota tutto il processo analitico. E’ la memoria, infatti, che viene ad essere la responsabile dell'integrazione tra il presente della relazione e il passato dell'esperienza affettiva, un evento ponte che consente il processo di ricostruzione in senso non necessariamente storico, ma come recupero emotivo degli eventi passati. E’ interessante qui puntualizzare come il sogno rappresenti l'esperienza per eccellenza collegata alla Nachträglichkeit, intesa come riattribuzione di significato ad una esperienza passata, legata ad una ritrascrizione della memoria. Il concetto di Nachträglichkeit freudiana operante nel sogno richiama a sua volta alla mente il concetto di anastilosi degli archeologi, inteso come ricomposizione e ricostruzione di oggetti (ad esempio una colonna) che il tempo, le avversità, i terremoti, hanno abbattuto, frammentato e disperso. E’ chiaro dunque che il sogno, come anastilosi, in quanto permette una ricostruzione del passato si fonda sulla ritrascrizione della memoria, cioè sulla Nachträglichkeit. Il che ci consente di affermare che il lavoro analitico non è soltanto archeologico, come voleva Freud (1937), ma anche storico. Se è vero che il sogno è prodotto dal desiderio infantile rimosso e in quanto tale permette una ricostruzione, appare ovvia l'affermazione di Freud che tutti i sogni sono realizzazioni di desideri. Ma questa convinzione, mantenuta da Freud per tutta la vita, lo ha esposto a continue critiche e obiezioni. Critiche e obiezioni alle quali Freud ha sempre risposto che ogni sogno, per quanto penoso, esprime la realizzazione di un desiderio inconscio che si soddisfa con l'allucinazione, in quanto attività psichica che presenta una identità di percezione, avviene cioè per ripetizione di una percezione più antica collegata alla realizzazione del desiderio. «Infatti il pensiero non è altro che il surrogato del desiderio allucinatorio ed è ovvio che il sogno sia l'appagamento di un desiderio, dato che nulla, all'infuori di un desiderio, è in grado di mettere in moto il nostro apparato psichico» (Freud, 1899b, p. 517). Ogniqualvolta il bisogno si ripresenterà, l'impulso psichico occuperà nuovamente l'immagine di questa percezione nella memoria e la percezione stessa nel ricomparire soddisferà il desiderio. Si tratta dunque di una esperienza in cui avviene la ripetizione di una percezione identica a quella collegata alla realizzazione del desiderio. Esiste tuttavia una funzione che impedisce al desiderio inconscio di farsi strada attraverso il preconscio per emergere nel conscio: la censura. E’ la censura responsabile dell'oblio e i sogni che non si ricordano sono opere riuscite della censura. Quest'ultima rappresenta per Freud la custode della nostra salute mentale. Questa affermazione significa che il sogno è fatto dall'individuo per essere sognato e non necessariamente ricordato. Il sogno assolve così il suo compito. In situazioni emotive particolari, per esempio di tipo traumatico, o nelle condizioni create dal processo analitico in seguito al riattivarsi nel transfert del desiderio infantile rimosso, la censura può abbassare la sua guardia e quindi permettere il ricordo del sogno e la sua narrazione. Ma il sogno come evento primario, collegato alla messa in scena di rappresentazioni affettive, non deve essere confuso con il sogno narrato, che presuppone come processo secondario la trasformazione di queste rappresentazioni in un sistema di significazione linguistica. Su questo punto ritornerò più avanti. Accanto al desiderio rimosso, Freud coglie nel sogno un altro desiderio: quello di continuare a dormire. Di qui l'affermazione di Freud, che tanto ha fatto discutere, che il sogno è «il guardiano del sonno». Oggi ci sono validi motivi per capovolgere questa affermazione, nel senso che il sogno è preparato e custodito dallo stato di sonno (Mancia, 1975, 1987). Nel 7° capitolo di L'interpretazione dei sogni, Freud formula anche un'ipotesi sulla funzione del sonno, oltre che del sogno: come il sogno è l'esaudimento del desiderio inconscio rimosso, così il sonno è l'esaudimento di un desiderio preconscio. Nell'inconscio vige un principio energetico attivo e indistruttibile: in esso nulla finisce, nulla è passato, nulla è dimenticato. In esso vive un'energia immanente che segna il nostro destino di uomini. Un concetto di inconscio, dunque, in cui vigono leggi speciali e dove, accanto alla logica aristotelica, può presentarsi un'altra logica che non rispetta il principio di non-contraddizione (la bi-logica di cui ci ha parlato Matte Bianco, 1975). Tra gli altri compiti, nell'inconscio viene affrontato anche quello di liberare l'energia collegata al desiderio e produrre il sogno. Per questo il processo del sogno è brusco, anche se richiede uno sviluppo lento per il processo di trasformazione, deformazione e distorsione cui va incontro fin dall'inizio. A questo punto Freud si pone il problema del lavoro che la mente compie durante il sogno e si domanda: quali trasformazioni hanno subito i pensieri latenti del sogno (cioè le rappresentazioni primarie) per organizzare il sogno manifesto che ricordiamo al risveglio? Attraverso quali vie la mente ha potuto compiere questa trasformazione? E, infine, qual è la provenienza del materiale che dovrà essere elaborato nel sogno? Freud risponde a queste domande nel 6° capitolo di L'interpretazione dei sogni e suggerisce che varie sono le trasformazioni cui va incontro il sogno: condensazione, spostamento, rappresentazione, simbolizzazione e drammatizzazione. Il sogno manifesto, infatti, appare spesso ridotto, povero, laconico, se paragonato alla ricchezza delle idee che lo alimentano. E’ come se le diverse rappresentazioni del sogno si condensassero l'una sull'altra e contribuissero a conferire al sogno quei caratteri di estraneità, bizzarria e alienità tipici dell'esperienza onirica. Siamo nell'ambito della operazione di condensazione che la mente fa, un processo che avviene per omissione di elementi, che produce delle lacune nel sogno, oppure per una ripetizione di elementi che caratterizza la sovradeterminazione del sogno. Anche questa operazione favorisce la formazione di situazioni assurde e bizzarre. Al lavoro di condensazione si unisce nel sogno quello di spostamento, per cui i contenuti del sogno si dispongono intorno ad elementi altri rispetto ai pensieri del sogno. Ne consegue che alcuni aspetti essenziali del sogno vengono trattati come se avessero scarso valore e al loro posto vengono trasferiti elementi che hanno realmente uno scarso valore per i pensieri del sogno. Lo spostamento riguarda anche gli affetti con cui vengono investiti gli oggetti del sogno oppure il ruolo di determinati personaggi. Ma forse lo spostamento più sottile che partecipa alla distorsione e al camuffamento del sogno nella sua narrazione è quello collegato alla catena verbale associativa, per cui si assiste ad uno scambio linguistico in cui un sintagma sta per un altro. Di questo scambio linguistico si avvantaggia anche la condensazione e l'intero lavoro onirico che, come processo secondario, si fonda su una trasformazione linguistica delle rappresentazioni. Freud, infatti, dice che nel sogno le parole, in quanto ambigue, permettono l'espressione di più pensieri, come un significante dai molteplici significati, un crocevia di significazioni di molteplici rappresentazioni predestinate dunque a una molteplicità di sensi e quindi preziosi strumenti di condensazione, spostamento, distorsione, travestimento del sogno. Il risultato di questo processo è un'accentuazione dell'opera di retorica del sogno, cioè di divergenza tra contenuto manifesto e pensiero latente. Rientra in questo delicato lavoro onirico, che porta alla costruzione della retorica del sogno, il processo della simbolizzazione, intesa come uso di oggetti che stanno al posto di altri oggetti che rappresentano i veri pensieri del sogno. Questo processo costituisce un lavoro di trasformazione delle stesse rappresentazioni affettive, che vengono ad acquisire significati simbolici. Sappiamo da Freud, tuttavia, che il simbolismo non appartiene soltanto al sogno: lo ritroviamo nei miti, nei proverbi e nelle storie popolari. Nel sogno, però, il simbolo acquisisce un significato molto privato collegato alla storia affettiva del soggetto e al contesto delle sue relazioni. Freud non nasconde che può esistere anche un aspetto genetico della simbolizzazione, suggerendo che ciò che oggi è legato simbolicamente poteva un tempo lontano rappresentare una identità concettuale e linguistica. In questa linea, il simbolo può essere considerato come un possibile residuo di quella passata identità che si collega all'inizio della cultura del genere umano e, nel singolo uomo, all'inizio della sua stessa vita di relazione. Freud si chiede se, nell'ambito di un incontro analitico, gli elementi del sogno debbano essere interpretati storicamente (come reminiscenze) oppure simbolicamente, con un riferimento cioè ad oggetti uguali per tutti, metastorici rispetto alla storia dell'individuo, o ancora partendo dal dono della parola, riferendosi cioè alla narrazione del sogno, alla sua musicalità e agli aspetti formali del racconto. Freud fa un collegamento, infatti, tra questo aspetto formale della narrazione e la poesia, associando il linguaggio del sogno a quello poetico. Strettamente legato alla simbolizzazione è il processo di drammatizzazione del sogno, che ci permette di vedere il sogno come una pièce teatrale in cui i singoli personaggi e le singole parti che essi rappresentano sono uniti tra loro da vari rapporti logici (aristotelici e non). Una messa in scena di rappresentazioni che la mente compie nel sogno attraverso un'operazione trasformativa delle singole rappresentazioni (sensoriali, percettive, fino a conferire loro un profondo significato simbolico) cui vengono ancorati determinati affetti. Un'operazione, questa, che presenta delle analogie con l'operazione che durante la veglia la mente compie nel trasformare le rappresentazioni affettive nei grandi sistemi di significazione (iconico, plastico, musicale, linguistico). Ciò conferma le analogie tra pensiero della veglia e pensiero del sogno, con la differenza che la messa in scena di rappresentazioni simboliche nel sogno resta un evento primario (nella sua essenza inconoscibile) che è possibile conoscere solo attraverso il processo secondario della narrazione. La scena primaria del sogno è il vero «nutrimento della mente», l'esperienza che si presenta come necessità per la nostra mente, il processo primario che può, in determinate circostanze, andare incontro a una narrazione, la quale tuttavia comporta una deformazione e una interpretazione. Il processo secondario, che caratterizza la narrazione del sogno, avviene quando con il pensiero e il linguaggio interrompiamo e fissiamo la messa in scena del sogno passando da un livello di realtà (quello primario del sogno) ad un altro (quello della narrazione). In analisi è possibile un ulteriore lavoro elaborativo del sogno, che partecipa alla integrazione dei suoi diversi livelli di realtà e permette di contestualizzarli dando loro un senso. Freud afferma che, diversamente dal teatro, il sogno presenta scene più complesse in quanto più eventi possono essere rappresentati simultaneamente in un'unica situazione. Questa simultaneità unifica un materiale eterogeneo in un unico avvenimento dando un senso logico al sogno. Ne risulta un qualcosa di paragonabile all'opera di un pittore che rappresenta numerosi personaggi in un unico quadro (in questo concetto è implicito quello di un teatro in cui gli attori sono in relazione tra di loro [la dimensione intrapsichica del sogno] e con i vari spettatori [la sua dimensione interpersonale e intersoggettiva] ). Parlando di sogno, Freud introduce un concetto fondamentale per l'intera teoria psicoanalitica: quello di identificazione. Quest'ultima è la base della rappresentazione che permette di eludere la censura ma, nello stesso tempo, in quanto operazione di camuffamento, soddisfa le esigenze della stessa censura. Freud non parla in questo contesto di identificazione proiettiva, ma va molto vicino a questo concetto quando scrive che «là dove nel contenuto onirico non compare il mio Io, ma soltanto una persona estranea, posso tranquillamente supporre che il mio io è celato per identificazione dietro quella persona [...] Nel sogno posso dunque raffigurare il mio Io, in modi diversi, ora direttamente, ora per mezzo dell'identificazione con persone estranee» (1899b, p. 297). Il lavoro onirico è comunque permeato di affettività e il sogno nelle sue varie dimensioni (intrapsichica e interpersonale) non può esprimere altro che affetti. Gli affetti presenti nel sogno non sono dissimili né hanno meno valore rispetto a quelli della veglia. Essi si collocano nell'infanzia e nelle prime esperienze del bambino con la madre e la coppia dei genitori. Nel Supplemento metapsicologico alla teoria del sogno (1915b), Freud va persino oltre l'infanzia e afferma che il sonno può rappresentare una riattivazione della vita intrauterina e che i sogni sono assolutamente egoistici in quanto la parte del protagonista nel sogno è sempre del sognatore. Un'affermazione che si collega al concetto di narcisismo primario proposto da Freud anche per lo stato di sonno in cui i pensieri si trasformano in immagini visive e le rappresentazioni di parole vengono ricondotte, con un processo regressivo, alle rappresentazioni di cosa. Come dire che i sistemi di significazione vengono ricondotti ai sistemi di rappresentazione e il linguaggio viene sostituito dalle immagini visive. E la regressione topica (quella formulata nel Progetto) che permette al sognatore di allucinare il contenuto onirico e, come tale, credere alla realtà dell'appagamento del proprio desiderio. Freud riprende il discorso sul sogno in Introduzione alla psicoanalisi (1915-17), soffermandosi sui sogni infantili, di cui sottolinea la chiarezza e l'assenza di deformazione onirica per cui nel bambino il lavoro di retorica è ridotto. Ne consegue una riduzione della distanza tra sogno manifesto e sogno latente che fa sì che il sogno si avvicini ad una operazione che potremmo definire di tipo allegorico, in quanto permette di cogliere del sogno direttamente il significato letterale (vedi, a questo riguardo, Gerolamo Cardano, 1989, 1993). Anche per il bambino il sogno rappresenta l'appagamento di un desiderio, ad esempio collegato ad una esperienza diurna. La mente infantile, però, deve essere in grado per sognare di compiere una elaborazione simbolica, anche se gli eventi che sono rappresentati simbolicamente nel sogno sono pochi ed essenziali: il corpo umano nel suo insieme, i genitori, i figli, i fratelli, la nascita, la morte, la sessualità. Pur affermando che esistono oggetti-simbolo che permetterebbero di interpretare un sogno anche senza l'aiuto del sognatore e delle sue associazioni libere, Freud precisa che non è possibile fornire un'interpretazione basata sulla sola conoscenza-simbolo. Questa precisazione acquista una notevole importanza perché ci consente di affermare che il lavoro di Freud sul simbolo onirico è collegato al sognatore, alle sue fantasie e alla sua storia e, in particolare, al contesto relazionale ed emotivo in cui i simboli compaiono nel sogno. Inoltre, viene valorizzato da Freud il ruolo delle associazioni libere nel processo di decodificazione del sogno e in quello di costruzione di un ponte tra la vita inconscia del sogno e la vita inconscia della veglia. All'interno di questa cornice, una possibile obiezione turba Freud: che la suggestione possa avere una influenza decisiva nella produzione dei sogni da parte del paziente. Ammette così che quanto l'analista dice al paziente può essere da questi inglobato nel sogno come residuo diurno, ma resta convinto che il lavoro onirico inconscio è sottratto ad ogni influsso esterno. La preoccupazione di una possibile suggestione ha impedito a Freud di accettare il fatto che i sogni del paziente sono di fatto influenzati dalle interpretazioni del suo analista, in quanto il sogno è il rivelatore più accurato della temperatura transferale in quel fuggevole e unico momento della relazione analitica. Ma Freud, all'epoca in cui elaborava la sua teoria dei sogni, non aveva ancora scoperto le potenzialità del transfert, né la sua influenza sulla costruzione del sogno. A quell'epoca Freud considerava ancora il transfert un disturbo nella relazione: solo con il caso di Dora gli si rivelerà per la prima volta il collegamento, nel sogno, tra lui- analista e il signor K-padre di Dora. Freud era piuttosto alla ricerca, nel sogno e nelle associazioni, di elementi rimossi che gli permettessero una ricostruzione di un passato essenzialmente storico degli eventi traumatici del paziente che potevano aver causato la sua nevrosi; quindi è attraverso il sogno che Freud riproponeva la riscrittura di una autobiografia il più fedele possibile alla storia reale del paziente. Non era stato ancora precisato il ruolo del sogno nel processo di rappresentazione del transfert nel suo immediato presente. Ciò permetterà a Freud di affidare il lavoro ricostruttivo alla sola memoria storica e agli eventi del passato che riemergeranno nella relazione, anche se in Ricordi di copertura (1899a) aveva messo in dubbio che noi abbiamo ricordi della nostra infanzia o non piuttosto costruiti sulla nostra infanzia. L'ambiguità riguardo alla memoria storica che opera nel sogno sembra permeare tutta l'opera di Freud fino al 1937, anno in cui, con Costruzioni nell'analisi, ritorna al passato che sopravvive nel presente quale base della relazione analitica e del lavoro di costruzione del materiale dimenticato a partire dalle tracce che questo materiale ha lasciato dietro di sé. In altra sede (Mancia, 1990) ho cercato di dimostrare come Freud, in questo lavoro, usi costruzione e ricostruzione come intercambiabili sinonimi. Fino alle nuove lezioni del 1932, Freud confermerà l'importanza della teoria dei sogni per la psicoanalisi, che sarà vista sempre più come processo di conoscenza del profondo, con una funzione che dalla terapia di nevrosi si estende alla antropologia. Nelle nuove lezioni del 1932 Freud rifonda la sua teoria del sogno: il lavoro onirico crea una distanza tra contenuto manifesto e pensiero latente; chi fornisce l'energia per questo lavoro è l'impulso inconscio (con il desiderio ivi rimosso). Questo moto pul- sionale tende al soddisfacimento, ma poiché siamo paralizzati nel sonno, esso si soddisfa allucinatoriamente attraverso le porte della percezione. Sono passati trentasette anni dal lontano 1895, ma lo schema iniziale con cui nel Progetto Freud elaborava la sua teoria del sogno non è sostanzialmente cambiato: il sogno resta un evento che permette al desiderio inconscio di soddisfarsi allucinatoriamente, anche se esistono diverse categorie di sogni: di desiderio, d'angoscia, di punizione. Questi ultimi sono anch'essi appagamenti di un desiderio, che però è critico o punitivo per l'Io. E il punitore è il Super-io, l'istanza di derivazione inconscia che Freud aveva introdotto nella sua teoria della mente nel 1922. Freud, tuttavia, nel 1932 ammette che la sua teoria dei sogni può essere in parte rivista, almeno riguardo a due condizioni: i sogni che si riferiscono ad una penosa situazione traumatica e quelli che evocano esperienze dolorose dell'infanzia. Anche per Freud, infatti, è difficile conciliare questo carattere penoso del sogno con l'appagamento di un desiderio; così, ammette la possibilità di modificare lievemente la sua definizione: il sogno è un tentativo di appagamento di un desiderio rimosso. La sua teoria sembra salva, ma non potrà resistere ai nuovi significativi sviluppi cui andrà incontro il pensiero psicoanalitico. Nel 1952 Fairbairn critica il modello freudiano del sogno come esaudimento del desiderio rimosso nell'infanzia e propone quello del sogno come rappresentazione della realtà interna del sognatore in tutte le sue più significative sfaccettature. Ma venti anni prima di Fairbairn, Melanie Klein (1932) aveva proposto una nuova teoria della mente e conseguentemente un nuovo modo di leggere il sogno. Essa aveva innanzitutto intuito le profonde analogie esistenti tra il linguaggio del gioco e quello del sogno, in quanto ambedue arcaici e capaci di esprimersi per immagini. Con la teoria degli oggetti interni elaborata dalla Klein, non sarà solo il rimosso la molla inconscia che fa lavorare nel sogno la mente dell'uomo, ma una tensione dinamica tra oggetti interni, rappresentazioni di figure significative dell'infanzia fortemente investite di affetto. Alla Klein va il merito di aver attribuito al sogno una funzione centrale nell'economia della mente: quella di rappresentare le varie fasi cui la mente va incontro nel suo sviluppo, così come possono essere colte nel transfert. Con la teoria degli oggetti interni la Klein ha potuto rappresentare la mente umana come un teatro privato, con personaggi in relazione tra loro, con conflitti e difese da cui scaturisce un significato che è portato nel mondo esterno e nelle relazioni interpersonali. La metafora del teatro privato ci fa vedere il sogno come una messa in scena o presentazione di rappresentazioni cariche di affetti dove gli oggetti interni sono in relazione tra loro (la dimensione intrapsichica del sogno), ma anche con il Sé e gli oggetti della realtà (la dimensione interpersonale e intersoggettiva del sogno). Questa presentazione primaria assolve il suo compito in quanto messa in scena di eventi affettivi, e non è conoscibile se non attraverso una sua narrazione, che tuttavia implica - in quanto evento secondario - una sua trasformazione e interpretazione. La messa in scena di una relazione tra oggetti interni, cioè di quelle rappresentazioni affettive di persone altamente significative per la formazione della personalità dell'individuo, ci permette di elaborare un modello del sogno che potremmo definire teologico, nel senso che si riferisce a quelle figure che hanno acquisito dentro di noi una «sacralità» capace di condizionare i nostri vissuti e comportamenti nel mondo esterno. Può essere interessante ricordare come anche in campo semiotico si afferma che «dietro ad ogni strategia del mondo simbolico esiste, a legittimarlo, una teologia» (Eco, 1981, p. 912): e nessuna manifestazione della mente umana è più simbolica del sogno, che dunque è legittimato dalla teologia interna del sognatore, che il transfert vivifica e riattiva nella rappresentazione. E’ a partire da questa legittimazione che ho cercato una possibile analogia tra sogno e religione, da me intesa nella accezione di re-ligare, «cioè unire in una complessa relazione gli elementi emotivamente più significativi che nel mondo interno dell'individuo hanno acquisito un significato sacrale» (Mancia, 1987, p. 14). Il sogno diventa così capace di rappresentare le cose sacre, cioè quegli oggetti interni che hanno acquisito un significato teologico per l'individuo e che ne caratterizzano lo stile relazionale. È possibile cogliere qui delle interessanti analogie con il pensiero di Mircea Eliade (1948), il quale definisce ierofania quell'evento o fenomeno che manifesta il sacro. E il sogno, per quanto detto, entra di fatto nella categoria delle ierofanie poiché esprime una modalità del sacro (collegato al mondo interno) e un momento della sua storia relazionale. Gli oggetti che compaiono nel sogno, infatti, in virtù della simbolizzazione, dello spostamento e della condensazione, presentano proprietà ierofaniche in quanto da oggetti «profani» (o significanti) acquisiscono nuove dimensioni sacrali (i vari significati del sogno). La teoria degli oggetti interni ha avuto un valore euristico notevole nell'introdurre dei «valori» nella dimensione psicoanalitica della mente, nel conferire una responsabilità all'uomo per lo stato dei suoi oggetti (interni ed esterni), nel dare un «significato nuovo», essenzialmente relazionale (e secondario), al concetto di fantasia inconscia (che la scuola kleiniana ha insistentemente proposto come primario) e quindi al significato più profondo dei sogni. Questo spostamento di vertice ha rappresentato un importante movimento del pensiero psicoanalitico, che ha sostituito il modello energetico pulsionale freudiano fondato sul desiderio e sulla sua rimozione, con un modello relazionale basato sulle più complesse modalità che partecipano alla organizzazione della personalità e del carattere. Con queste premesse, lavorare sul sogno significa anche acquisire conoscenze sullo stato degli oggetti interni, sui loro conflitti e difese. Per questo, il modello teologico della mente ha potuto trasformarsi e arricchirsi conferendo al sogno una ulteriore funzione, studiata da analisti dell'ultima generazione appena scomparsa (Bion, 1962; Money-Kyrie, 1978): quella di essere fondamentale strumento di conoscenza. Il modello proposto si può definire epistemologico e si basa su una felice affermazione di Money-Kyrie (1961), per cui se l'uomo è la sua rappresentazione del mondo e in essa si identifica la sua dimensione conoscitiva, il sogno, in quanto rappresentazione del mondo interno dell'uomo, è esso stesso fonte di conoscenza. Bion (1962) propone per il sogno il compito, affidato alla funzione alfa, di trasformare le esperienze sensoriali, emotive ed emozionali che raggiungono la mente durante la veglia come elementi beta, in forme di pensiero del sogno. Il sogno diventa allora uno strumento con cui la mente elabora le esperienze sensoriali e le trasforma in pensieri. Ciò permette una preziosa continuità alle funzioni mentali nel passare dalla veglia (dominata da fantasie) al sonno (dominato da sogni). Bion capovolge il rapporto tra sogno e inconscio rispetto a quello prospettato da Freud. Censura e resistenze personali nel sogno non sono per Bion il prodotto dell'inconscio, ma strumenti per mezzo dei quali il sogno «crea e differenzia il conscio dall'inconscio» (p. 42). Per il sogno Bion introduce un concetto di grande interesse teorico-clinico: quello di barriera di contatto, una sorta di membrana semipermeabile che permette lo scambio tra conscio e inconscio, ma anche ne differenzia le funzioni nella veglia e nel sonno. La barriera di contatto va vista come espressione di una estrema plasticità della mente nell'ambito del transfert. Infatti, in analisi il sogno permette di attivare un processo in cui la barriera è in continua trasformazione e permette alla coppia analitica di cogliere le varie dimensioni del sogno (quella intrapsichica e quella interpersonale) e di darne diverse interpretazioni. Spesso è proprio grazie a questa plasticità della barriera che è possibile cogliere, nel sogno prima che altrove, le resistenze, le difese, i cambiamenti significativi della temperatura transferale del paziente e della sua relazione con noi. Il sogno contestualizzato, attraverso il transfert, nell'ambito della relazione analitica, definisce la sua dimensione conoscitiva. Questa dimensione è definita come epistemologica in quanto vede la mente svilupparsi sulla base dell'acquisizione di conoscenze su se stessi e sui propri oggetti (interni ed esterni). Ma poiché tale conoscenza è condizionata dal potere e dal valore degli stessi oggetti, possiamo affermare che la funzione conoscitiva della mente è condizionata dalla sua teologia (e dagli affetti che legano questi oggetti «sacri»). Questo aspetto epistemico del sogno pone il problema della necessità che ha l'uomo di sognare perché sognare significa darsi un essenziale strumento di conoscenza di sé e dei propri oggetti, di cui la mente ha bisogno per mobilitarsi e crescere. Produrre conoscenza attraverso il mondo delle rappresentazioni può dunque essere considerata una delle funzioni del sogno. L'aveva intuito Freud ( 1899b) quando paragonava il sogno ad un giornale in un regime dittatoriale: deve uscire ogni notte ma, non potendo dire la verità, è costretto a dirla tra le righe. Lo pensiamo anche noi oggi, solo che per noi il sogno è un giornale che esce ogni notte e deve dire la verità, anche se in forma distorta, per rivelare lo stato affettivo del sognatore e ad un tempo per radiografare lo stato relazionale della coppia in analisi, con riguardo sia alla mente del paziente e ai suoi oggetti che alla mente dell'analista con i suoi affetti personali e controtransferali. In questa linea di pensiero possiamo oggi definire il sogno come una «esperienza reale» che, in quanto rappresentazione del mondo interno del sognatore nel suo immediato presente, esprime il «transfert» in tutta la sua totalità. Con ciò non si vuol negare che il sogno sia anche altro o che assolva ad altre funzioni: ad esempio, quella di comunicare all'analista qualcosa che non può essere comunicato altrimenti, oppure l'esaudimento di un antico desiderio rimosso (come voleva Freud), oppure una premonizione come si pensava nell'antichità (Guidorizzi, 1988), o perfino un agito in seduta, come nel caso - tutt'altro che infrequente - di sogni portati in seduta in grande quantità per riempire difensivamente lo spazio analitico senza la possibilità di essere utilizzati per qualsivoglia costruzione o ricostruzione. Ogni analista ha esperienze dell'uso che il paziente fa del sogno, il suo modo di comunicarlo, il suo selezionare i vari sogni e i vari elementi di uno stesso sogno, le associazioni che può portare al sogno, la disponibilità o meno a lavorare o elaborare un sogno in rapporto anche alle ansie che questo solleva. Quello che comunque va sottolineato è il ruolo attivo e insostituibile del sogno nel processo di drammatizzazione della relazione, teso a costruire un pensiero condiviso dalla coppia. Un processo, cioè, di teatralizzazione degli affetti in gioco nella relazione in quel particolare e fuggevole momento transferale. Il transfert, in questo contesto, è da vedersi come una situazione relazionale totale (Joseph, 1985), trasferita dal passato al presente, come proiezione di una dinamica tra oggetti interni nello spazio della relazione analitica. Tale modalità permette al paziente di rappresentare attraverso il sogno e comunicare con la sua narrazione lo stato attuale dei propri oggetti interni, in relazione all'analista, e il suo collegamento alla sua storia affettiva primaria. All'analista il sogno permetterà di riconoscere le scissioni, le identificazioni, le negazioni, le idealizzazioni, le paure, le difese, le aggressioni, le seduzioni, attivate nel paziente, e di usarle per un lavoro sul sogno. Lavoro fatto di tante cose: certo di interpretazioni, decodificazioni e traduzioni dal manifesto al latente, ma anche, e a volte soprattutto, di esplorazioni, ipotesi, ripensamenti, rielaborazioni, mosse e attese da giocatore di scacchi, tutte con lo scopo di acquisire e far acquisire conoscenze sugli oggetti interni e le loro dinamiche, sulle difese indotte dalle sollecitazioni transferali e sulle azioni rivolte al mondo esterno. Questo complesso lavoro sul sogno è reso possibile dal contesto relazionale (transferale e controtransferale) che partecipa alla organizzazione del sogno che entra in seduta. In questa linea di pensiero, sulla quale si muove la psicoanalisi attuale, possiamo vedere il sogno come un evento che attinge alla vita mentale di entrambi i componenti della coppia analitica, un evento in cui non ci sono solo simboli del paziente che l'analista deve interpretare restando dall'altra parte della barricata, ma in cui il processo di simbolizzazione rappresenta il risultato dell'incontro tra paziente e analista, teso a creare nel sogno un senso nuovo e condiviso (Meitzer, 1984; Ferro, 1992; Nissim Momigliano e Robutti, 1992). Per questo, sebbene sia il paziente a sognare (e occasionalmente anche l'analista), non c'è una sola verità da scoprire in seduta, una verità che appartenga esclusivamente al paziente, bensì una verità che appartiene alla coppia e che permette a quest'ultima di realizzare una sintonizzazione (o dissonanza) affettiva (analoga a quella descritta nella relazione primaria madre/bambino [Stern, 1985]), affinché il paziente possa essere raggiunto dove è, e nella misura per lui sopportabile. La verità che il sogno, ogni sogno, veicola deve poter essere colta dalla coppia nel suo doppio livello: intrapsichico, dove parti del Sé in relazione dinamica tra loro sono identificate con gli oggetti del sogno, e intersoggettivo, dove parti del Sé sono identificate con l'oggetto, l'analista nel transfert. Contestualizzato e ricondotto all'Aie et nunc dell'incontro, il sogno si presenta come l'aiuto più prezioso per cogliere un determinato momento transferale, selezionare gli affetti emergenti e comporre le tessere sparse di un mosaico relazionale, così da produrre una costruzione su cui basare un'ipotesi interpretativa. (E’ il lavoro sull' inconscio presente di cui parlano i Sandler [1984] ). Ma, nello stesso tempo, il sogno permette un recupero e una presentificazione di antiche esperienze cui viene attribuito un nuovo senso: operazione che permette di considerare il sogno come il protagonista più accreditato e l'artefice più affidabile di quella che Freud definisce Nachträglichkeit, intesa come riattribuzione di significato ad una esperienza passata attraverso una ritrascrizione della memoria. Questo è il lavoro sul sogno più propriamente ricostruttivo (Mancia, 1990) che si collega ali' inconscio passato (Sandler e Sandler, 1984). Il lavoro di riattribuzione di senso a esperienze passate è reso possibile, nel sogno, dal recupero della memoria: questa va intesa non tanto come memoria storica, quanto come memoria affettiva ( memories in feelings di kleiniana memoria), legata alla riattivazione di una processualità affettiva (traumatica o meno) che ha caratterizzato le tappe più significative dello sviluppo della mente e della personalità nella doppia funzione di a) immagazzinare le esperienze fatte nell'hic et nunc dell'incontro e permettere, in assenza dell'oggetto, lo sviluppo del pensiero e delle funzioni di contenitore; b) integrare le esperienze passate con quelle presenti, la realtà affettiva attuale con quella dell'infanzia resa attuale dal transfert, e con questo consentire un lavoro ricostruttivo. Il sogno, in virtù della memoria, diventa così un pontifex che, collegando e saldando le esperienze attuali (presenti anche come residui diurni) con quelle di un tempo, fa da ponte tra inconscio passato e inconscio presente dando unità all'esperienza inconscia e permettendo una sua storicizzazione. Così intesa, la memoria che opera nel sogno, e che comunque è attivata dal sogno, diventa parte integrante del transfert e del lavoro costruttivo e ricostruttivo che sul transfert la coppia analitica compie. Complesse sono le funzioni del sogno nel corso di un processo analitico. Sul piano più strettamente clinico, possiamo dire che Freud non ha sufficientemente sottolineato la funzione del sogno nel working through dell'analisi, e la sua trasformazione nel corso del processo. Questa appare oggi centrale alla nostra esperienza di analisti. I sogni, infatti, subiscono continue trasformazioni in rapporto alle trasformazioni cui va incontro il paziente nel corso del suo lavoro con noi. Nella mia esperienza, ad esempio, molti sogni, soprattutto quelli che risalgono al primo periodo dell'analisi, presentano nelle separazioni componenti fortemente persecutorie, al punto da considerarle una «costante psichica» di natura difensiva, dal momento che la mente umana preferisce, nelle separazioni più dolorose, un oggetto presente, per quanto persecutorio, ad un oggetto assente. I sogni, dunque, cambiano in analisi quando il paziente va incontro a qualche trasformazione. E’ vero che le variabili affettive rappresentate dal sogno sono così numerose da rendere impossibile proporre rigide categorie, in quanto anche i sogni più disperatamente evacuativi, per il fatto stesso di essere portati in seduta, acquistano una potenzialità elaborativa. Comunque, possiamo vedere che eventi fondamentali dell'incontro, come le separazioni, le paure, le frustrazioni, la dipendenza, le umiliazioni, l'asimmetria della relazione, portano all'organizzazione di sogni che rappresentano le difese rispetto a questi dolorosi sentimenti attivati dal transfert. A mano a mano che il lavoro procede e il paziente, pur mantenendo una chiara oscillazione tra posizione schizo-paranoide e posizione depressiva, riesce a trasformare questi sentimenti e si avvicina alla posizione depressiva, la funzione simbolica del sogno diventa sempre più ricca, ma il lavoro sul sogno e il suo uso diventano sempre più facili sia da parte dell'analista che del paziente. Un lavoro costante sui sogni nel corso di un'analisi porta, parallelamente allo sviluppo del processo, ad un attenuarsi della censura. E poiché, come diceva Freud (1899b), è la censura la causa della deformazione del sogno, è comprensibile come una sua attenuazione riduca lo scarto fra contenuto latente e contenuto manifesto, creando una rappresentazione in cui i personaggi e i loro ruoli sono uniti tra loro da rapporti logici, e che quindi appare come compiuta e organica allegoria, come «un testo (visivo o verbale) che proceda per articolazione di immagini che potrebbero essere interpretate nel loro senso letterale» (Eco, 1981, p. 891). Ciò comporta una relativa maggiore facilità di lettura del sogno, che può arrivare a suggerire interpretazioni che tengano in gran conto il contenuto manifesto. Esso può infatti rappresentare direttamente i sentimenti e le difese che il paziente vive in quello specifico momento transferale. Complesse sono dunque le funzioni del sogno nel corso di un processo analitico. Esso può rivelare sentimenti che il paziente non è in grado di comunicare altrimenti, ad esempio la gelosia, l'invidia, l'intolleranza alla asimmetria della relazione analitica, la paura della dipendenza e della separazione. Ma il sogno, a volte, può essere il rivelatore più efficace di una situazione di stallo passata inosservata all'analista e al paziente, oppure può permetterci di capire la natura del rapporto che il paziente ha in quel momento transferale con i propri oggetti interni proiettati nello spazio analitico e nella figura dell'analista. Conseguentemente, il sogno pone problemi relativi alla responsabilità rispetto a questa relazione che il paziente ha con i propri oggetti interni proiettati. Il sogno può anche essere la rappresentazione privilegiata per situazioni masturbato rie criptiche che Meltzer (1966) definisce di tipo anale e che il paziente non è in grado di comunicare altro che attraverso il sogno. Per ultimo, ma certo non per importanza, la funzione del sogno può in analisi essere quella di prevenire gli «agiti». Un buon lavoro con il paziente, allora, permetterà di aumentare la sua produzione onirica e il suo insight e, parallelamente, di ridurre l'intensità dei suoi agiti in un rapporto à bascule che ci permette, come analisti, di conoscere la temperatura del transfert del paziente e avanzare qualche ipotesi sul possibile sviluppo e conclusione della relazione con lui.
|