Parte prima |
|
A mia madre e a mio padre Je donne une œuvre subjective ici, œuvre cependant qui tend de toutes ses forces vers l'objectivité. E. MINKOWSKI Capitolo primoLe basi fenomenologico-esistenziali di una scienza delle personeSi designa col termine «schizoide» un individuo la cui totalità di esperienza personale è scissa a due livelli principali: nei rapporti con l'ambiente, e nei rapporti con se stesso. Da una parte questo individuo non è capace di sentirsi insieme con gli altri, né di partecipare al mondo che lo circonda, ma, al contrario, si sente disperatamente solo e isolato; dall'altra non si sente una persona completa e unitaria, bensì si sente «diviso» in vari modi: per esempio vive se stesso come una mente e un corpo uniti fra loro da legami incerti, oppure come due o più persone distinte. In questo libro si tenterà di descrivere e comprendere alcune persone schizoidi e schizofreniche da un punto di vista fenomenologico-esistenziale. Prima però è necessario mettere a confronto questo punto di vista e quello della psichiatria clinica e della psicopatologia ufficiali. La fenomenologia esistenziale si propone di precisare la natura dell'esperienza che si ha del proprio ambiente e di se stessi. Non si tratta tanto di descrivere i diversi oggetti particolari di questa esperienza, quanto di porre tutte le varie esperienze singole entro il contesto di un globale «essere-nel-mondo». Le cose dette e fatte da uno schizofrenico sono destinate a restare, essenzialmente, assurde e inspiegabili se non si comprende il loro contesto esistenziale. Come tenterò di mostrare descrivendo un modo particolare di impazzire esiste una transizione comprensibile da un modo schizoide (ma sano) a un modo psicotico di essere nel mondo. Naturalmente, pur conservando i termini «schizoide» e «schizofrenico» per indicare rispettivamente lo stato sano e lo stato psicotico, non li userò nel loro significato clinico consueto, bensì in senso fenomenologico ed esistenziale. In clinica il campo di osservazione è ristretto, e riguarda solo alcuni dei possibili modi di essere schizoide, o di diventare schizofrenico partendo da uno stato schizoide. Nelle pagine che seguono si intende invece dimostrare, attraverso un resoconto delle esperienze vissute da alcuni individui, che i metodi della psichiatria clinica e della psicopatologia, al loro stato attuale, sono inadeguati per comprendere tali esperienze, e che il metodo fenomenologico- esistenziale si rende necessario per metterne in luce tutto il significato umano. In tutto il libro si punterà il più direttamente possibile sui pazienti, riducendo al minimo ogni accenno alle questioni anamnestiche e teorico-pratiche che si presentano in psichiatria e in psicoanalisi. La forma particolare di tragedia umana che ci troveremo davanti non è mai stata presentata con sufficiente chiarezza: per questa ragione si è ritenuto che l'aspetto puramente descrittivo del compito dovesse avere la precedenza su ogni altra considerazione. Il presente capitolo si limita dunque a formulare il più brevemente possibile gli orientamenti fondamentali del volume, al fine di evitare disastrosi equivoci, ed è rivolto a due categorie di lettori: da una parte a quegli psichiatri che, pur avendo grande familiarità col «caso» clinico, non siano avvezzi a vederlo in quanto persona, come faremo qui; dall'altra si rivolge a coloro che conoscono persone di questo tipo, o che hanno verso di esse un atteggiamento di simpatia umana, ma che non le hanno incontrate in situazione clinica. Inevitabilmente il capitolo lascerà in qualche modo insoddisfatte entrambe le categorie. Una difficoltà di fondo si incontra già all'inizio: come può uno psichiatra considerare direttamente il paziente per descriverlo, se il vocabolario psichiatrico a sua disposizione serve solo per tenerlo a distanza? Come si può mostrare il significato umano generale posseduto dallo stato del paziente, se le parole che si debbono usare sono state inventate apposta per isolare e circoscrivere in una entità clinica particolare il senso della vita del paziente? L'insoddisfazione nei riguardi della terminologia psichiatrica e psicoanalitica è comune, anche fra coloro che debbono farne uso; ed è diffusa opinione che i termini della psichiatria e della psicoanalisi servano solo ad esprimere incompiutamente le cose che invece si vogliono «significare realmente». Ma non è che una forma di autoinganno presumere di poter dire una cosa e pensarne un'altra. Converrà quindi cominciare prendendo in considerazione alcuni dei termini di uso corrente. Per dirla con Wittgenstein, il pensiero è il linguaggio; e un vocabolario tecnico non è altro che un linguaggio entro un linguaggio. Un esame di questo vocabolario tecnico sarà dunque un tentativo di accostarsi a quella realtà che le parole possono scoprire ma anche nascondere. L'obiezione più seria che si può fare al vocabolario tecnico attualmente usato per descrivere i pazienti psichiatrici è che esso consiste di parole il cui effetto è di dividere l'uomo, in modo analogo alle fratture esistenziali che qui vogliamo descrivere. Ma di queste fratture esistenziali non si può dare un resoconto adeguato se non si parte dal concetto di un tutto unitario, e nessun concetto simile esiste, né potrebbe essere espresso, entro il sistema linguistico in uso in psichiatria o in psicoanalisi. I termini del vocabolario tecnico corrente, infatti, hanno l'una o l'altra di queste proprietà: o si riferiscono ad un uomo in isolamento rispetto agli altri e al mondo (cioè ad una entità la cui qualità essenziale non è quella di essere in rapporto con gli altri e col mondo), o si riferiscono ad aspetti falsamente elevati a sostanza di questa entità isolata. Termini come mente e corpo, psiche e soma, psicologico e fisiologico; o come personalità, l'io, l'organismo, sono delle astrazioni. Invece del legame originale di Io e Tu, si prende un singolo uomo isolato, e si concettua- lizzano i suoi vari aspetti: l'Io, il Super-Io, l'Es. L'Altro diviene un oggetto, interno od esterno, oppure interno ed esterno assieme. Com'è possibile parlare veramente di un rapporto fra me e te servendosi del concetto di interazione fra un apparato mentale e un altro? E anzi, come si può spiegare cosa significa nascondere qualcosa a se stessi, o ingannare se stessi, parlando di barriere interposte fra le varie parti di un apparato mentale? Questa difficoltà non si presenta solo nella metapsicologia freudiana classica, ma in ogni teoria che parta dall'uomo, o da una sua parte, astraendolo dal suo rapporto con gli altri nel suo mondo personale. Sappiamo tutti per esperienza diretta che possiamo essere noi stessi soltanto nel nostro mondo personale e attraverso di esso, e che in un certo senso il «nostro» mondo perirà con noi, anche se «il» mondo continuerà ad esistere senza di noi. E soltanto il pensiero esistenziale ha tentato di esprimere l'esperienza originale che si ha di se stessi in rapporto agli altri, nel proprio mondo personale, con un termine che rifletta adeguatamente questa globalità: nel linguaggio esistenziale la cosa concreta è l'esistenza di un uomo, il suo essere-nel-mondo. A meno che non si parta dal concetto di uomo in relazione ad altri uomini, e fin dal principio «in» un mondo; a meno che non si avverta che l'uomo non esiste senza il «suo» mondo, né questo può esistere senza di lui, si è destinati a iniziare lo studio delle persone schizoidi e schizofreniche con una frattura, verbale e concettuale, corrispondente a quella che esiste nella globalità dell'essere-nel-mondo dello schizoide. Di più: il compito secondario di ricostruire, verbalmente e concettualmente, i vari pezzi e frammenti corrisponderà agli sforzi disperati dello schizofrenico per ricomporre il suo io e il suo mondo disintegrati. In breve, si avrà fra le mani un burattino già rotto in partenza, che nessuna parola composta — psicofisico, psicosomatico, biopsicologico, psicopatologico, psicosociale - può più servire a rimettere insieme. Stando cosi le cose potrà essere molto importante, per comprendere l'esperienza schizoide, vedere quale sia l'origine di questa teoria schizoide. Tenteremo di farlo usando un metodo fenomenologico. L'essere di un uomo (il termine verrà usato d'ora in poi per indicare semplicemente tutto quello che un uomo è) può essere visto da angoli diversi, e l'uno o l'altro aspetto può essere preso come oggetto di studio. In particolare l'uomo può essere visto come una persona o come una cosa. Ma anche la stessa cosa, se osservata da punti di vista diversi, può dare origine a due descrizioni completamente diverse, che a loro volta daranno origine a due teorie completamente diverse: queste due teorie poi potranno portare ad altrettanto diversi modi di agire. È il modo iniziale di vedere una cosa che determina tutte le nostre azioni successive nei suoi confronti. Si consideri la ben nota figura ambigua: 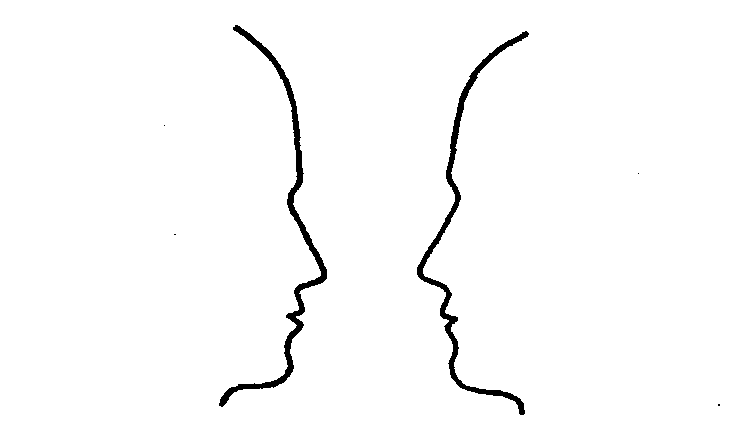
In questa figura ciò che sta sulla carta può essere visto come un vaso, oppure come due profili umani di fronte. Sulla carta non vi sono due cose diverse, ma una sola: eppure, a seconda di come essa ci colpisce, possiamo scorgervi due oggetti diversi. La relazione delle varie parti con il tutto è molto diversa per i due oggetti. Infatti, se dovessimo descrivere uno dei profili visti, descriveremmo, dall'alto al basso, una fronte, un naso, due labbra, un mento, un collo. Avremmo così descritto la stessa linea che, se vista in altro modo, potrebbe essere un lato del vaso: ma non avremmo descritto il lato di un vaso, bensì il profilo di un volto. Se ora tu siedi davanti a me, io posso vederti come un'altra persona come me; ma, senza che tu cambi o faccia niente di nuovo, posso anche vederti come un sistema fisico-chimico complesso, forse dotato di certe caratteristiche individuali ma nondimeno sempre tale. Visto in questo modo tu non sei più una persona, ma un organismo. Nel linguaggio della fenomenologia esistenziale l'altro - visto alternativamente come persona o come organismo - è l'oggetto di atti intenzionali diversi. Non vi è dualismo, nel senso della coesistenza di due essenze o sostanze diverse nell'oggetto (psiche e soma): vi sono due diverse Gestalt di esperienza, persona e organismo. Ma il rapporto che si stabilisce con un organismo è diverso dal rapporto che si ha con una persona. La descrizione dell'altro come organismo è diversa dalla descrizione dell'altro come persona, allo stesso modo che la descrizione del profilo di un vaso è diversa da quella del profilo di un volto. Analogamente una teoria dell'altro come organismo è tutt'altra cosa che una teoria dell'altro come persona. La scienza della persona è lo studio degli esseri umani che parte da un rapporto con l'altro come persona, e che spiega l'altro sempre considerandolo come persona. Per esempio, se si ascolta un'altra persona che sta parlando si possono fare due cose: a) si può studiare l'attività verbale in termini di processi nervosi e del funzionamento dell'apparato vocale; b) si può cercare di capire cosa sta dicendo la persona. Nel secondo caso una spiegazione dell'attività verbale, in termini del nesso generale di quelle modificazioni organiche che si devono necessariamente avere come condizione indispensabile dell'attività stessa, non contribuisce in alcun modo alla comprensione delle cose dette; e viceversa la comprensione delle cose dette non serve per conoscere i processi metabolici nelle cellule nervose dell'individuo che parla. Insomma la comprensione delle cose che l'individuo sta dicendo non può sostituire la spiegazione dei suoi principali processi organici, e viceversa. E ancora una volta, come sempre, non è questione di dualismo di spirito e corpo. Le due spiegazioni (in questo caso l'una personale, l'altra organica, sia del linguaggio, sia di qualunque altra attività umana osservabile) sono la conseguenza di due atti intenzionali iniziali, ciascuno dei quali va in una propria direzione e conduce a risultati suoi propri. Il particolare punto di vista, o atto intenzionale, viene scelto entro il contesto generale di quello che «si cerca» nell'altro: visto come organismo, o visto come persona, un uomo espone all'osservazione di colui che indaga aspetti differenti della sua realtà umana. Entrambi sono legittimi da un punto di vista metodologico, ma bisogna stare molto attenti a non confonderli. L'altro come persona è visto come responsabile, capace di fare delle scelte, in una parola è visto come un agente autonomo. Visto come organismo, tutto quello che in esso avviene può concettualizzarsi a qualsiasi livello di complessità: atomico, molecolare, cellulare, sistemico, organico. Mentre l'attività personale è vista in termini dell'esperienza di quella persona, e delle sue intenzioni, l'attività organica può essere vista solo come la contrazione o la decontrazione di certi muscoli, ecc.: in luogo di interessarsi ad una successione di esperienze, ci si interessa ad una successione di processi. Quindi in un uomo visto come organismo non c'è posto per desideri, timori, speranze o disperazioni in quanto tali. Il fine ultimo delle nostre spiegazioni non riguarda le sue intenzioni nei confronti del suo mondo, ma i quanti di energia in un sistema di energia. Visto come organismo, l'uomo non può essere altro che un complesso di cose, di entità neutre (its): i processi che in ultima analisi lo costituiscono sono processi di cose. Si ha comunemente l'impressione che si potrebbe in qualche modo comprendere meglio una persona, se si potesse tradurre la comprensione personale che si ha di lui nei termini impersonali di una successione, o sistema, di processi di cose o di entità neutre. Anche in assenza di giustificazioni teoriche, c'è sempre una certa tendenza a tradurre l'esperienza personale che si ha dell'altro come persona in una descrizione spersonalizzata. Ciò avviene, in una certa misura, sia usando nella nostra «spiegazione» analogie meccanicistiche, sia usando analogie biologiche. È necessario tener presente che qui non si fa obiezione all'uso delle analogie meccanicistiche o biologiche in quanto tali, e neppure all'atto intenzionale di considerare l'uomo come un meccanismo complesso o come un animale. La nostra tesi è semplicemente che una teoria dell'uomo come persona sia destinata a fallire se si ricade in una descrizione dell'uomo come meccanismo, o come sistema organico di processi di cose; e viceversa. (Cfr. Brierley, 1951). Sembra incredibile che, mentre generalmente le scienze fisiche e biologiche, cioè le scienze dei processi di cose, siano prevalse sulla tendenza a personalizzare il mondo delle cose, o a leggere delle intenzioni umane nel mondo animale, un'autentica scienza delle persone non sia quasi ancora riuscita a nascere a causa della inveterata tendenza a spersonalizzare o reificare le persone. Nelle pagine che seguono ci occuperemo specificatamente di individui che si sentono automi, macchine, parti di meccanismi, persino animali. Queste persone vengono, giustamente, considerate pazze. E perché mai allora non si considera ugualmente pazzesca una teoria che cerca di trasformare delle persone in automi o animali? L'esperienza che si ha di se stessi e degli altri come persone è primaria; essa si valida da sé; la sua esistenza è precedente a tutti i problemi di ordine scientifico o filosofico sulla sua origine o sulle sue possibili spiegazioni. In realtà è molto difficile spiegare il persistere, in tutto il nostro pensiero, di tracce dell'«analogia biologica», come l'ha chiamata MacMurray: «Ci si aspetterebbe - scrive MacMurray ( 1957) - che alla nascita di una psicologia scientifica corrisponda una transizione da una concezione organica ad una concezione personale... dell'unità». In altri termini, ci si aspetterebbe di poter pensare, oltre che sentire, l'uomo individuale, né come una cosa né come un organismo, ma come una persona, e di poter disporre di un modo adatto per esprimere questa forma specificamente personale di unità. Invece non è cosi, e perciò il difficilissimo compito che affronteremo nelle pagine seguenti sarà quello di tentare di spiegare una forma strettamente personale di disintegrazione e spersonalizzazione, in quest'epoca, in cui appartiene ancora all'avvenire la conquista di quella «forma logica attraverso la quale sia possibile concepire in modo coerente l'unità personale» (ibid.). Naturalmente esistono, in psicopatologia, numerose descrizioni di spersonalizzazione e di rottura della personalità. Ma nessuna teoria psicopatologica ha saputo finora eliminare completamente quelle deformazioni della persona che le sue stesse premesse rendono inevitabili, anche laddove si cerca di negare queste premesse. Infatti una psicopatologia che meriti il suo nome deve necessariamente presupporre una «psiche» (un apparato mentale, o struttura endopsichica); e deve presupporre che l'obiettivazione, con o senza la reificazione imposta dal pensare in termini di una «cosa» o di un sistema fittizio, costituisca un corrispondente concettuale adeguato dell'altro come persona in interazione con altre persone. Deve inoltre presupporre che il suo modello concettuale abbia un modo di funzionamento analogo al funzionamento di un organismo in stato di salute, e un modo di funzionamento analogo al funzionamento di un organismo in stato di malattia. Tuttavia, per quanto pregni di analogie parziali possano essere tali confronti, la psicopatologia, per la natura stessa del suo atteggiamento di fondo, si preclude la possibilità di comprendere la disorganizzazione di un paziente come fallimento del tentativo di raggiungere una forma di unità specificamente personale. È un po' come voler ottenere del ghiaccio facendo bollire l'acqua. La stessa esistenza della psicopatologia perpetua quel dualismo che quasi tutti gli psicopatologi vorrebbero evitare perché palesemente falso. Ma esso non può essere evitato entro il sistema di riferimento della psicopatologia, tranne ricadendo in un monismo che riduce un termine all'altro, e che è semplicemente un giro ulteriore in una spirale di falsità. Si può sostenere che non è possibile essere scientifici senza conservare la propria «obiettività». Una scienza genuina dell'esistenza personale deve cercare di essere il meno tendenziosa possibile. Ma la fisica e le altre scienze delle cose devono accordare alla scienza delle persone il diritto di evitare la tendenziosità in modi che non tradiscano la natura del suo campo di studio. Se si ritiene che per evitare di essere tendenziosi occorre essere «oggettivi» nel senso di spersonalizzare la persona che costituisce l'«oggetto» dello studio, e se si cede alla tentazione di fare cosi, si ha l'illusione di essere scientifici. Un procedimento di spersonalizzazione, in una teoria che vuol essere una teoria di persone, è falsa proprio come la spersonalizzazione che lo schizoide opera sugli altri, e in ultima analisi non è meno di questa un atto intenzionale. Pur essendo condotta in nome della scienza, una simile reificazione produce falsa «conoscenza»; è una fallacia, altrettanto patetica quanto la falsa personalizzazione degli oggetti inanimati Purtroppo parole come «personale» e «soggettivo» sono tanto abusate da non aver più il potere di descrivere l'atto genuino di vedere l'altro come persona (se intendiamo indicare questo, dobbiamo infatti tornare a usare il termine «oggettivo»), mentre invece implicano immediatamente l'idea che i propri sentimenti e atteggiamenti vengano confusi con quelli dell'altra persona osservata, in modo da deformarne la percezione. Ed è molto forte il contrasto fra parole ben considerate, come «oggettivo» o «scientifico», e parole mal considerate, come «soggettivo», «intuitivo», e, peggiore di tutte, «mistico». È interessante, per esempio, che davanti alla parola «soggettivo» si incontri spesso l'avverbio «puramente», mentre non si può quasi immaginare di parlare di qualche cosa che sia «puramente» oggettiva. Il maggiore psicopatologo è stato Freud: come un eroe mitologico, egli è disceso agli «inferi», e si è trovato di fronte a terrori agghiaccianti; ma portava con sé la sua teoria, come una testa di Medusa, e con essa li ha trasformati in pietra. Noi, suoi seguaci, abbiamo il vantaggio della conoscenza che egli riportò indietro con sé e ci consegnò. Freud sopravvisse. Tocca a noi vedere se riusciamo a sopravvivere senza far ricorso ad una teoria che è, in qualche misura, uno strumento di difesa. Il rapporto col paziente, come persona o come cosa.Nella fenomenologia esistenziale l'esistenza in questione può essere la propria o quella dell'altro. Se l'altro è un paziente, la fenomenologia esistenziale diventa un tentativo di ricostruzione del suo modo di essere se stesso nel suo mondo: anche se, nel rapporto terapeutico, il centro di osservazione può essere il suo modo di essere con me. I pazienti si presentano allo psichiatra accusando disturbi che vanno dalla difficoltà più particolare («Sono tentato di gettarmi da un aeroplano») alla più generale («Veramente non so perché sono venuto: ma forse ho qualcosa che non va»). Ma al di là di quanto circoscritto o diffuso sia il disturbo inizialmente accusato, si sa che in realtà il paziente porta nella situazione terapeutica, intenzionalmente o no, la sua esistenza, tutto quanto il suo essere-nel-mondo. Si sa anche che ogni aspetto del suo essere ha un qualche rapporto con tutti gli altri, anche se poi possa risultare tutt'altro che chiaro in che modo i vari aspetti si articolano. Il compito della fenomenologia esistenziale consiste appunto nell'articolare il «mondo» dell'altro e il suo modo di esservi. Fin dall'inizio può darsi che la mia idea dell'ampiezza, o del raggio di estensione dell'essere di un uomo non coincida con la sua, e anzi nemmeno con quella di altri psichiatri. Per esempio io personalmente considero un qualsiasi individuo particolare come finito, cioè come uno che ha avuto un principio e che avrà una fine: è nato, e morirà; nel frattempo ha un corpo, che lo àncora a questo tempo ed a questo luogo. Io ritengo queste proposizioni applicabili a tutti e a ciascuno; ma non mi propongo di verificarle di nuovo tutte le volte che incontro un'altra persona, che anzi esse non si possono dimostrare né vere né false. Ma una volta ho avuto un paziente la cui idea dell'orizzonte del suo essere si estendeva al di là della nascita e della morte: «di fatto», e non semplicemente con «l'immaginazione», egli dichiarava di non essere realmente legato a un tempo ed a un luogo. Non lo consideravo psicotico, né avrei potuto dimostrare, se lo avessi voluto, che era nel falso. Tuttavia è di grande importanza pratica il riuscire a vedere che l'idea, o l'esperienza, che un uomo può avere nei confronti del suo essere, può essere molto diversa dalla propria. In questi casi è necessario potersi orientare come persona nello schema dell'altro, anziché limitarsi a vedere l'altro come un oggetto nel proprio mondo, cioè entro il proprio sistema totale di riferimento. E si deve poter effettuare questo nuovo orientamento senza giudicare anticipatamente dove sta il torto o la ragione. La capacità di fare tutto questo è il primo ed assoluto requisito per poter lavorare con gli psicotici. Vi è un altro aspetto dell'essere dell'uomo che è cruciale per la psicoterapia più che per altre forme di trattamento. Si tratta del fatto che ciascuno di noi è al tempo stesso separato dai suoi simili ed in rapporto con essi. Questi stati di separazione e di legame sono postulati reciprocamente necessari: infatti il rapporto personale può esistere solo tra esseri che siano separati ma non isolati. Non siamo isolati, e tuttavia non siamo delle parti dello stesso corpo fisico. Si ha qui il paradosso - potenzialmente tragico - che il nostro rapporto con gli altri è un aspetto essenziale del nostro essere, tanto quanto lo è la nostra separazione, mentre una qualsiasi persona particolare non è una parte necessaria del nostro essere. La psicoterapia è un'attività in cui viene usato a fini terapeutici un aspetto dell'essere del paziente: il suo rapporto con gli altri. Il terapeuta agisce sulla base del principio che, poiché questo rapporto è potenzialmente presente in ognuno, può non essere una perdita di tempo star seduto per delle ore accanto a un catatonico, che dà tutti i segni di non riconoscere la sua esistenza. Capitolo secondoLe basi fenomenologico-esistenziali per la conoscenza della psicosiIl gergo psichiatrico attualmente in uso presenta un'altra caratteristica. La psicosi è, in questo linguaggio, un mancato aggiustamento biologico o sociale, un disadattamento particolarmente grave, una perdita di contatto con la realtà, un difetto di autocritica. Come ha detto Van den Berg (1955), si tratta di un vero e proprio «vocabolario di denigrazione». Non già una denigrazione di tipo moralistico: almeno non in un senso ottocentesco, che anzi questo linguaggio è in un certo modo il risultato di uno sforzo fatto per evitare i concetti di libertà, di scelta, di responsabilità. Esso implica piuttosto un certo modo standard di essere umani: un modo con il quale lo psicotico non può competere. E sta di fatto che io non mi sento di respingere tutte le implicazioni contenute in questo «vocabolario di denigrazione», ma credo, al contrario, che bisognerebbe rendere ancora più espliciti, nel nostro pensiero, i giudizi che facciamo quando definiamo psicotico qualcuno. Quando dichiaro che un certo paziente è malato di mente, che può essere pericoloso a sé e agli altri, e che ha bisogno di ricovero in ospedale psichiatrico, non intendo equivocare sulle cose che scrivo. Al tempo stesso, però, sono anche cosciente del fatto che a mio avviso vi sono in giro altre persone, considerate sane, la cui mente è altrettanto gravemente ammalata; che possono essere altrettanto pericolose - o anche di più - a sé e agli altri, e che invece la società non considera psicotici da rinchiudere in manicomio. E sono anche cosciente del fatto che, se mi mandano un uomo avvertendomi che sta delirando, quest'uomo può, nel suo delirio, dirmi la verità, e ciò non in maniera vaga o metaforica, ma letteralmente, perché la mente ammalata dello schizofrenico può permettergli di vedere delle cose che non possono entrare nella mente intatta, ma non aperta, di molte persone sane. Ezechiele, a giudizio di Jaspers, era uno schizofrenico. A questo punto devo confessare una certa difficoltà personale di cui soffro come psichiatra, e che sta alla base di molte delle cose dette in questo libro. Si tratta del fatto che, tranne nel caso degli schizofrenici cronici, mi riesce difficile individuare con certezza i «segni e sintomi» della psicosi durante i colloqui che conduco personalmente. Ho pensato per un certo periodo che la cosa fosse dovuta a un mio difetto di acume nell'individuare la presenza dell'allucinazione, del delirio ecc. Se infatti confrontavo l'esperienza che avevo io degli psicotici con le descrizioni che si trovano nei libri di testo, non riconoscevo il modo di comportarsi dei miei malati nei pazienti descritti dagli autori, e pensavo che forse avevano ragione gli autori. Poi pensai che forse erano loro che avevano torto; ma questa opinione è altrettanto arbitraria. Per stare ai fatti, il problema si può formulare nel modo seguente. Le descrizioni dei libri di testo riguardano l'attività di una persona, in un campo di attività in cui è presente, anche lo psichiatra. Allora l'attività del paziente è, in qualche misura, una funzione dell'attività dello psichiatra che si trova nel campo. Il paziente psichiatrico tipico è una funzione dello psichiatra tipico, e dell'ospedale psichiatrico tipico. Il basso continuo (per usare un'immagine musicale) che accompagna tutte le grandi pagine di Bleuler sugli schizofrenici è contenuto in questa sua osservazione: che, tutto sommato, i pazienti gli risultavano più estranei degli uccelli del suo giardino. Bleuler, come sappiamo, si accostava al paziente allo stesso modo che un clinico medico si accosta ad un caso clinico: con rispetto, cortesia, considerazione, e curiosità scientifica. Ma il paziente è un malato, in senso medico, e bisogna arrivare a una diagnosi della sua condizione osservando i segni della malattia. È talmente evidente, per tanti psichiatri, che un simile atteggiamento è corretto, che a molti di essi potrà riuscire difficile capire dove voglio arrivare. È vero che oggi esistono molte scuole in cui si pensa diversamente, ma nel nostro paese il pensiero dominante è ancora questo; ed è certamente il modo di pensare accettato dal pubblico laico (sto sempre parlando di pazienti psicotici: quelli, come immediatamente pensa la maggior parte della gente, diversi da noi). Ed è l'atteggiamento al quale restano ancora attaccati, in pratica, gli psichiatri, anche se a parole molti di essi accettano l'idea di incompatibilità di punti di vista, di opinioni e valori, di modi di fare. Ci sarà anche del buono in questo atteggiamento, anche perché dà tanta sicurezza-, ma proprio per questo si deve esaminare attentamente la possibilità che, come atteggiamento clinico, come atteggiamento professionale, esso possa lasciare a desiderare, o anche, in certe circostanze, essere completamente sbagliato. La difficoltà non consiste semplicemente nel notare i sentimenti del paziente, cosi come si rivelano attraverso la sua attività. Qualunque buon clinico medico sa che se il paziente è ansioso la sua pressione sanguigna può essere più elevata del solito, il polso più rapido ecc. Ma il punto è che quando si ausculta «il cuore», o anche quando si esamina l'intero paziente in quanto organismo, si trascura di osservare la natura dei propri sentimenti personali verso di lui, come se, comunque, questi fossero irrilevanti e non degni di nota. Si conserva, insomma, un atteggiamento e un modo di fare professionali più o meno indifferenti. Che questo atteggiamento clinico-psichiatrico classico sia rimasto fondamentalmente lo stesso dai tempi di Kraepelin si può controllare confrontando il passo seguente con qualunque libro di testo inglese recente (per esempio Mayer-Gross, Slater e Roth). Si tratta di una dimostrazione in aula fatta da Kraepelin (1905), su un paziente con segni di eccitamento catatonico. Il paziente che oggi vi mostro ha dovuto essere portato quasi di peso, perché cammina a gambe larghe appoggiandosi sull'esterno del piede. Entrando getta in aria le ciabatte, si mette a cantare a voce altissima, e poi grida due volte, in inglese: «Padre mio! Padre mio vero! » Ha diciotto anni, frequentava l'Oberrealschule (scuola media superiore a indirizzo moderno), è alto e di forte costituzione, ma di colorito pallido, con rossori frequenti. Il paziente siede a occhi chiusi e non presta attenzione all'ambiente che lo circonda. Non guarda l'interlocutore, ma risponde dapprima a voce bassa, poi gradualmente gridando sempre più forte. Quando gli si chiede dove si trova dice: «Vuole sapere anche questo? Glielo dico io chi è misurato e viene misurato e dev'essere misurato. So tutto, glielo potrei dire, ma non voglio». Quando gli si chiede come si chiama, grida: «Come ti chiami? Che cosa chiude? Chiude gli occhi. Che cosa sente? Non capisce. Come? Chi? Dove? Quando? Che significa? Quando gli dico di guardarmi non mi guarda giusto. Eilà tu, guarda su! Cosa c'è? Che succede? Attento! Non sta attento. Ehi ehi dico, che c'è? Perché non mi rispondi? Ti rimetti a fare lo sfacciato? Non fare lo sfacciato! Ora vengo! Ora ti faccio vedere io! Tu non farmi da ruffiano. Non sei neanche intelligente. Sei uno sfacciato, fai schifo, uno sfacciato così, uno schifo cosi non l'ho mai visto. Ah ora ricomincia. Non capisci niente, niente! Niente capisce questo. Se ora stai attento non sta attento, non starà attento. Ora ti rimetti a fare lo sfacciato? Ancora più sfacciato? Come stanno attenti, stanno tutti attenti! » e così di seguito. Alla fine il paziente non emette che suoni inarticolati di collera. Kraepelin osserva poi, fra altre cose, la «inaccessibilità» del paziente: Nonostante sia fuor di dubbio che il paziente comprenda tutte le domande che gli sono rivolte, egli non ci ha fornito una sola informazione utile. I suoi discorsi sono... soltanto una serie di frasi sconnesse, che non hanno alcun rapporto con la situazione generale (1905). Che il paziente mostri i «segni» dell'eccitamento catatonico è indiscutibile. Ma la costruzione che eleviamo sulla base di questo tipo di attività dipende dal rapporto che avremo stabilito col paziente; e dobbiamo a Kraepelin e alla sua vivida descrizione se, cinquant'anni dopo, il paziente è vivo davanti a noi in questa pagina. Ma che cosa sta facendo? Sicuramente un dialogo: un dialogo fra la sua versione, parodistica, di Kraepelin, e il suo io in rivolta. «Vuole sapere anche questo? Glielo dico io chi è misurato e viene misurato e dev'essere misurato. So tutto, glielo potrei dire, ma non voglio». Questo è un discorso abbastanza chiaro: presumibilmente il paziente è molto ostile verso questa forma di interrogatorio, che si svolge in un'aula piena di studenti, e non vede che rapporto possa avere con le cose che lo turbano profondamente. Ma queste cose non costituirebbero «informazioni utili» per Kraepelin, tranne che come nuovi «segni» di una «malattia». Kraepelin gli chiede come si chiama. Il paziente scoppia in una collera esasperata, e dice quello che crede essere l'atteggiamento implicito nel modo di fare di Kraepelin: «Come ti chiami? Che cosa chiude? Chiude gli occhi... Perché non mi rispondi? Ti rimetti a fare lo sfacciato?... Tu non farmi da ruffiano [qui crede che Kraepelin lo voglia prostituire all'intera classe di studenti]... Uno sfacciato così, uno schifo così non l'ho mai visto...» Sembra chiaro che l'attività di questo paziente può essere vista almeno in due modi, analogamente al profilo e al vaso della figura ambigua. Si possono osservare nel suo comportamento i «segni» di una «malattia»; e si può considerare il suo comportamento come l'espressione della sua esistenza. La costruzione fenomenologico-esistenziale è un'inferenza sul modo con cui l'altro sente e agisce. Come è sentito Kraepelin dal paziente? Questo ragazzo pare tormentato e disperato. Che cosa «vuole» parlando e a- gendo in questo modo? Protesta perché lo misurano e lo visitano. Protesta perché vorrebbe, invece, che lo ascoltassero. L'interpretazione come funzione del rapporto col paziente.Lo psichiatra clinico, nel suo desiderio di essere «scientifico» e «oggettivo», può proporsi di limitarsi a considerare l'attività «oggettivamente» osservabile del paziente che gli sta di fronte. La risposta più semplice è che ciò è impossibile. Vedere «segni» di «malattia» non significa vedere in modo neutro. Né è imparzialità vedere un sorriso come una contrazione dello sfintere orale (Merleau- Ponty, 1942). Non possiamo far altro che vedere una persona in un modo o nell'altro, fondando le nostre costruzioni o interpretazioni sulla «sua» attività non appena entriamo in rapporto con lei. Questo accade anche nel caso negativo in cui ci si sente bloccati o imbarazzati dalla mancanza di reciprocità da parte del paziente, e si ha l'impressione che davanti a noi non ci sia nessuno. Con questo siamo molto vicini al centro del problema. Le difficoltà che ci si presentano sono simili, se non più grandi, a quelle incontrate da chi volesse tradurre dei geroglifici (questa analogia piaceva a Freud). La teoria dell'interpretazione o decifrazione dei geroglifici e di altri antichi testi è stata sviluppata ed esposta da Dilthey nel secolo scorso, cosa che non è avvenuta per la teoria della interpretazione di quei geroglifici che sono gli atti e le parole psicotiche. Un confronto del nostro problema con quello dello storico, cosi com'è visto da Dilthey, può contribuire a chiarire la nostra posizione: in entrambi i casi si tratta essenzialmente di un problema di interpretazione I documenti antichi possono essere sottoposti ad una analisi formale, analizzati cioè secondo la loro struttura, stile, tratti linguistici, caratteristiche sintattiche peculiari, ecc. La psichiatria clinica tenta di fare un'analisi formale di questo tipo sul linguaggio e sull'attività del paziente. Questo formalismo, storico o clinico, presenta ovviamente gravi limiti. Al di là dell'analisi formale si può far luce su un testo attraverso una conoscenza delle condizioni storico-sociali da cui proviene. Analogamente, si sente di solito il bisogno di estendere il più possibile l'analisi, formale e statica, dei segni clinici isolati, fino a comprendere il posto che essi occupano nella storia del paziente e le cause dinamiche della loro insorgenza. Ma l'informazione storica in sé, sia su antichi autori che su pazienti, può aiutarci a comprendere questi solo nel caso che noi desideriamo comprendere le loro modalità di essere-nel-mondo. Perciò, quando Dilthey «caratterizza il rapporto fra l'autore e il decifratore come il fattore che condiziona la possibilità di intelligenza del testo, egli in realtà individua il presupposto di ogni interpretazione che abbia alla base la comprensione» (Bultmann, 1955). «Noi spieghiamo - scrive Dilthey - mediante processi puramente intellettuali, ma comprendiamo mediante tutte le forze della mente unite nella comprensione. Nell'atto di comprendere partiamo dalle connessioni dell'insieme dato e vivente, per rendere comprensibile, in termini di questo, il passato». La nostra visione dell'altro dipende appunto dalla nostra disposizione a mobilitare tutte le forze in noi stessi per l'atto della comprensione. Occorre anche orientarsi verso questa persona in modo da lasciare aperta la possibilità di comprenderla. L'arte di comprendere gli aspetti osservabili in quanto espressione del modo di essere-nel- mondo di questo individuo consiste nel mettere i suoi atti in relazione al suo modo di vivere la situazione in cui si trova con noi. Analogamente, è in termini del suo presente che dobbiamo comprendere il suo passato, e non soltanto viceversa. Anche questo risulta vero nei casi negativi, in cui può sembrare dal suo comportamento che il paziente neghi del tutto l'esistenza della situazione: come quando, per esempio, ci sentiamo trattati come se non esistessimo, o come se esistessimo solo come riflesso dei suoi desideri o delle sue ansietà. Certo qui non si può attribuire ad una simile attività un significato rigidamente predeterminato. Facendolo, e considerando gli atti del paziente come «segni» di una «malattia», gli imponiamo le nostre categorie mentali, in modo analogo a quello che forse attribuiamo a lui; lo stesso accadrebbe se immaginassimo di poter spiegare il suo presente come il risultato meccanico di un passato immutabile. Se atteggiamenti di questo genere vengono adottati nei confronti di un paziente, non è più possibile capire le cose che forse egli cerca di comunicarci. Per riprendere l'esempio di una persona che parla e una che ascolta, mettiamo che io ti sieda di fronte e ti parli, e che tu possa: 1) cercare di scoprire e valutare eventuali anormalità del mio linguaggio; 2) cercare di spiegare quello che sto dicendo sulla base del metabolismo dell'ossigeno nel mio cervello; 3) cercare di scoprire perché dico certe cose in un certo momento, sulla base della mia storia passata e del mio ambiente socio-economico. Nessuna delle risposte che eventualmente potrai dare a queste domande sarà capace, in sé, di farti capire in maniera semplice che cosa voglio ottenere. È possibilissimo avere una conoscenza completa di tutto ciò che è noto sull'incidenza ereditaria o familiare delle psicosi maniaco-depressive o della schizofrenia; imparare a riconoscere facilmente le deformazioni schizoidi e i difetti schizofrenici dell'Io, oltre a tutti i vari disturbi del pensiero, della memoria, della percezione ecc.; insomma sapere pressapoco tutto quello che si può sapere sulla psicopatologia della schizofrenia, cioè sulla schizofrenia come malattia, senza per questo essere in grado di capire un solo schizofrenico. Quei dati di conoscenza, infatti, sono in realtà tutti modi di non capirlo. Guardare e ascoltare un paziente e vedere in lui i «segni» della schizofrenia come «malattia», e guardarlo e ascoltarlo semplicemente come essere umano, sono due cose radicalmente diverse, e- sattamente come quando, nella figura ambigua, si vede prima il vaso e poi i due profili. Naturalmente, come osserva Dilthey, l'interprete di un testo ha il diritto di presumere che, nonostante il tempo intercorso e nonostante l'ampia divergenza del suo modo di vedere rispetto al modo di vedere dell'antico autore, il suo contesto generale di esperienza non sia completamente diverso da quello dell'originale. In fin dei conti egliv come l'autore originale, esiste nel mondo, come oggetto permanente nel tempo e nello spazio, insieme con altri simili a lui. Ma questo presupposto non è valido nei confronti dello psicotico. Da questo punto di vista può essere più difficile capire uno psicotico, che sta qui con noi adesso, che non capire l'autore di un geroglifico, morto migliaia di anni fa. E tuttavia la distinzione non è essenziale. Dopotutto lo psicotico - come diceva Harry Stack Sullivan - è soprattutto «semplicemente umano». Le due personalità del medico e dello psicotico, non diversamente da quelle dell'interprete e dell'autore del testo, non sono contrastanti, come due fatti opposti che non possono né incontrarsi né confrontarsi. Però, come l'interprete, il terapeuta deve possedere una plasticità sufficiente per potersi trasporre in un altro modo, un modo strano e che forse gli è completamente alieno, di vedere il mondo. In questo atto di trasposizione il terapeuta attinge alle sue proprie potenzialità psicotiche, senza per questo rinunziare alla sua salute mentale. Solo cosi può arrivare a cogliere la posizione esistenziale del paziente. Spero che sia chiaro che non sto parlando di un processo puramente intellettuale. Invece di cogliere si potrebbe benissimo dire amare; solo che non c'è parola più abusata di questa. La capacità necessaria (ma non sufficiente) è quella di sapere come il paziente senta se stesso e il mondo, ivi compreso il terapeuta: se non si può capire questo non si è certo nella migliore condizione per poter cominciare ad «amarlo» in modo utile. Ci è stato comandato di amare il nostro prossimo, ma non si può amare disinteressatamente un qualunque prossimo particolare senza sapere chi è: si può solo amare la sua astratta umanità. Così non si può amare un conglomerato di «segni di schizofrenia». Nessuno ha la schizofrenia, nel senso che intendiamo quando diciamo che uno ha il raffreddore. Il paziente non ha la schizofrenia: è schizofrenico. Bisogna conoscerlo senza distruggerlo, e lui stesso deve scoprire per conto suo che ciò è possibile. Per questa ragione i sentimenti di a- more e di odio del terapeuta sono ugualmente ed estremamente importanti, perché quello che lo schizofrenico rappresenta per noi contribuisce potentemente a determinare quello che noi siamo per lui, e con ciò i suoi atti. Mentre invece i «segni», quelli riportati sui libri di testo, variano anche di molto da un ospedale all'altro; alcuni psichiatri osservano alcuni segni più di altri; si direbbe che, a seconda degli ospedali, i segni schizofrenici vengano rilevati in funzione delle cure infermieristiche Ritengo perciò che sia assolutamente vera, anche se difficile da accettare, la seguente proposizione di Frieda Fromm-Reichmann: «...ormai gli psichiatri possono ritenere per certo che, almeno teoricamente, è possibile stabilire un rapporto medico-paziente col paziente schizofrenico. Nei casi in cui ciò appaia impossibile, il motivo risiede nelle difficoltà personali del medico e non già nella psicopatologia del paziente» ( 1952). Naturalmente, come accade col ragazzo catatonico di Kraepelin, il paziente reagisce al terapeuta solo in parte secondo ciò che questo ritiene di essere; per il resto risponde in termini delle sue fantasie su ciò che il terapeuta è. E il terapeuta cerca appunto di far vedere al paziente che nel suo modo di agire è implicita questa sua particolare percezione fantastica: della quale con grandissima probabilità egli non si rende conto interamente, cioè la vive inconsciamente, ma che nondimeno rappresenta un necessario postulato se si vuol cominciare a capire questo modo di agire. Quando due persone sane stanno insieme, ci si aspetta che A riconosca B, più o meno, per la persona che B ritiene di essere, e viceversa. Vale a dire che da parte mia mi aspetto che la definizione che io do di me stesso coincida, almeno pressapoco, con quella che ne dà l'altra persona; naturalmente assumendo che io non stia facendo l'ipocrita, o dicendo delle bugie, o fingendo di essere un altro. (C'è una storiella su un paziente sottoposto alla prova del riflesso psicogalvanico. Gli viene chiesto di dire se è Napoleone e risponde di no. Il galvanometro registra una bugia.) Tuttavia, anche entro il contesto della salute mentale di entrambi c'è un margine abbastanza largo di errori, conflitti, false percezioni: in breve, c'è margine per una certa discrepanza fra la persona che si è ai propri occhi (l'essere per se stessi) e la persona che si è agli occhi dell'altro (l'essere per l'altro); e reciprocamente, fra la persona che lui è per me e quella che invece è per se stesso; e infine, fra la persona che lui ritiene essere la sua immagine di se stesso, l'immagine degli atteggiamenti e intenzioni che ritiene di avere verso se stesso, e l'immagine, gli atteggiamenti e le intenzioni che in realtà ha verso se stesso, e viceversa. Insomma, quando due persone sane di mente si incontrano si ha una certa percezione reciproca dell'identità personale di ciascuno, percezione nella quale sono contenuti due elementi fondamentali: a) io riconosco l'altro come la persona che egli stesso ritiene di essere; b) l'altro riconosce me come la persona che io stesso ritengo di essere. Ciascuno dei due possiede un senso autonomo della propria identità e una sua propria definizione di sé; e l'uno si aspetta dall'altro che questi sia capace di riconoscerlo, cioè io sono abituato ad aspettarmi che la persona che tu ritieni che io sia, e l'identità che io attribuisco a me stesso, grosso modo coincidano. Diciamo grosso modo, perché sono ovviamente possibili divergenze anche notevoli. Ma se, anche dopo i normali tentativi per ridurle, restano delle divergenze profonde, allora non resta che concludere che uno dei due non è sano di mente. Io non ho difficoltà a considerare psicotica un'altra persona, se questa, per esempio: - dice di essere Napoleone, mentre io dico che non lo è; - dice che io sono Napoleone, mentre io dico di non esserlo; - crede che io voglia sedurlo, mentre io credo di non avergli mai dato motivi reali perché lui supponga che tale sia la mia intenzione; - crede che io abbia paura che lui voglia assassinarmi, mentre io non ho questa paura né ho fatto nulla per giustificare la sua supposizione. E suggerisco il criterio seguente: la salute mentale, o la psicosi, si misura col grado di convergenza o divergenza esistente fra due persone, una delle quali sia, per comune consenso, sana di mente. Il test per stabilire se un paziente sia psicotico è un difetto di convergenza, un'incongruenza, un urto fra lui e me. «Psicotico» è il nome che riserviamo all'altra persona che sta con noi in un rapporto disgiuntivo particolare. È solo per questa disgiunzione interpersonale che cominciamo a chiedere un'analisi delle urine e a cercare anomalie nel suo elettroencefalogramma. Ma a questo punto converrà esaminare un po' più da vicino la natura di questa barriera, o disgiunzione, fra il sano e lo psicotico. Se, per esempio, un uomo afferma di essere irreale, sempre che non stia mentendo, o scherzando, o equivocando in maniera sottile con le parole, non c'è dubbio che verrà considerato delirante. Ma cosa significa, esistenzialmente, il suo delirio? Egli non scherza, né finge: anzi insiste che ha continuato per anni a fingere di essere una persona reale, e dice che ora non può più continuare l'inganno. La sua vita intera è stata una lotta fra il desiderio di svelarsi e il desiderio di nascondersi. Tutti noi abbiamo, in comune con lui, questo stesso problema, e tutti siamo arrivati a una soluzione più o meno soddisfacente. Abbiamo i nostri segreti, e il desiderio di confessarli. Possiamo anche ricordare come, nell'infanzia, gli adulti sapessero vederci dentro come se fossimo trasparenti; ma in seguito, quale grande conquista per noi quando, tutti tremanti, dicemmo la prima bugia, scoprendo al tempo stesso di essere, sotto certi aspetti, irrimediabilmente soli, e apprendendo che entro i confini di questo territorio deserto potevano esservi solo le nostre impronte. Alcuni di noi però non si realizzano mai - non diventano mai «reali» - in questa forma. Questo genuino essere soli con se stessi costituirà per la maggior parte di noi la base per poter avere con gli altri rapporti genuini: ma quello che chiamiamo «schizoide» si sente al tempo stesso più esposto, più vulnerabile di noi, e più isolato. Ecco perché uno schizofrenico può dire di essere fatto di vetro, e tanto trasparente e fragile che un'occhiata basta a penetrarlo e mandarlo in frantumi. Possiamo crederlo: egli si sente precisamente cosi. Allora dobbiamo pensare che l'uomo irreale abbia imparato cosi bene a nascondersi proprio in conseguenza di questa estrema vulnerabilità. Egli ha imparato a piangere quando era allegro e a sorridere quando era triste. Ha accolto le lodi con malumore, i rimproveri con allegria. «Niente di quello che voi vedete sono io», egli dice dentro di sé. Ma (in realtà) egli può essere qualcuno soltanto in quello che vediamo noi: e se quello che vediamo noi, le sue azioni, non sono il suo vero io, allora egli è irreale davvero; è qualcosa di ambiguo e del tutto simbolico, una persona puramente virtuale, potenziale, immaginaria, un uomo mitico, in realtà un niente. E se poi per una volta smette di fingere di essere quello che non è, e viene fuori come la persona che è diventato, ne esce un Cristo, uno spettro, non un uomo: esistere senza un corpo si paga col non essere. Cosi, nella sua vita, la sua condizione esistenziale è diventata vera: ciò che è vero esistenzialmente diventa vero in realtà. Non c'è dubbio che la maggior parte delle persone giudicano realmente vero soltanto ciò che ha a che fare col linguaggio e col mondo naturale. Un uomo dice di essere morto quando invece è vivo, e la sua «verità» è quella di essere morto; ma egli la esprime nell'unico modo, forse, che il senso comune (cioè comunitario) gli permette. Quello che intende dire è che è realmente e letteralmente morto, non già in modo simbolico o «in un certo senso» o «per modo di dire»: ma il prezzo che si paga per questa trasformazione di valore della verità comunitaria è la pazzia, giacché l'unica morte reale che gli altri riconoscono è quella biologica. Lo schizofrenico è un uomo senza speranza. Non ho mai conosciuto uno schizofrenico che potesse dire di essere amato come uomo: da Dio padre, dalla madre di Dio, da un altro uomo. Lui stesso è Dio, o il diavolo, o sta all'inferno estraniato da Dio. Quando qualcuno dice in tutta serietà di essere irreale o di essere morto, egli esprime in termini radicali la nuda verità della sua esistenza come da lui stesso è sentita: cioè la follia. E a noi che cosa resta da fare? Il centro dell'esperienza schizofrenica è destinato a rimanerci incomprensibile, fin tanto che noi siamo sani di mente e lui no. Ma di una cosa certamente lo schizofrenico non ha bisogno né desiderio: del nostro sforzo di raggiungerlo e comprenderlo restando però nel nostro mondo, e giudicandolo col criterio delle nostre categorie, alla cui altezza egli non potrà mai essere. Dobbiamo invece tenere continuamente presente il suo essere distinto, separato, diverso; la sua solitudine e la sua disperazione. (La schizofrenia non si può comprendere se non si comprende la disperazione. Cfr. specialmente Kierkegaard, 1953; Binswanger, 1958.) Capitolo terzoL'insicurezza ontologicaA questo punto possiamo definire con maggior precisione la natura della nostra ricerca clinica. Un uomo può avere il senso della sua presenza nel mondo come persona reale, viva, intera e, in senso temporale, continua. Come tale vive nel mondo e ne fa parte, e incontra gli altri; e sia questi che quello vengono vissuti come altrettanto reali, vivi, interi e continui. Questa persona, fondamentalmente sicura in senso ontologico (II termine non è da intendere qui nel suo senso filosofico, come per esempio si trova usato in Heidegger, Sartre o Tillich, ma nel suo significato empirico, cioè come avverbio o aggettivo della parola «essere»), è in grado di affrontare la vita e le sue difficoltà di ordine sociale, etico, spirituale e biologico, armata di questo suo senso, solido e centrale, della realtà e della identità di se stessa e degli altri. Ed è spesso difficile, per una persona con un tale senso della sua identità personale, col senso della permanenza e della interezza di sé e delle cose, col senso della stabilità e della sostanzialità dei processi naturali; è spesso difficile per una persona così trasporsi nel mondo di un individuo, nella cui esperienza manchi invece completamente ogni certezza al di là del dubbio, ogni certezza di per sé evidente. Il nostro studio riguarda le cose che succedono quando vi è un'assenza o un difetto delle certezze derivanti da una condizione esistenziale che ora possiamo chiamare sicurezza ontologica primaria, e quando al loro posto vi sono ansietà e pericoli che, come qui suggerisco, provengono soltanto da una insicurezza ontologica primaria-, riguarda infine i tentativi, conseguenti a questa condizione, di affrontare quelle ansietà e quei pericoli. Il critico letterario Lionel Trilling ( 1957) ha descritto con grande chiarezza lo stesso contrasto fra una condizione esistenziale di sicurezza ontologica di fondo e una condizione di insicurezza ontologica. L'autore confronta il mondo di Shakespeare e Keats da una parte, e quello di Kafka dall'altra: ... per Keats la consapevolezza del male esiste accanto a un senso fortissimo di identità personale, e per questo motivo è meno immediatamente apparente; ad alcuni lettori contemporanei potrà sembrare, per lo stesso motivo, anche meno intensa. Allo stesso modo può apparire a un lettore contemporaneo che, se confrontiamo Shakespeare a Kafka trascurando le differenze di statura, e considerando entrambi come interpreti della sofferenza e della alienazione cosmica dell'uomo, sia quella di Kafka l'esposizione più intensa e completa. E in realtà può anche darsi che si tratti di una valutazione giusta, proprio perché in Kafka il senso del male non è contraddetto dal senso dell'identità personale. Il mondo di Shakespeare, non meno di quello di Kafka, è quella prigione con cui Pascal definisce il mondo, dalla quale ogni giorno i condannati vengono condotti a morire; non meno di Kafka, Shakespeare ci costringe a vedere la crudele irrazionalità della condizione umana, la vita come un racconto detto da un idiota, gli dèi puerili che ci torturano non per punizione ma per divertirsi; non meno di Kafka, Shakespeare si sente rivoltare al fetore della prigione, ché nulla è in lui più caratteristico delle sue immagini di disgusto. Ma nella cella di Shakespeare, in quale miglior compagnia ci si trova! I capitani e i re, gli amanti e i buffoni di Shakespeare sono vivi e completi fino all'ora della morte. Ma in Kafka qualcosa di terribile è stato fatto ai condannati già molto tempo prima che la sentenza venga eseguita, anzi molto tempo prima che si istituisca il maligno processo. E sappiamo tutti di che si tratta. Essi sono stati spogliati di tutto quello che si addice all'uomo, tranne la sua astratta umanità, che però, come i loro scheletri, non gli si addice mai del tutto. Sono senza parenti, senza casa, senza moglie o figli, senza impegno o appetito; sono a loro e- stranei il potere, la bellezza, l'amore, l'ingegno, il coraggio, la lealtà, la fama; e il senso di orgoglio che si prova nel possedere queste cose. Così che possiamo dire che la conoscenza del male esiste in Kafka senza la conoscenza, con essa contrastante, dell'io nella sua saldezza e validità; mentre in Shakespeare la conoscenza del male esiste accanto a questo contrasto, espresso il più fortemente possibile. Cioè, dice Trilling, i personaggi di Shakespeare mostrano chiaramente di sentirsi reali e vivi e completi, per quanto possano essere tormentati da dubbi o combattuti; al contrario di quanto avviene in Kafka, dove viceversa si ha uno sforzo di comunicare cosa significa essere vivi senza averne la certezza: caratteristica che sembra essere presente nell'opera di numerosi scrittori e artisti del nostro tempo. La vita, senza sentirsi vivi. Per esempio, con Samuel Beckett si entra in un mondo in cui nessun senso contrastante dell'io «nella sua saldezza e validità» viene a mitigare la disperazione, il terrore e lo squallore dell'esistenza. Così i due vagabondi che aspettano Godot sono condannati a vivere: Estragone Troviamo sempre qualche cosa, eh, Didi, che ci dà l'impressione di esistere? Vladimiro (con impazienza) Sì, sì, siamo dei maghi. Ma pensiamo a quello che dobbiamo fare, prima di scordarcene. In pittura è Francis Bacon, fra altri, che sembra trattare, problemi simili. In generale è evidente che gli argomenti che qui verranno trattati da un punto di vista clinico non rappresentano che un piccolo campione di qualcosa, in cui la natura umana è profondamente implicata; e che il nostro contributo alla sua comprensione può solo essere parziale. Ma cominciamo dal principio. La nascita biologica è un atto definitivo, col quale l'organismo infantile viene scagliato nel mondo. Eccolo: è un nuovo nato, una nuova entità biologica, già fatta a modo suo, viva e reale: almeno dal nostro punto di vista. Ma dal suo? In circostanze normali, la venuta al mondo di un nuovo organismo vivente coincide con l'inizio di rapidi processi, in virtù dei quali entro un tempo sorprendentemente breve il bambino si sente vivo e reale, ed ha il senso di essere un'entità, continua nel tempo e provvista di un posto nello spazio. Insomma alla nascita fisica, all'ingresso biologico nella vita fa seguito la nascita esistenziale, il diventare vivo e reale. Di solito questa sequenza risulta naturale, e fornisce la certezza dalla quale dipenderanno tutte le altre certezze: cioè non sono i soli adulti a vedere i bambini come entità biologiche reali, ma i bambini stessi si sentono persone intere, vive e reali, e similmente sentono vivi e reali gli altri esseri umani. Sono questi i dati in sé validi dell'esperienza. In breve, l'individuo può avere esperienza di se stesso come di una cosa viva, reale, intera; differenziata dal resto del mondo, in circostanze ordinarie, tanto chiaramente da non mettere mai in dubbio la propria identità e la propria autonomia; un'autonomia continua nel tempo; dotata di coerenza interna, di sostanzialità, di genuinità e di valore; spazialmente identica al proprio corpo; e, di solito, come qualcosa che ha avuto inizio con la nascita, o approssimativamente con essa, e che si estinguerà con la morte. Tutto questo rappresenta il solido nucleo della sicurezza ontologica. Ma può accadere diversamente. Anche in circostanze di vita ordinarie, un individuo può sentirsi più irreale che reale; letteralmente più morto che vivo; differenziato in modo incerto e precario dal resto del mondo, cosi che la sua identità e la sua autonomia sono sempre in questione. Può mancargli la sensazione della continuità temporale; può fargli difetto il senso della propria coerenza o coesione personale. Si può sentire come impalpabile, e incapace di ritenere genuina, buona e di valore la stoffa di cui è fatto. Può sentire il suo io parzialmente disgiunto dal suo corpo. È naturalmente inevitabile che un individuo le cui esperienze di se stesso siano di quest'ordine non possa vivere in un mondo «sicuro», più di quanto può sentirsi sicuro in se stesso. L'intera fisionomia del suo mondo sarà per lui corrispondentemente diversa da quella dell'individuo il cui senso di se stesso si è fermamente stabilito in tutta la sua saldezza e validità, e il rapporto con le altre persone gli apparirà in un significato e con funzioni radicalmente diverse. Anticiperemo quello che segue dicendo che, nell'individuo il cui essere è sicuro in questo senso di esperienza primaria, il rapporto con gli altri appare potenzialmente buono e piacevole; laddove, invece, la persona ontologicamente insicura si preoccupa di difendere se stessa, piuttosto che di procurarsi piacere, e le circostanze più ordinarie della vita bastano a minacciare la sua bassa soglia di sicurezza Se è stata raggiunta una condizione di sicurezza ontologica primaria, le normali circostanze della vita non presentano una minaccia continua per la propria esistenza. Ma se questa base per vivere non è stata raggiunta, tutte le circostanze comuni della vita quotidiana costituiscono un pericolo continuo e mortale. Solo rendendosi conto di ciò è possibile cominciare a capire come possano svilupparsi certe psicosi. Se l'individuo non è in grado di accettare come cose naturali la realtà, l'autonomia, l'identità, l'essere vivo suo e degli altri, deve continuamente inventare dei modi per cercare di essere reale, di mantenersi vivo o di mantenere vivi gli altri, di conservare la sua identità; deve lavorare continuamente per impedire (come egli stesso dirà) a se stesso di perdersi. Tutti gli eventi che per la maggior parte di noi sono cose di tutti giorni, che non si notano o si notano appena perché non hanno nessun significato speciale, diventano invece per lui profondamente significativi, almeno nella misura in cui contribuiscono al sostegno del suo essere, o per contro lo minacciano col pericolo di non essere. Così questo individuo, per il quale i vari elementi che compongono il mondo stanno assumendo, o hanno già assunto, una gerarchia di importanza e di significato diversa da quella della persona ordinaria, comincia, come si dice, a «vivere in un mondo suo proprio», o già vi vive da tempo. Ma non corrisponde a verità dire, senza aggiungere altro, che questa persona « sta perdendo il contatto» con la realtà e che si ritira in se stessa. Gli eventi esterni non lo colpiscono più allo stesso modo degli altri individui: ma non per questo lo colpiscono di meno, anzi spesso lo colpiscono di più, il che non può certo significare che la persona stia diventando «indifferente» o che si ritiri in se stessa. Più semplicemente, il mondo della sua esperienza personale è diverso e incomunicabile. Ma prima di esplorare questo processo sarà utile descrivere separatamente tre forme di ansietà di cui soffre la persona ontologicamente insicura, dando a ciascuna di esse un nome convenzionale: risucchio, implosione, pietrificazione. 1. Risucchio. Nel corso di una seduta psicanalitica di gruppo nacque una discussione fra due pazienti. Improvvisamente uno dei due troncò la discussione dicendo: «Così non posso continuare. Lei discute per il piacere di avere la meglio su di me. A lei non può succedere niente, al massimo può perdere la discussione. Ma io combatto per la mia esistenza». Questo paziente era un uomo giovane, che io definirei sano di mente, ma, come egli stesso diceva, la sua attività nella discussione (e in tutto il resto) non aveva lo scopo di dargli soddisfazione, bensì quello di difendere la sua esistenza. Anche qui si potrebbe sostenere che se questa persona si immaginava davvero che aver la peggio in una discussione avrebbe messo in pericolo la sua vita, allora doveva aver perso completamente il «contatto con la realtà», ed era virtualmente uno psicotico. Ma questo equivale semplicemente a porsi la questione, senza poi fare più nulla per capire il paziente. Invece è importante rendersi conto che, se si sottoponesse questo paziente al tipo di intervista psichiatrica consigliata in tanti libri di testo, nel giro di pochi minuti il suo comportamento e il suo linguaggio rivelerebbero chiari «segni» psicotici; ma che è facilissimo provocare tali « segni » in una persona la cui soglia-base di sicurezza è talmente bassa che praticamente qualunque tipo di rapporto con un altro, per quanto superficiale o per quanto apparentemente inoffensivo, può minacciare di sopraffarlo. Per poter avere un rapporto da essere umano con un'altra persona è necessario possedere un senso solido della propria autonomia e della propria identità: se non è cosi, ogni rapporto minaccia l'individuo di perdita dell'identità. Una forma particolare di questa perdita può chiamarsi «risucchio». L'individuo teme ogni rapporto in quanto tale, con chiunque e persino con se stesso, perché l'incertezza che prova, il senso di instabilità che ha nei confronti della sua autonomia, gli fa continuamente temere di perderla nel rapporto. Ma il risucchio non è semplicemente temuto come qualcosa che può accadere volente o nolente, malgrado tutti gli sforzi che si possono fare per evitarlo. L'individuo si sente invece come uno che continuamente, con la più strenua, costante, disperata attività, deve lottare per non lasciarsi annegare. Il risucchio è vissuto come il rischio costante di essere compreso (e quindi preso, afferrato), o di essere amato, o semplicemente di essere visto. Per altre ragioni si può anche temere di essere odiati, ma questo appare spesso meno terribile dell'essere inghiottiti o risucchiati, e perciò annientati (come in effetti si teme) dall'amore. La manovra principale cui si ricorre per conservare l'identità quando si vive nel timore del risucchio consiste nell'isolarsi. Così, in luogo dei due poli di un'esistenza fondata sull'autonomia individuale: la separazione dagli altri e il rapporto con gli altri, si ha un'antitesi: la completa perdita dell'essere, attraverso un assorbimento nell'altra persona (cioè il risucchio), o la completa solitudine (l'isolamento). Non c'è nessun'altra possibilità di rapporto dialettico, come accade fra due persone col terreno sicuro sotto i piedi, e perciò dotate del coraggio di «perdersi» l'una nell'altra: con quella sicurezza di sé che sola può permettere un'autentica fusione reciproca. Se un uomo odia se stesso può desiderare di perdersi nell'altro: in questo caso, farsi annientare dall'altro costituisce una fuga da se stesso. Nell'esempio presente si ha il continuo timore di questa possibilità. Come si vedrà più avanti, la stessa cosa che in un certo momento è temutissima e disperatamente evitata può trasformarsi in una cosa desiderata con tutte le forze. Questa forma di ansia spiega una forma particolare di «reazione terapeutica negativa» che si verifica in terapia in seguito ad una interpretazione apparentemente corretta. Infatti essere capiti significa essere risucchiati, circondati, inghiottiti, annegati, mangiati, soffocati dall'abbraccio della presunta comprensione dell'altra persona. È penoso e fa sentire soli essere sempre incompresi, ma da questo punto di vista, nell'isolamento si ha almeno un minimo di sicurezza. L'amore dell'altro è perciò più temuto del suo odio, o meglio, l'amore è sentito come una forma di odio. Con l'essere amati ci si trova in un obbligo non desiderato. In terapia, con una persona di questo tipo, l'ultima cosa da fare è di fingere più «amore» o «interessamento» di quanto si prova in realtà. Quanto più i motivi personali - necessariamente molto complessi - del terapeuta per cercare di aiutare una persona di questo tipo convergono verso una genuina preoccupazione a «lasciarlo in pace», anziché verso il suo soffocamento di fatto, o verso una semplice indifferenza, tanto maggiori saranno le speranze di riuscita. Oltre a quelle già accennate, vengono usate molte altre immagini per descrivere forme analoghe di minaccia della propria identità, tutte strettamente connesse con la paura del risucchio. Per citarne alcune: essere sepolti, essere presi e sprofondati nelle sabbie mobili; molto spesso ricorre l'immagine del fuoco. Il fuoco può essere l'incerto bagliore della vita interiore dell'individuo stesso, oppure una potenza ignota e distruttiva, che lo devasta. Alcuni psicotici in fase acuta dicono di essere seduti sul fuoco e che il loro corpo sta bruciando. Un paziente descrive se stesso come una cosa fredda e secca, ma ha terrore di qualunque cosa che sia calda o bagnata: teme di essere inghiottito dall'acqua o dal fuoco, e in entrambi i casi annientato. 2. Implosione (Implosion). Questo è il termine più forte che ho saputo escogitare per indicare una forma estrema di urto, come l'ha chiamato Winnicott, della realtà. Ma questa parola non dà l'idea piena del terrore di sentire il mondo come qualcosa che da un momento all'altro può sfondarci, e cancellare qualunque traccia della nostra identità come un gas che irrompe in un vuoto. L'individuo si sente appunto «vuoto». Ma questo vuoto è lui stesso: sebbene, in altri modi, desideri che il vuoto venga riempito, egli teme la possibilità che ciò avvenga, perché si è andato convincendo di non essere null'altro che questo vuoto spaventoso. Allora ogni «contatto» con la realtà viene sentito, in sé, come una terribile minaccia, perché questa, così com'è vissuta da lui, è necessariamente implosiva, e quindi, come i rapporti con gli altri minacciavano di inghiottire, anch'essa è di per sé un pericolo per quel po' di identità che l'individuo può ancora supporre di possedere. La realtà come tale, minacciando di inghiottire o di implodere, è il persecutore. E si badi che solo pochi gradi di temperatura separano tutti noi dallo stesso ordine di esperienza. Un po' di febbre, ed ecco che il mondo può cominciare ad assumere un aspetto minaccioso e persecutorio. 3. Pietrificazione e spersonalizzazione. Nell'uso del termine «pietrificazione» si possono assumere le varie accezioni di questa parola, e cioè: a) una forma particolare di terrore o incubo, nel quale si è trasformati in pietra; b) il timore che ciò accada, cioè il timore di diventare o essere trasformati, da persona viva, in una cosa morta: una pietra, un robot, un automa, una cosa senza soggettività e senza autonomia personale; c) l'atto magico con il quale qualcuno può tentare di trasformare qualcun altro in pietra; e, per estensione, l'atto con cui uno nega o cancella l'autonomia dell'altro, ignora i suoi sentimenti, lo considera un oggetto, uccide la vita che è in lui. In questo senso sarebbe forse meglio parlare di spersonalizzazione o di reificazione: si è trattati non come una persona o un libero agente, ma come una cosa. La spersonalizzazione dell'altro è di uso universale: si ricorre ad essa quando l'altro sta diventando troppo noioso o reca disturbo. Si cessa di rispondere ai suoi sentimenti, non se ne tiene più conto, lo si tratta come se non ne 1 avesse. Ma le persone che ci interessano qui hanno la tendenza sia a sentire se stesse più o meno spersonalizzate, sia a spersonalizzare gli altri, perché temono costantemen- ; te di venire spersonalizzati da questi. E l'atto di trasformarle in una cosa equivale realmente, per esse, a pietrificarle, perché quando le si tratta come una cosa la loro soggettività si ritira, come il sangue dal viso di uno che impallidisce. Fondamentalmente queste persone hanno bisogno di ricevere costantemente dagli altri una conferma della loro esistenza. Come si è già accennato, nella vita di ogni giorno si ricorre molto spesso a una parziale spersonalizzazione degli altri, e questa pratica viene considerata normale anche se non molto desiderabile. Molti rapporti si fondano su questa tendenza a non trattare l'altro secondo la consapevolezza che si ha di lui come persona, ma piuttosto come se fosse un robot in forma umana, che esegue la sua parte in una grande macchina, nella quale anche noi obbediamo alla nostra. Di solito si accarezza la speranza, che può essere una realtà e non un'illusione, che vi sia una zona sia pur limitata della nostra vita, immune da questo processo di disumanizzazione. Ma è proprio in questa zona che si avverte il rischio più grande, e la persona ontologicamente insicura lo sente fortissimo. Il rischio consiste in questo: se si sente l'altro come un libero agente, si è esposti alla possibilità di sentire se stessi come un oggetto della sua esperienza, e quindi di sentirsi prosciugare la propria soggettività. Si è minacciati dal pericolo di diventare un semplice oggetto del mondo dell'altro, senza più vita propria, senza più un essere proprio. Sotto l'effetto di questa ansia l'atto stesso di sentire l'altro come persona viene vissuto come un atto potenzialmente suicida. Questa esperienza viene brillantemente descritta da Sartre nella terza parte di L'essere e il nulla. Teoricamente la cosa è chiara. Ci si può sentire vivificati dall'altro, rinforzati nel proprio essere, ma si può anche sentirsi soffocati e impoveriti da lui. Una persona può essere giunta a concludere in anticipo che tutti i possibili rapporti con un altro avranno il secondo tipo di effetto. Allora chiunque può rappresentare un pericolo per il proprio «io» (cioè per la propria capacità di agire in maniera autonoma), non per quello che può fare o non fare specificamente, ma in ragione della sua stessa esistenza. Alcune delle cose dette trovano un esempio pratico nella vita di James, un chimico ventottenne. La sua difficoltà era di non poter diventare una «persona», non aveva un suo «io». «Sono soltanto una risposta agli altri: non ho una mia identità». (Avremo occasione più avanti, ai capp. 5 e 6, di descrivere in dettaglio la sensazione di non essere il vero io di se stesso e di vivere un falso io). Aveva l'impressione di diventare sempre più «una persona fantastica»; e di non avere peso o sostanza. «Non sono altro che un sughero che galleggia nel mare». Per quest'uomo era un tormento il non aver potuto diventare una persona, e di questo fallimento egli incolpava sua madre. «Per lei io ero soltanto un oggetto da mostrare: non ha mai riconosciuto la mia identità». E come contrasto all'incertezza riguardo a se stesso, e alla sua autodenigrazione, era sempre sul punto di venir sopraffatto, schiacciato, dalla forza della realtà posseduta dagli altri. In contrasto al suo poco peso, alla sua incertezza, alla sua scarsa sostanza, gli altri gli apparivano solidi, decisivi, assai significativi, sostanziali, e come costruiti su una scala più grande della sua. Ma al tempo stesso, in pratica, non si lasciava sopraffare facilmente. Per conservare una certa sicurezza aveva due tecniche. La prima consisteva in una grande docilità esteriore nei confronti degli altri (cfr. cap. 7). La seconda era ima testa di Medusa, privata e segreta, con la quale pietrificava gli altri a volontà. Le due tecniche, nell'insieme, gli garantivano il mantenimento della propria soggettività, che egli non si trovava mai a dover tradire o smentire apertamente, perché non doveva mai esprimerla in modo diretto o immediato. Il segreto gli forniva la sicurezza. Le due manovre lo salvavano dal pericolo di essere annientato o spersonalizzato. Col suo comportamento esterno, infatti, che consisteva nel fingere di non essere altro che un sughero, egli neutralizzava il pericolo cui era costantemente esposto, quello di diventare un oggetto posseduto da qualcun altro. (Dopotutto, cosa può esservi di più sicuro, nel mare, di un sughero?) Ma al tempo stesso, col suo potere magico di trasformare, ai suoi propri occhi, l'altra persona in un oggetto, egli, in segreto, disarmava totalmente il nemico, e distruggendolo come persona (sempre ai propri occhi) lo privava del potere di schiacciarlo; togliendogli la vita personale, ossia riuscendo a vederlo non come un essere umano, ma come un semplice meccanismo, annegato, imploso nel suo stesso vuoto, trasformato in un semplice guscio, finalmente non lo temeva più. Questo paziente era sposato con una giovane donna molto vivace, di grande spirito, dotata di una forte personalità e di un'intelligenza molto autonoma. Il suo rapporto con lei era paradossale, perché in un certo senso egli era completamente solo e isolato, mentre in un altro le stava accanto quasi come un parassita. Uno dei suoi sogni, per esempio, consisteva nell'essere un'ostrica attaccata al corpo di sua moglie. Appunto in quanto poteva fare un sogno simile, egli aveva tanto più bisogno di tenerla in suo potere, sforzandosi di vederla come un meccanismo. Era infatti capace di descrivere l'allegria, la collera, le tristezze della moglie con una precisione «clinica», e addirittura la chiamava «il coso», abitudine che produceva un effetto bizzarro. «Allora il coso si è messo a ridere». La chiamava così appunto perché in ogni suo atto era una reazione prevedibile e determinata. Per esempio le raccontava una storiella banale, e quando lei (il coso) si metteva a ridere, ciò indicava la sua (del coso) natura da robot, completamente «condizionata». (Questo paziente vedeva la propria moglie in modo molto simile a certe teorie psichiatriche che spiegano tutte le azioni umane). In principio mi sorprendeva, e mi rallegrava, la sua apparente capacità di dissentire, di confutare le cose che dicevo anziché essere sempre d'accordo con me. Mi pareva che ciò indicasse da parte sua una autonomia mentale maggiore di quanto egli stesso riteneva di possedere, e anche un certo coraggio nel manifestarla. Ma ben presto risultò chiaramente che questa apparente autonomia nei miei riguardi era solo l'effetto della sua manovra segreta. Egli non mi considerava come un essere umano, una persona viva con il suo io, ma come una specie di macchina elaboratóre nella quale egli introduceva dei dati, e che, dopo una rapida elaborazione di essi, gli restituiva una interpretazione verbale. Grazie a questo modo segreto di vedermi come una cosa, egli riusciva a sembrare una persona. Ma un rapporto da persona a persona, vissuto come tale, questo non lo poteva sopportare. Persone di questo genere fanno comunemente dei sogni, in cui trova espressione l'una o l'altra forma dei terrori suddetti. Non si tratta di varianti della paura di essere mangiati, che ricorre nei sogni delle persone ontologicamente sicure. Essere mangiati non significa necessariamente perdere la propria identità. Giona era sempre se stesso anche nel ventre della balena. Ben pochi dei nostri incubi arrivano a provocare l'ansia per la perdita dell'identità, di solito perché la maggior parte di noi, anche in sogno, continua a trovarsi di fronte agli stessi pericoli che si possono incontrare come persone, che potranno anche essere aggredite o mutilate, ma il cui nucleo esistenziale di fondo resta al sicuro. Nel classico incubo ci si sveglia in preda al terrore, ma questo terrore non è il timore di perdere il proprio io. Per esempio, un paziente sogna che un enorme maiale gli sta seduto sul petto e sta per soffocarlo, e si sveglia spaventato. Ma una minaccia di soffocamento è meglio del pericolo di dissoluzione di tutto il proprio essere. A volte si ha, nei sogni dei pazienti, un metodo di difesa che consiste nel trasformare in una cosa non se stessi, ma l'immagine materna, o l'immagine del seno. Un paziente faceva un sogno ricorrente in cui in un angolo della stanza si formava un piccolo triangolo nero, che diventava sempre più grande e sembrava volesse inghiottirlo; a questo punto il paziente si svegliava in preda al terrore. Si trattava di un giovane psicotico, che ha abitato per diversi mesi in casa mia, e che perciò conoscevo piuttosto bene; c'era una sola situazione, per quello che io potevo giudicare, in cui egli si sentiva libero di «lasciarsi andare» senza provare la paura di non potersi più riprendere, ed era quando ascoltava della musica jazz. Il fatto che anche nei sogni l'immagine del seno debba essere spersonalizzata è una misura del pericolo potenziale che questa immagine rappresenta per l'io, presumibilmente a causa delle spaventose personalizzazioni che ne sono state fatte in origine, e del successivo fallimento di un normale processo di spersonalizzazione. Medard Boss (1957) cita diversi esempi di sogni che preannunciano ima psicosi. In uno di essi la paziente è inghiottita dal fuoco: Una donna di meno di trent'anni, in perfetta salute, sognò di essere in fiamme. Tutt'intorno a lei, che era il fuoco, si stava formando una crosta di lava che diventava sempre più grande. Un po' dall'esterno e un po' dall'interno del suo stesso corpo poteva vedere come il fuoco venisse lentamente soffocato da questa crosta. Ad un tratto si trovava tutta all'esterno del fuoco, e freneticamente lo colpiva con un bastone, per rompere la crosta e far entrare un po' d'aria. Ma presto si stancò, e lentamente il fuoco (cioè lei stessa) si spense. Quattro giorni dopo questo sogno la donna entrò in un episodio schizofrenico acuto. Nei dettagli del sogno aveva previsto esattamente il decorso della sua psicosi. Prima si irrigidi, come se realmente fosse chiusa in una crosta. Dopo sei settimane cominciò a difendersi con tutte le sue forze contro l'estinzione del fuoco della sua vita, ma alla fine si spense del tutto, spiritualmente e mentalmente. Ormai da alcuni anni è simile a un cratere spento. In un altro esempio si ha la pietrificazione di altre persone, che preannunzia quella della stessa paziente: ... una ragazza di venticinque anni sognò che aveva preparato il pranzo per la sua famiglia di cinque persone. Dopo averlo portato in tavola chiamò i genitori, il fratello e le sorelle perché venissero a mangiare, ma nessuno rispose: le ritornò solo la sua voce come un'eco da una caverna profonda. Questo improvviso vuoto della casa le fece paura. Corse di sopra per cercare la famiglia. Nella prima stanza trovò le sue due sorelle sedute sui letti: ma nonostante i richiami impazienti, esse rimasero sedute rigidamente, in una posizione innaturale, senza risponderle, e quando si avvicinò per scuoterle si accorse che erano statue di marmo. Piena di orrore, la ragazza corse allora nella stanza della madre, ma anche questa era diventata pietra, e sedeva inerte in una poltrona guardando fissa nel vuoto. La paziente fugge allora nella stanza del padre e lo trova in piedi in mezzo alla stanza. Disperata gli corre incontro e, cercando protezione, gli getta le braccia attorno al collo; ma anche lui è di pietra, e nell'abbraccio diventa sabbia. La paziente si sveglia paralizzata dal terrore, e per diversi minuti non riesce a muoversi. Lo stesso orribile sogno si ripete poi altre quattro volte in pochi giorni. A quest'epoca la paziente era, in apparenza, il ritratto della salute fisica e mentale, tanto che i genitori la chiamavano il sole della famiglia. A dieci giorni di distanza dall'ultima ripetizione del sogno la ragazza entrò in una forma acuta di schizofrenia con gravi sintomi catatonici, cadendo in uno stato molto somigliante alla pietrificazione effettiva della sua famiglia, che aveva sognato. Nella sua vita di veglia era adesso condannata a un tipo di comportamento uguale a quello che, in sogno, aveva osservato in altre persone. La legge generale sembra essere questa: a un certo punto, ci si getta incontro agli stessi pericoli che più si temono, come per prevenirli. Così rinunziare alla propria autonomia diventa il mezzo di salvaguardarla in segreto, e fare il morto diventa il mezzo di conservare la vita (cfr. Obern- dorf, 1950). Trasformarsi in pietra diventa un modo per non essere fatto pietra da qualcun altro. «Sii duro!» ammoniva Nietzsche. Ma in un certo senso (che lo stesso Nietzsche, credo, non considerava) l'essere duro come pietra, e come essa morto, scongiura il rischio di essere trasformato in una cosa morta da un'altra persona. Comprendere totalmente se stessi (inghiottire se stessi) è una difesa contro il pericolo di essere risucchiati nel gorgo della comprensione di un'altra persona. Consumarsi nell'amore di se stessi previene la possibilità di essere consumati da un altro. Sembra anche che il metodo preferito per aggredire l'altro si basi sullo stesso principio di attacco che si ritiene implicito nel tentativo di rapporto da parte dell'altro. Così l'uomo che ha paura che la sua individualità venga sommersa, sfondata o congelata, tenterà spesso di sommergere, travolgere o distruggere l'individualità dell'altra persona. Questo processo implica un circolo vizioso: più si tenta di conservare la propria autonomia e identità annullando la specifica individualità dell'altro, più si sente la necessità di continuare a farlo, perché ad ogni negazione dell'entità ontologica dell'altro la sicurezza della propria diminuisce un po', la minaccia che l'altro costituisce per l'io si fa più forte, e quindi si deve negarla ancor più disperatamente. In questa forma di lesione della propria autonomia si hanno due fallimenti: l'incapacità di mantenere il senso di sé come persona quando si è con un altro, e l'incapacità di mantenere questo senso quando si è soli, il fallimento del senso del proprio essere quando non si è in presenza di altre persone, l'incapacità di essere se stessi da soli. Com'era solito dire James, il paziente già presentato: «Sono gli altri che mi forniscono la mia esistenza». Questo sembra in diretta contraddizione col suo timore che gli altri gliela togliessero, ma per quanto contraddittorio o assurdo possa sembrare, entrambi gli atteggiamenti esistevano in lui, e di fatto sono caratteristici di questo tipo di persona. La capacità di sentirsi autonomo significa che si è riusciti a rendersi conto di sé come persona separata da tutti gli altri. Per quanto profondamente io sia legato, nella gioia o nel dolore, a un'altra persona, questa non è me, né io sono lei. Per quanto ci si possa sentire soli o tristi, si può continuare a esistere anche da soli. Il fatto che l'altra persona, nella sua realtà, non sia me, sussiste accanto all'altro fatto, ugualmente reale, che il mio attaccamento per lei fa parte di me, così che se muore o parte l'attaccamento persiste anche senza di lei. Ma io non posso morire la morte di un altro in sua vece, né lui può morire la mia. Anzi, come nota Sartre a proposito di questo pensiero di Heidegger, lui non può amare in vece mia, o prendere le mie decisioni, e ugualmente io non posso fare queste cose per lui. In breve, lui non può essere me e io non posso essere lui. Ma se l'individuo non si sente autonomo, allora egli non può sentire in modo normale né la sua separazione né la sua relazione con l'altro. La mancanza del senso di autonomia implica che egli senta il proprio essere avvolto nell'altro, o viceversa, in modo da trasgredire la realtà della struttura dei rapporti umani. Significa che in luogo di un senso di rapporto e di attaccamento nei confronti dell'altro, fondato su di una genuina reciprocità, si ha la sensazione di essere in uno stato di dipendenza ontologica, cioè che si dipende dall'altro per esistere, e che il totale distacco, il completo isolamento è la sola alternativa ad un attaccamento da ostrica, o da vampiro, in cui il sangue e la vita dell'altro sono necessari per la propria sopravvivenza, ma al tempo stesso la mettono in pericolo. Perciò, anziché la separazione e il rapporto, i due poli sono il completo isolamento e la completa fusione dell'identità. L'individuo è in perpetua oscillazione fra questi estremi, entrambi ugualmente impossibili, e si trova, alla fine, a vivere non diversamente da quei giocattoli meccanici provvisti di un tropismo positivo che li spinge verso uno stimolo, fino a raggiungere un dato punto; al che un tropismo negativo, che hanno dentro, li dirige in senso opposto finché di nuovo il tropismo positivo non abbia ripreso il sopravvento, e così all'infinito. Gli altri erano, diceva James, indispensabili alla sua esistenza. Un altro paziente, vittima dello stesso dilemma di fondo, si comportava nel modo seguente. Per mesi interi restava isolato dal mondo, vivendo solitario chiuso in una stanza, nutrendosi a malapena, fantasticando; ma così facendo, a un certo punto cominciava a sentirsi morire dentro, diventava sempre più vuoto, e osservava «un impoverimento progressivo del mio modo di vivere». In questo esistere per proprio conto era implicita una grande quantità di orgoglio e di autostima; tuttavia, all'aggravarsi del suo stato di spersonalizzazione, finalmente riemergeva alla vita sociale e vi faceva una breve incursione, per avere «una piccola dose, non eccessiva» del suo prossimo. Era come l'alcolizzato che, dopo un periodo di astinenza, improvvisamente corre ad ubriacarsi; solo che nel suo caso l'assuefazione, della quale aveva vergogna e paura proprio come un alcolizzato o un tossicomane pentito, riguardava i suoi simili. Dopo un po' cominciava a sentirsi in pericolo e a temere di essere preso nella trappola dell'ambiente in cui era entrato, e si ritirava di nuovo nel suo isolamento, in una confusione di paure, sospetti, disperazione e vergogna. Alcuni dei punti precedenti trovano un'illustrazione nei due casi che seguono. Caso 1. L'ansia del sentirsi soli. Il disturbo accusato dalla signora R. era un timore di stare per la strada (agorafobia). Ad un esame più attento risultò che l'ansietà nasceva quando cominciava a sentirsi da sola, per strada o in qualunque altro luogo. Era capace di cavarsela per conto suo, ma solo se non si sentiva completamente sola. La sua storia, in breve, era la seguente. Era figlia unica. Non era stata trascurata, né c'era stata ostilità visibile nella famiglia. Tuttavia era sua impressione che i genitori fossero sempre troppo occupati l'uno dell'altro per accorgersi di lei. Crescendo, desiderava di poter riempire questo vuoto nella sua vita, ma non era mai riuscita ad essere autosufficiente, né a sentirsi partecipe completamente del suo mondo personale, il suo desiderio più forte era sempre quello di poter essere importante per qualcun altro. Doveva sempre esserci qualcun altro. Voleva essere amata e ammirata, ma in mancanza di ciò, essere odiata era da preferirsi di molto all'essere ignorata. Insomma questa paziente voleva essere importante per qualcuno, e per qualunque motivo, come reazione al triste ricordo che aveva di sé come bambina che non contava realmente agli occhi dei genitori, i quali non provavano per lei né amore né odio, né orgoglio né vergogna. In conseguenza, per quanto si guardasse nello specchio non era mai riuscita a convincersi di essere qualcuno, né era mai riuscita a non provare paura tutte le volte che si trovava sola. Comunque crebbe, diventò molto piacente, e a diciassette anni sposò il primo uomo che se ne accorse veramente. I suoi genitori, in un modo che a lei sembrava caratteristico, non si erano mai accorti, fino all'annuncio del fidanzamento, che la loro figlia fosse mai stata turbata per qualche cosa. Ora, al calore delle attenzioni del marito, si sentiva trionfante e fiduciosa. Ma il marito era un ufficiale dell'esercito e poco dopo venne trasferito all'estero; la ragazza non potè seguirlo. A questa separazione segui uno stato di panico grave. È da notare che la reazione all'assenza del marito non fu una depressione o uno stato di tristezza, con nostalgia o dolore per la sua lontananza. Fu il panico, perché (vorrei suggerire) in lei si era dissolto qualcosa la cui esistenza era dovuta alla presenza del marito e alle sue attenzioni continue, come un fiore che avvizzisce mancando la pioggia. Tuttavia arrivò un aiuto, sotto forma di una malattia improvvisa della madre. La paziente ricevette un appello urgente di aiuto da parte di suo padre, che le chiedeva di venire a casa per curarla. Durante tutto l'anno della malattia della madre la paziente, per usare le sue stesse parole, non era mai stata tanto se stessa. Era diventata il centro della casa. Non vi fu più traccia di panico fino a quando, alla morte della madre, cominciò a preoccuparla l'idea di lasciare quel luogo, dove finalmente contava tanto, per raggiungere il marito. L'esperienza dell'anno trascorso le faceva sentire, per la prima volta, di essere finalmente la figlia dei suoi genitori, e al confronto essere la moglie di suo marito le pareva superfluo. È ancora da notare l'assenza di dolore per la morte della madre. Fu in questo periodo che cominciò a considerare la possibilità di restare sola al mondo. Sua madre era morta; poi sarebbe stata la volta di suo padre, e forse di suo marito; «dopo questo, più nulla». Quest'idea non la deprimeva: la spaventava. Raggiunse il marito all'estero, e per alcuni anni condusse una vita gaia. Ma le attenzioni di lui diminuirono, e allora incominciò a sentirsi inquieta e insoddisfatta; il matrimonio finì in una separazione, e la paziente tornò a Londra a vivere col padre. Mentre viveva con lui diventò l'amante e la modella di uno scultore, e viveva cosi da diversi anni quando, a ventotto anni di età, venne da me. Ecco come si esprimeva parlando di come si trovava per la strada: «Per la strada la gente va e viene pensando ai propri affari. Non si incontra mai qualcuno che ti riconosca, oppure è solo un cenno col capo, o al massimo un minuto di conversazione. Nessuno sa chi sei. Tutti sono preoccupati solo di se stessi; nessuno si cura di te». Qui citava casi di persone che si sentono male per la strada fra l'indifferenza di tutti: «A nessuno importa un bel niente». Era in questo atteggiamento mentale che si veniva formando l'ansietà. Questa era causata dal trovarsi per la strada da sola, o meglio dal sentirsi lasciata a se stessa. Se usciva con qualcuno o se incontrava qualcuno che la conoscesse veramente, non provava nessuna ansietà. Nell'appartamento del padre era spesso sola, ma allora era diverso. Li non si sentiva mai veramente lasciata a se stessa. Si preparava da mangiare, faceva i letti, lavava i piatti, e faceva in modo che queste occupazioni durassero il più a lungo possibile. Il pomeriggio era più noioso, ma neppure questo le pesava molto, perché «tutto è cosi familiare»: c'era la poltrona del padre, le sue pipe, al muro un ritratto della madre, che la guardava, ed era come se tutti questi oggetti familiari illuminassero la casa con la presenza delle persone che li possedevano o che li avevano usati per tutta la vita. Cosi, sebbene da sola, a casa poteva sempre, con mezzi magici, stare con qualcuno. Ma nel rumore e nel movimento anonimo della strada si rompeva l'incantesimo. Applicando grossolanamente a questa paziente la teoria psicoanalitica classica dell'isteria, o quella che si crede essere tale, si potrebbe descriverla come una persona con un attaccamento libidico inconscio per il padre, e di conseguenza con senso di colpa inconscio e con un bisogno, o timore altrettanto inconscio, di punizione. La sua incapacità di stabilire relazioni affettive durevoli con persone diverse dal padre parrebbe confortare questa ipotesi, e cosi la sua decisione di vivergli accanto pensando a lui per quasi tutta la giornata prendendo per cosi dire il posto di sua madre. La devozione verso la madre durante la malattia potrebbe essere, in parte, la conseguenza del senso di colpa provato per l'inconscia ambivalenza nei suoi confronti; e l'ansia alla sua morte non sarebbe altro che ansia per l'avverarsi di un desiderio inconscio. E cosi di seguito. Ma la questione di fondo, il problema centrale della vita di questa paziente non consiste nell'essere scoperta nel suo «inconscio», perché è già lì scoperto e visibile, sia per lei che per noi (sebbene non si debba credere che non vi siano molte cose che la paziente ignora su se stessa). Il punto centrale di tutta la sua vita è la sua mancanza di autonomia ontologica. Se le manca la presenza fisica di una persona nota, o se non riesce a evocare con l'immaginazione questa presenza, le sfugge il senso della sua identità. A questo venir meno del suo essere è dovuto il panico: per esistere, ha bisogno di qualcuno che creda nella sua esistenza. Come appare necessario che il suo amante debba essere uno scultore, e lei la sua modella! E come appare inevitabile, data questa premessa fondamentale della sua esistenza, che l'ansietà sopraggiunga non appena questa sua esistenza non sia riconosciuta da nessuno. Per lei esse est percipi, essere vista, cioè, non semplicemente come una passante anonima o come una conoscente casuale. Anzi era proprio questo modo di essere percepita a pietrificarla, perché essere vista come una persona a- nonima, come una senza importanza, o come una cosa, equivaleva a non essere nessuno in particolare. Ella non era che ciò che gli altri vedevano, e se a un dato momento non c'era nessuno, doveva mettersi a inventare qualcuno - di volta in volta padre, madre, marito, amante - per il quale potesse sentire di contare qualcosa, per il quale potesse essere una persona; e si immaginava di essere in sua presenza. Se questa persona, da cui dipendeva il suo essere, moriva o se ne andava, il sentimento provato non era il dolore, ma il terrore e il panico. Non è possibile trasporre nell'«inconscio» il problema centrale di questa paziente. Se si scoprisse in lei, per esempio, la fantasia inconscia di essere una prostituta, ciò non spiegherebbe l'ansietà provata nel passeggiare, né la preoccupazione per le altre passanti che si sentono male e che nessuno aiuta a rialzarsi. Al contrario, la fantasia inconscia si deve spiegare e comprendere sulla base della questione di fondo riguardante il suo essere se stessa. Il suo timore di trovarsi da sola non è una «difesa» contro fantasie incestuose o di masturbazione. In realtà la paziente aveva fantasie di incesto; ma queste erano una difesa contro la paura di essere sola, così come era una difesa tutta la sua «fissazione» all'idea di essere una figlia: tutti mezzi usati per vincere l'ansietà di trovarsi con se stessa. Le fantasie inconscie di questa paziente avrebbero un significato totalmente diverso se la sua condizione esistenziale di fondo le avesse permesso di avere dentro di sé un punto di partenza, dal quale procedere alla ricerca della soddisfazione. Ma cosi come stavano le cose, la sua vita sessuale e le sue fantasie costituivano uno sforzo, non già per ottenere la soddisfazione, ma anzitutto per cercare la sicurezza ontologica. Nell'amore trovava un'illusione di questa sicurezza, e sulla base dell'illusione la soddisfazione era possibile. Sarebbe un errore grave definire narcisistica questa paziente, in una corretta accezione del termine, perché ella non era capace di innamorarsi del suo riflesso. Cosi sarebbe un errore riportare il suo problema a questioni di fasi di sviluppo psicosessuale, orale, anale e genitale, perché per lei la sessualità era come un appiglio al quale aggrapparsi. Non era frigida, poteva trovare soddisfazione fisica nell'orgasmo, se in quel momento si sentiva sicura nel senso ontologico primario. Nel rapporto con l'uomo che l'amava (ed ella possedeva la capacità di credere di essere amata da un altro) trovava forse i suoi momenti migliori. Ma erano di breve durata. Non sapeva restare sola, né lasciare che il suo amante stesse da solo quando era con lei. Il bisogno di essere notata potrebbe indurre ad applicare alla paziente un altro cliché, quello dell'esibizionismo. Ma ancora una volta, il termine è valido solo se inteso in senso esistenziale, e in questo senso troviamo - e riprenderemo l'argomento — che la paziente si mostrava sì, ma non si dava: si esibiva nell'atto stesso con cui si inibiva. Perciò era e si sentiva sempre sola, per quanto, in superficie, la sua difficoltà non fosse di trovarsi insieme con gli altri, che anzi il problema era meno evidente quando riusciva a stare a lungo in compagnia degli altri. Ma è chiaro che il suo modo di comprendere l'esistenza autonoma degli altri era altrettanto tenue e imperfetto quanto la sua capacità di credere nella sua propria autonomia. Infatti gli altri cessavano di esistere non appena non erano in sua presenza. E l'orgasmo era un mezzo per possedere se stessa tenendo fra le braccia l'uomo che la possedeva: ma non poteva essere se stessa da sola, e quindi non poteva essere se stessa comunque. Caso 2. Uno dei più curiosi fenomeni nel campo della personalità, noto e osservato da secoli pur non avendo mai ricevuto una spiegazione soddisfacente, si ha quando a un individuo pare di essere il veicolo di una personalità non sua. Appare cioè che sia la personalità di un altro a «possederlo», e a trovare espressione attraverso le sue parole ed i suoi atti, mentre la sua propria sembra temporaneamente perduta o assente. Il fenomeno si verifica con maggiore o minore gravità, ma si tratta sempre dello stesso processo fondamentale, che può andare dalla semplice, banale constatazione che il tale «ha preso da suo padre», o che nella tal altra «salta fuori il caratterino di sua madre», fino all'estremo turbamento della persona che si trova a dover assumere le caratteristiche di una personalità magari odiata, o che è completamente estranea alla sua. Il fenomeno, quando si presenta non desiderato e con caratteristiche di coazione, è uno dei più importanti fattori nel determinare delle rotture del senso della propria identità. Il timore del suo verificarsi è uno dei fattori del timore di annientamento e di implosione. L'individuo può trovarsi a temere di provare simpatia per qualcuno, perché teme di essere costretto a diventare come lui. Come tenterò di mostrare più avanti, questo è uno dei motivi dell'isolamento schizofrenico. Il caso che segue illustra fino a che punto, nel risucchio di una subidentità estranea, possa modificarsi l'io e la personalità di un individuo: tanto profondamente da rendere possibile la perdita della propria identità. La signora D. era una donna di quarantanni, che inizialmente lamentava una paura vaga, ma intensa. Diceva di aver paura di tutto, «anche dell'aria», di provare continuamente un senso di insoddisfazione, di avere inspiegabili accessi di collera contro il marito, e soprattutto di «mancare del senso di responsabilità». Poi disse che il suo timore era «come se qualcuno cercasse di salire dentro di me, e di uscire fuori». Aveva anche paura di essere come sua madre, che odiava. Ciò che chiamava «irresponsabilità» era una sensazione di perplessità e di confusione, che attribuiva al fatto di non essere mai riuscita a far niente che facesse piacere ai suoi genitori. Faceva una cosa e le dicevano che era male, allora ne faceva un'altra e le dicevano ancora che era male: non riusciva mai a sapere «cosa volessero da me». Rimproverava i genitori soprattutto per questo, per non averle mai dato modo di scoprire chi fosse, o che cosa dovesse diventare. Non poteva essere né cattiva né buona in modo stabile e «responsabile», perché i suoi genitori erano, almeno così le sembrava, completamente imprevedibili e instabili nelle loro espressioni di amore e di odio, di approvazione e di rimprovero. Retrospettivamente concludeva che dovevano odiarla, ma a quel tempo, ora diceva, era troppo confusa e ansiosa e preoccupata di indovinare cosa si volesse da lei per riuscire nonché ad amarli, anche ad odiarli. Ora diceva di cercare solo il «benessere», e si aspettava da me una parola che le indicasse la strada da seguire; e perciò le riusciva insopportabile il mio atteggiamento non-direttivo, che le appariva come una chiara ripetizione dell'atteggiamento di suo padre: «Non fare domande e non ti diranno bugie». Ebbe un breve periodo di pensiero coatto, durante il quale si trovava costretta a porsi domande di questo genere: «A cosa serve questo?» oppure «Perché c'è quest'altro?» e a darsi da sola la risposta. Interpretava il fenomeno come un tentativo di cercare il benessere nei suoi stessi pensieri, visto che non poteva ottenerlo da nessuno. Poi ebbe un periodo di grave depressione, e cominciò a lamentarsi dei suoi sentimenti dicendo che erano infantili. Parlava a lungo del fatto che compiangeva tanto se stessa. Ma a me sembrava che in realtà non compiangesse il suo vero io. Era molto più simile a una madre che si lamenta di un bambino diffìcile. E infatti pareva proprio che fosse sua madre a «venir fuori» da lei rimproverandola di essere troppo infantile, e non soltanto con questi rimproveri che faceva a se stessa, ma anche in altri modi: per e- sempio, proprio come sua madre, faceva continue scenate al marito e al figlio; come sua madre, odiava tutti; e come sua madre, piangeva sempre Cosi la vita era per lei un tormento perché non poteva mai essere se stessa ma invece era costretta ad essere sempre sua madre. Ma sapeva che quando si sentiva sola, smarrita, impaurita e confusa, allora era più se stessa; e sapeva anche che era in gioco la sua complicità quando andava in collera, faceva scene, piangeva e si lamentava, perché non appena si metteva in quello stato (cioè non appena diventava sua madre) non sentiva più la paura (pagando ciò, beninteso, col non essere più se stessa). Tuttavia la manovra la opprimeva, e quando la tempesta era passata le restava addosso un senso di futilità (per non essere stata se stessa), e sentiva odio per la persona che era stata (la madre), e per la propria doppiezza. Divenuta consapevole di questo modo sbagliato di vincere l'ansietà cui si trovava esposta quando era se stessa, la paziente dovette ora decidere se i tentativi di evitare l'ansietà evitando di essere se stessa non fossero una cura peggiore della malattia. Le frustrazioni provate con me, che mi attirarono un odio violento, non si potevano spiegare come frustrazione delle pulsioni libidiche o aggressive del transfert, ma costituivano piuttosto una frustrazione esistenziale, originata dal fatto che io, negandole il «benessere» che voleva da me, le imponevo invece di decidere per conto suo quale persona volesse diventare. La sua impressione che le fosse stato negato un diritto alla nascita, e che i suoi genitori non avessero assolto la loro responsabilità, che era di fornirle una definizione di sé di cui potesse valersi come punto di partenza della sua vita; questa impressione veniva intensificata dal mio rifiuto di darle il «benessere». Ma solo in questo modo era possibile creare la situazione in cui la paziente potesse assumersi questa responsabilità. In questo senso, perciò, il problema psicoterapeutico che si poneva era di fare appello, per usare un'espressione di Jaspers, alla libertà del paziente. Buona parte dell'abilità del terapeuta consiste nel fare ciò efficacemente.
|