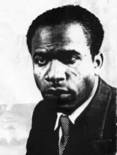
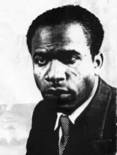
1.
Tra le icone (di sinistra) del Novecento, Frantz Fanon meriterebbe una fama pari a quella di Ernesto Che Guevara. Medico come questi, e per di più psichiatra antesignano dell’antipsichiatria, Fanon sceglie ad un certo punto della sua vita, già fervida da un punto di vista intellettuale, di fare il rivoluzionario di professione. Originario delle Antille, cittadino francese, entra a fare parte del Fronte Nazionale di Liberazione algerino, assumendo un ruolo di leader a tal punto carismatico che, alla sua morte, riceverà l’onore di un funerale pubblico, al quale, nonostante la guerra in corso, partecipa una folla imponente e commossa.
Coerente con le sue analisi del colonialismo, Fanon abbandona la professione medica e depone la penna per darsi alla lotta. Per quanto breve, la sua stagione intellettuale è, però, intensa. Amico dell’intellighenzia di sinistra francese, egli pubblica due libri (il Negro e l’Altro e I dannati della Terra) che diventeranno il manifesto del terzomondismo e dell’anticolonialismo.
A differenza di Che Guevara, egli non muore sul campo, ma in un letto di ospedale a New York di leucemia. Si è battuto però sino all’ultimo per la causa degli oppressi.
La rimozione di Fanon dall’immaginario collettivo, laddove egli sopravvive solo presso alcune frange di terzomondisti, e il suo non essere divenuto un mito non vanno solo ricondotti all’ondata di conservatorimo che ha (prematuramente) seppellito la grande stagione culturale degli anni Sessanta e Settanta. Il problema, se lo si vuole affrontare senza remore, è che Fanon è un negro orgoglioso, riottoso, suscettibile, consapevole delle sue doti intellettuali, che, pur avendo assimilato la cultura bianca, non la ritiene affatto espressione di una civiltà superiore, e il cui sguardo esprime la fredda rabbia del rappresentante dei dannati della terra e l’assorto smarrimento di chi non si adatta a vivere nel mondo così com’è.
Anima travagliata, le cui radici affondano nell’humus di un’originaria cultura comunitaristica e la cui formazione intellettuale, passando attraverso Marx, accede infine all’esistenzialismo umanitaristico sartiano, Fanon, coltivando un’emarginazione inesorabilmente legata al suo essere negro, è giunto ad uno stato di indignazione critica che, in più momenti, ha sfiorato la paranoia.
Nella prefazione al saggio, Francis Jeanson, che pure non cela la sua ammirazione per l’intellettuale rigoroso e il rivoluzionario coerente, ricorda un episodio singolare. Fanon nel 1952 gli invia in lettura il manoscritto de Il negro e l’Altro. Avendolo trovato estremamente interessante, egli commette l’errore di dirglielo, ricevendo in risposta un duro giudizio (come se avesse pensato: “Mica male, per un negro”) e la minaccia di troncare repentinamente una relazione appena avviatasi. Jeanson reagisce al sospetto con indignazione e Fanon capisce di avere sbagliato.
All’epoca, egli è di fatto un essere letteralmente “scorticato” dalla rabbia e dall’indignazione per il pregiudizio contro i popoli di colore. La militanza nelle file del Fronte di Liberazione nazionale lo acquieta e lo tempra, ma non fino al punto di estinguere una diffidenza radicale nei confronti della civiltà occidentale. Ricoverato presso l’ospedale di New York in un estremo tentativo di salvarlo, egli avanza il dubbio che i medici complottino per imbiancargli il sangue.
Intrattabile compagno, lo definisce con dolcezza Jeanson. Un carattere fiero, indomabile, suscettibile e reattivo al punto che un critico, dopo la comparsa del libro, non esita a scrivere un giudizio terribile: “Il signor Fanon ha la malattia di essere nero come si ha la rosolia... Ha i nervi a fior di pelle (nera) e il sangue piuttosto bollente... Il suo libro è probabilmente un cattivo libro e la sua nevrosi certamente una pessima nevrosi... E poiché è medico, che guarisca se stesso!”
Il giudizio è totalmente sbagliato. Appassionato e radicale, il libro di Fanon è un tentativo di interpretare la psicopatologia del negro che viene a contatto con la civiltà bianca al fine di risolverla. Il problema è che Fanon, pur consapevole dell’esistenza di quella psicopatologia, non riesce ad analizzarla prescindendo dall’oggettività del pregiudizio che essa riflette, vale a dire dal contesto socioculturale nel quale si realizza.
Egli scrive nell’Introduzione: “L’analisi che intraprendiamo è psicologica. Rimane evidente tuttavia che per noi la vera disalienazione del negro implica una brusca presa di coscienza delle realtà economiche e sociali.
Se vi è un complesso d’inferiorità, questo è conseguenza di un duplice processo; in un primo tempo economico; d’interiorizzazione o, meglio, di epidermizzazione di questa inferiorità, in un secondo.
Reagendo contro la tendenza costituzionalista della fine del XIX secolo, Freud, mediante la psicoanalisi, chiese che si tenesse conto del fattore individuale. A una tesi filogenetica, egli sostituì la prospettiva ontogenetica. Si vedrà che l’alienazione del nero non è una questione individuale. A lato della filogenesi e dell’ontogenesi, c’è la sociogenesi.” (p. 37)
Fin dall’inizio, dunque, Fanon sancisce che la soggettività è una dimensione all’interno della quale si danno processi complessi che, però, sono incomprensibili se, oltre a tenere conto delle dinamiche soggettive, non si riesce a risalire alle matrici esperienziali e storico-culturali che li generano. Con ciò, senza saperlo, egli fa proprio il presupposto dell’antipsichiatria, almeno dell’antipsichiatria più sottile – quella di Laing e di Esterson -, la quale non ha mai negato la realtà delle esperienze psicopatologiche, bensì solo la sterilità di iscriverle in una griglia nosografica. Certo, quelle esperienze, benché diverse le une dalle altre, presentano degli aspetti sintomatologici comuni che può consentire di ricondurle entro categorie. Ma, stabilito che i fenomeni psicopatologici sembrano realizzarsi entro poche forme invarianti, la loro analisi diventa significativa solo se si è in grado di capire come e perché, vale a dire in forza di quali leggi essi, nonostante la diversità dei tragitti di esperienza soggettivi, finiscono con l’imboccare una via finale comune.
Se questo modo di vedere può creare qualche problema laddove le esperienze psicopatologiche sembrano immediatamente poco correlabili alla situazione esistenziale e al contesto ambientale (com’è per esempio il caso di un delirio persecutorio acuto), è difficile negare la sua pertinenza laddove il disagio riconosce un fattore comune, che, nel caso specifico, è il colore della pelle. “Il bianco – si legge a pag. 36 – è chiuso nella sua bianchità. Il negro nella sua negrità.” Un’affermazione solo apparentemente ovvia, perché essa implica effetti molto diversi. Chiuso nella sua bianchità, l’uomo occidentale può presumere di appartenere ad una razza e ad una civiltà superiore e di essere lui stesso, nella sua singolarità, superiore ad ogni uomo di pelle scura. Il negro viceversa rimane intrappolato nella sua negrità e giunge a viverla come un segno visibile della sua inferiorità. Fa proprio il pregiudizio del bianco, dà ad esso credito e si definisce sulla sua base.
Per ciò, l’intento di Fanon è “quello di liberare l’uomo di colore da se stesso” (p. 35), vale a dire dall’interiorizzazione del pregiudizio di superiorità del bianco che diventa, nel suo inconscio, il metro di misura del suo essere.
2.
Dopo la stagione dell’antipsichiatria, e la denuncia del codice normativo borghese come strumento di alienazione e di discriminazione, l’approccio di Fanon alla psicopatologia può apparire scontato. Ma non è così. Primo, perché il libro di Fanon è del 1952, allorché la psichiatria manicomiale è in auge e si è avviata da poco la “rivoluzione” psicofarmacologica. Secondo, perché quella stagione è tramontata senza lasciare traccia nell’ideologia e nella pratica psichiatrica. Tornare a Fanon è un modo per rivitalizzarla, e si vedrà ulteriormente in che senso specifico.
Intanto c’è da considerare che Fanon mantiene costantemente, in rapporto alla psicopatologia, un orientamento dialettico. Egli scrive: “La struttura nevrotica di un individuo [è] l’elaborazione, la formazione, l’esplosione nell’Io di conflitti provenienti, da una parte, dall’ambiente, dall’altra parte dal modo affatto personale con cui questo individuo reagisce a quelle influenze.” (p 104) E’ evidente che Fanon pensa che, senza queste influenze, non si creerebbero i presupposti del disagio, vale a dire non si produrrebbero conflitti psicodinamici. Al tempo stesso, egli giustamente ritiene che quei presupposti intanto divengono patogeni in quanto il soggetto, cercando di affrontare, consciamente e inconsciamente, i problemi che essi pongono, adottarimedi che sono peggiori del male, e lo precipitano nella spirale dei conflitti psicodinamici.
Nel caso del negro, il pregiudizio bianco, una volta interiorizzato, dà luogo ad una percezione sostanzialmente negativa, inadeguata e difettosa del proprio essere (ovviamente al di là del colore della pelle). In conseguenza di questo egli tenta di fare proprio il modello di normalità implicito in quel pregiudizio e di assimilarsi ad esso: in pratica, tenta di “sbiancarsi l’anima” assumendo una maschera che mortifica la sua cultura e lo rende un essere pateticamente anelante – dal livello del linguaggio a quello del comportamento – a divenire altro da sé. L’effetto di questa strategia è quella che Durkheim avrebbe definito anomia: una condizione ambigua per cui il negro finisce per non essere né carne né pesce.
Da questa analisi, si sarebbe indotti a pensare che Fanon proponga come soluzione del problema il rimanere, da parte del negro, orgogliosamente agganciato alla sua cultura, alla sua identità, alle sue tradizioni, e di contrapporre la sua umanità, plasmata da una lunga consuetudine comunitaristica, alla disumanità del bianco, chiuso nel suo individualismo egoista, nel suo narcisismo e nella sua arrogante pretesa di superiorità.
Nonostante il suo radicalismo politico, Fanon invece è avverso ad ogni guerra di civiltà, vale a dire al contrapporre alla pretesa superiorità dell’una quella dell’altra. Egli scrive: “Non ho il diritto, io uomo di colore, di ricercare in che cosa la mia razza è superiore o inferiore ad un’altra.
Non ho il diritto, io uomo di colore, di augurare che nel bianco si cristallizzi una colpevolezza rispetto al passato della mia razza.
Non ho il diritto, io uomo di colore, di preoccuparmi dei mezzi che mi permetterebbero di pestare la fierezza dell’antico padrone.
Non ho il diritto né il dovere di esigere riparazione per i miei antenati addomesticati.
Non esiste missione negra; non c’è fardello bianco...
No, non ho il diritto di venire a gridare il mio odio al bianco. Non ho il dovere di mormorare la mia riconoscenza al bianco...
La mia vita non deve essere consacrata a fare il bilancio dei valori negri. Non esiste mondo bianco, non esiste etica bianca e neppure intelligenza bianca. Da una parte e dall’altra del mondo ci sono uomini che cercano.” (pp. 239-240)
In breve, se, sul piano della decolonizzazione, Fanon ritiene che il conflitto e la lotta armata siano inevitabili (ragion per cui ha scelto di essere un rivoluzionario), nondimeno, al di là del ristabilirsi di un rapporto di pari dignità politica tra i vari paesi, la soluzione che propone per i problemi del mondo è di tipo umanitaristico. Si tratta in breve di riconoscere che l’uomo è uomo sotto tutte le latitudini, quale che sia il colore della pelle e la cultura cui appartiene, e che solo questo riconoscimento può portare l’umanità fuori dalla spirale dell’oppressione dell’uomo sull’uomo. Egli scrive: “Io, uomo di colore, non voglio che una cosa: che mai lo strumento domini l’uomo. Che cessi per sempre l’asservimento dell’uomo da parte dell’uomo. Vale a dire di me da parte di un altro. Che mi sia permesso di scoprire e di volere l’uomo dovunque si trovi.
Il negro non esiste. Non più del bianco.
Tutt’e due debbono allontanarsi dalle strade inumane che furono quelle dei rispettivi antenati, finché nasca un’autentica comunicazione. Prima di impegnarsi nel senso positivo, la libertà deve fare uno sforzo di disalienazione...
Superiorità? Inferiorità?
Perché non cercare semplicemente di toccare l’Altro, di sentire l’Altro, di rivelare l’Altro?” (p. 242)
Fanon non è ingenuo al punto di pensare che le tradizioni culturali e la storia, con il suo pesante carico di violenze agite e subite, possano essere cancellate di colpo. Ritiene, però, che se ci si riconduce all’uomo in quanto tale e al suo incoercibile bisogno di riconoscere e di essere riconosciuto dall’Altro, il travaglio di parto di una nuova civiltà integrata possa essere alleviato. Una civiltà integrata, nella sua ottica, fa proprie le conquiste delle diverse culture e si affranca dall’alienazione che, sia pure in misura diversa, caratterizza ciascuna di esse.
L’attualità di questo messaggio non può essere minimizzata.
3.
Detto questo di Fanon, sento la necessità di riferire anche una serie di riflessioni che la sua opera mi ha suggerito nel corso degli anni. Il pensiero di Fanon è tutto incentrato sulla potenza suggestiva che la cultura bianca e il codice normativo su cui essa si fonda esercita sui paesi non occidentali: potenza che, come egli ha analizzato, può comportare conseguenze psicopatologiche laddove l’interiorizzazione di quel codice promuove un’impossibile o sconsigliabile adattamento.
Io ritengo che questo problema non sia però riconducibile solo al rapporto tra civiltà e culture. Esso infatti può realizzarsi anche all’interno di una cultura. Per quanto riguarda la nostra, la pressione del codice normativo estroverso sta esercitando sui soggetti introversi la stessa pressione e gli stessi effetti che la cultura bianca ha prodotto nei negri. Interiorizzando inesorabilmente tale codice, e assumendolo come misura del proprio essere, gli introversi sono sollecitati univocamente a sentirsi inadeguati, carenti, difettosi, anormali. La conseguenza dell’interiorizzazione è che essi o si ripiegano dentro di sé con un carico di frustrazione, di rancore per la natura che, avendo operato una scelta nociva, li destina a vivere nell’ombra e nell’infelicità, e di invidia nei confronti dei normali (associata anche ad un certo disprezzo per la loro superficialità), o tentano di indossare una maschera estroversa, con effetti solitamente poco positivi, se non addirittura patetici.
Se questo è vero, il pensiero di Fanon, negro e per di più introverso, può essere utilizzato anche in una prospettiva diversa rispetto a quella originaria, vale a dire nella prospettiva di affrontare qualunque problema di discriminazione e di squalifica dell’umano che discenda da un codice normativo univoco, quindi anche il problema dell’introversione. Non solo. In questa nuova prospettiva, occorrerà tenere conto anche della soluzione dialettica intravista da Fanon, che, applicata al problema in questione, postula la necessità di aprire sia la gabbia normativa in cui sono chiusi gli introversi sia quella in cui sono chiusi gli estroversi. In entrambi i casi, infatti, sia pure in misura e con conseguenze diverse, quella gabbia aliena l’uomo da se stesso.